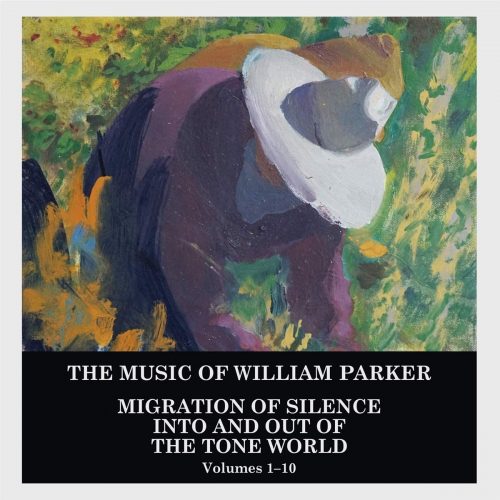WILLIAM PARKER – MIGRATION OF SILENCE INTO AND OUT OF THE TONE WORLD
Un box da dieci dischi per dieci ore di musica originale sarebbe un’impresa stupefacente per ogni artista; si rimane però un po’ meno sorpresi a veder attribuito l’immane sforzo a William Parker. Negli ultimi trent’anni, infatti, l’eclettico polistrumentista non ha mai smesso di inondare il mondo dei frutti della propria instancabile ispirazione, producendo una discografia sterminata tra collaborazioni, live e nuovi progetti sempre pronti a sbocciare. Per questo, di fronte ad una pubblicazione che per mole ed ambizione lascia di stucco, c’è almeno una certa familiarità d’approccio, una certa normalità nell’anomalia a saperla orchestrata dal musicista di New York. L’uscita di questo box set coincide tra l’altro con la pubblicazione della biografia su Parker ad opera di Cisco Bradley, un’opera che delinea il suo percorso da sodale di Cecil Taylor (non il primo musicista cui ha prestato il proprio talento, ma certamente quello che ha lanciato definitivamente Parker nel firmamento delle stelle del nuovo jazz) ad artista pienamente compiuto come bandleader, compositore, poeta e attivista. Migration of Silence Into and Out of the Tone World, insomma, arriva da lontano ed è prima di tutto un’opera collaborativa scaturita dalla volontà di espressione collettiva di una delle figure più importanti del jazz senza confini di questi decenni. Come scrive Alan Scherstuhl nell’intervista sul New York Times: «In the world of improvised music, William Parker is foundational».
Eppure, anche in una carriera monumentale e variegata come quella di Parker che consta di centinaia di album tra collaborazioni e uscite come leader, Migration… colpisce innanzitutto per il suo carattere prismatico. E non potrebbe essere altrimenti: i dieci dischi che compongono il lavoro sono stati registrati in momenti distinti tra il 2018 e il 2020 con formazioni profondamente differenti l’una dall’altra per numero di elementi, strumentazione, e scopi – nonostante siano tutti pensati espressamente come parte di un corpus unico. Lo stesso fatto che ogni disco presenti un titolo individuale suggerisce l’idea che ciascuno di questi sia in realtà considerabile come un full-length compiuto in sé, a prescindere dalla propria collocazione nell’immenso box set.
Quindi, la domanda sorge spontanea: qual è il fil rouge che lega tutti e dieci i lavori, e che giustifica l’accorpamento di dieci album indipendenti in un’opera massiva come Migration of Silence Into and Out of the Tone World?
Una risposta è immediata: la poetica e l’estetica di William Parker rifulgono di una luce ancora più abbagliante presentando, tutte insieme, le diverse fonti culturali e musicali da cui l’artista attinge nell’atto creativo. Per questo, coerentemente con la sua carriera, l’opera è costellata di una pletora di brani che, senza alcun vincolo di minutaggio o struttura, esplorano tutte le varie sfaccettature e possibilità che il termine “avant-garde jazz” può suggerire, dalle propaggini più sperimentali del jazz vocale al free classicamente inteso, dal jazz pan-culturale alla third stream. Diversi stili e influenze possono anzi ritrovarsi all’interno di una stessa composizione, come nuclei interagenti i cui significati sono scritti dagli strumentisti lavorando per sottrazione e alternanza. Non è infatti raro che, all’interno dello stesso ensemble, venga affidato soltanto a un ristretto sottoinsieme di musicisti il ruolo di condurre la musica verso l’apice drammatico di cui sono capaci gli strumenti, per poi passare il testimone a una diversa combinazione che mantiene vitale l’esecuzione collettiva, senza disperdere l’energia e l’espressività accumulate in precedenza. Alcuni accorgimenti in particolare contribuiscono notevolmente a dare coesione nel contesto di pezzi che accettano la sfida di lunghe fasi di interplay svincolato da temi a fare da collante. Anche se Parker non suona quasi mai il contrabbasso nel corso dell’opera, la sua mano e la sua sensibilità si avvertono comunque nel ruolo subliminale e allo stesso tempo nevralgico che riveste lo strumento nelle composizioni: pur se dietro le quinte, la sua guida non manca mai di dare un appoggio (e talvolta, una direzione) costante e di guidare i vari passaggi e le transizioni tra gli stessi. Questo accorgimento è tanto più importante perché, contrariamente a quanto avviene di solito, i vari gruppi non possono trovare un appiglio sicuro e delle direttive unitarie seguendo il tempo musicale scandito dall’impianto ritmico. Le percussioni, eccezion fatta per le sezioni più rarefatte in cui prevalgono iterazioni ritmiche minime e ipnotiche, sembrano essere infatti sempre un passo più in là rispetto alle aspettative, con un’esecuzione estremamente fluida che pare proseguire considerando suggestioni umorali estemporanee piuttosto che indicazioni metronomiche. Così tutto l’assetto strumentale procede errante e ricchissimo su percorsi non lineari, risultando imprevedibile ma senza perdere la presa. Mexico (disco 6) contiene alcuni dei più fulgidi esempi di quanto scritto: ascoltare la title-track e Tilted Mirror per credere. Ci sono però alcune incarnazioni particolari di questa visione musicale che fanno capire la vastità degli influssi e degli stimoli messi in gioco da Parker.
Uno degli esempi più pittoreschi risiede in Lights in the Rain (disco 8), interamente dedicato al cinema italiano. Per l’occasione la formazione si arricchisce di cornetta e armonica, che si uniscono a piano ed oboe a creare quadretti splendidamente evocativi, di grande grazia formale; allo stesso tempo i musicisti si spingono in interazioni non convenzionali ed esplorazioni dello spazio sonoro per cercare di dare vita nei brani all’anima dei rispettivi registi. Ecco allora un Visconti colorato di una tragica dolcezza sempre in bilico sui nervi, un Fellini imbevuto di Dolce Vita, la familiarità colorata di inquietudine di De Sica, i grandi spazi di Leone, Antonioni con la sua meraviglia colma di dubbi. Moltissimi i riferimenti alle colonne sonore ad opera di Nino Rota, ma anche di Ennio Morricone, in un gioco elegantissimo di rimandi ad una tradizione scolpita nell’immaginario e di rielaborazioni curiose e intriganti tra le possibilità degli strumenti.
Di tutt’altro tenore, invece, la musica contenuta nel conclusivo Manzanar (disco 10): ensemble di quattro archi più contributi ai fiati, per quello che risulta essere un bagno profondo nelle acque dove si scontrano le correnti della musica improvvisata e della composizione contemporanea. Questa sezione è teatro di alcuni dei passaggi idealmente più lontani dal resto dell’opera, come i venti minuti di Khaen, che con la propria grandeur pericolante e il senso di collasso imminente porta forti suggestioni di Scelsi e Xenakis. Tuttavia le composizioni rimangono saldamente coerenti con la linea tracciata finora anche nel contesto di una strumentazione radicalmente differente: lo si sente soprattutto nella spiritualità intensa che colora il magnifico librarsi d’archi nella conclusiva On Being Native, ma anche nel lirismo di Manzanar o nelle connessioni mutevoli di Charcoal Paragraphs. Quando poi Lakota scioglie l’ensemble su un brano dalla fortissima impronta jazz, a partire dalla linea ritmica che languidamente si dipana per tutta la sua durata, il gioco è tanto scoperto quanto irresistibile.
Un’altra importantissima caratteristica di “unità nella diversità” riguarda l’incredibile vastità e varietà di strumenti (soprattutto fiati) provenienti da ogni latitudine che Parker coinvolge estesamente in moltissimi passaggi di Migration…. Si tratta ben più di un semplice vezzo di abbondanza esotica: ognuno degli strumenti utilizzati ha infatti un ruolo ben preciso, conferito in virtù delle particolari qualità sonore e timbriche che porta in dote. Difficile immaginare il delicato equilibrio di If We Play Soft Enough senza i ricami delle trame di duduk e fujara, così come sembra impensabile l’intensità dell’invettiva di Shutters as Windows senza l’incalzare stentoreo del gralla. La ricchezza di questa risorsa viene celebrata con un disco dedicato, The Fastest Train (disco 9), suonato da una formazione a tre in cui Parker e gli olandesi Coen Aalberts e Klaas Hekman si cimentano con percussioni e fiati provenienti dalle tradizioni musicali dei più disparati angoli del globo, dalla Nuova Guinea al Mali, passando per l’Estremo Oriente. Per scopi e dimensione si tratta di un’espressione molto ridotta nell’organico, ma è facile imbastire un paragone con alcune incarnazioni del Kulture Jazz di Wadada Leo Smith. L’ensemble ridotto concentra tutta l’attenzione sulle peculiarità degli strumenti e sulla scoperta delle combinazioni possibili che si attivano quando note che hanno radici in continenti diversi si legano tra loro. I tre musicisti sono in grado di trasformare un setting ristretto in un viaggio entusiasmante, sostenuto dall’inventiva delle reciproche intuizioni, sfruttando al meglio l’arsenale musicale a propria disposizione. Ascoltando il disco si rimane certamente affascinati dalla quantità di stimoli da cui si può essere investiti pur in un contesto quasi intimista, come una festa pan-continentale lillipuziana. L’effetto generato dall’uso di una strumentazione così variegata va ben oltre i confini di questo singolo disco, per investire l’intera opera. L’inclusione profonda e naturale nel tessuto delle composizioni dei retaggi musicali provenienti da tradizioni (almeno geograficamente) lontanissime tra loro, unite in un flusso espressivo denso e coerente, porta alla fusione di questi richiami ancestrali in uno spazio di ascolto che li include tutti. Uno spazio immaginario dell’esperienza musicale, cioè, che proprio in virtù della varietà di stimoli accolti arriva a costituire una nuova tradizione dalla storia unitaria e senza confini. È ciò che Joachim-Ernst Berendt definisce imaginary folklore, una sensazione di affascinante straniamento geo-musicale che Parker riesce a ricreare nelle pieghe della sua opera.
Un ulteriore filo conduttore di quest’opera, a posteriori comunque evidente all’ascolto, è suggerito da William Parker stesso, quando afferma che Migration… sia pensato come una «collection of vocal and instrumental suites […] with women’s voices at its core». Infatti, nonostante l’album possa essere giustamente visto come un monumento alla figura di Parker, questi dieci dischi in realtà celebrano soprattutto l’espressività e la vitalità delle voci femminili. Tra i molti ensemble che danno vita alle diverse sezioni di questo percorso musicale, la presenza di strumentiste donne è notevole e variegata; inoltre, il ruolo preponderante della vocalità femminile è probabilmente l’aspetto più immediato e luminoso di questa raccolta. Migration… si pone in effetti come vera e propria esplorazione a tutto campo delle possibilità comunicative ed interpretative del jazz vocale, affidando il timone a cantanti che attraverso l’unicità del proprio stile tracciano una rotta di arricchimento ed empowerment artistico. I punti di riferimento per questa operazione non vanno ricercati soltanto nel free jazz più militante, ma anche e soprattutto nelle espressioni più politicizzate e identitarie della musica soul, da Gil Scott-Heron a Curtis Mayfield – quest’ultimo già celebrato da Parker in occasione del doppio-tributo I Plan to Stay a Believer, del 2010.
Fin dal primo disco, Blue Limelight, si viene trascinati dalla grande varietà di soluzioni offerte anche all’interno di un approccio tradizionale. Dalla graffiante energia soul di Cosmic Funk al lirismo di Blue Limelight (pezzo dedicato a Cecil Taylor), fino all’esuberanza verbale che acquisisce vitalità narrativa in Bennie’s Tune e forza polemica in Recall: l’interprete, in questo caso Raina Sokolov-Gonzalez, sembra capace di prendere l’ascoltatore per mano e condurlo verso nuovi lidi ad ogni pezzo. Ma la magia è possibile non soltanto per la bravura delle cantanti coinvolte, quanto soprattutto per la profonda fusione tra le trame musicali create dalle varie formazioni e la resa vocale delle interpreti. Le due forze agiscono in sinergia, in un processo di assorbimento e stimolo reciproco, in cui l’espressione emotiva è continuamente modulata ed affinata. Un chiaro esempio tratto dal primo disco è la splendida A Great Day to Be Dead, in cui la voce sospesa tra spoken word evocativo e canto cangiante si incastra alla perfezione con il penetrante tema di oboe che guida l’atmosfera spirituale del brano. L’effetto generato da questa unità di intenti è ancora più evidente in Lights in the Rain, dove la voce di Andrea Wolper non ha un ruolo di primo piano; eppure quando compare sulla scena sa trasmettere una grande eleganza unita allo stesso tempo alla forza passionale dell’espressione soul, ed è come se la sua voce fosse il fattore di innesco che spinge gli strumentisti a osare di più, a cercare combinazioni più ardite senza perdere la sensibilità espressiva. Quando poi a sorpresa la cantante veste i panni della chanteuse, ne esce una ballad delicata e intensa come Milano, due minuti di pura luce. Lo stesso può dirsi per il già citato Mexico, in cui Jean Carla Rodea cantando in spagnolo sembra poter assorbire nella propria voce tutta la drammaticità delle storie evocate, da orgogliose rivendicazioni a pieni polmoni alla lentezza di tristi lamenti.
Quando invece è la voce stessa ad essere concepita come grimaldello per sperimentare, si generano altre combinazioni molto interessanti. In The Majesty of Jah (disco 3) e Cheops (disco 4), le voci rispettivamente di Ellen Christie e Kyoko Kitamura sono niente meno che ulteriori strumenti partecipanti all’amalgama dell’improvvisazione, con le frasi pronte a sfaldarsi in fonemi e a farsi puro suono. Per avere idea degli orizzonti a cui mira questa disposizione è necessario ascoltare almeno Freedom e If We Play Soft Enough, due pezzi giganteschi in cui le potenzialità giungono a piena fioritura. Freedom è il punto focale di un disco che riassembla liberamente registrazioni risalenti al 2010 ad opera di vari musicisti modificandole massivamente con overdub e manipolazioni sonore: non a caso il primo brano, che si avvale di un lungo sample di James Baldwin (a cui è dedicato), suona più come un pezzo dark ambient che non come una composizione jazz. In questo contesto Freedom è forse il brano in cui l’abile montaggio di registrazioni sovrapposte raggiunge la maggiore efficacia, incluso un campionamento trascinante dello stesso Parker; su questa struttura Christie può dipingere a mano libera con la voce, e sembra quasi di sentirla incarnare Abbey Lincoln in alcune delle sezioni più liberatorie di We Insist!. If We Play Soft Enough è invece un lungo pezzo che porta al culmine il rapporto tra ritualità e sperimentazione che caratterizza tutto Cheops. È un pezzo magistrale nel controllo dei propri umori, pervaso da una tensione costante, un “pianissimo” che cammina sul ghiaccio sottile e che minaccerebbe di esplodere in un “fortissimo” dissonante se non ci fosse la voce di Kitamura a tenere le briglie e a contendere magneticamente il controllo dell’esecuzione con intensità quasi sciamanica.
Tuttavia, non tutti gli esperimenti vocali raggiungono questo grado di riuscita: il riferimento è alla lunga e frammentaria rimuginazione di Afternoon’s Poem (disco 7), disco affidato esclusivamente alla voce di Lisa Sokolov e relativi overdub, il cui tentativo di creare una densità di significato attraverso la pura ricombinazione fonetica non tiene il passo della propria ambizione. Si tratta comunque di un passaggio a vuoto comprensibile e perfino atteso in un’opera di queste dimensioni. Del resto, nella grande ricchezza di contenuti, gli fa da contraltare un Harlem Speaks (disco 5) in cui Fay Victor si dedica con grande efficacia a raccogliere l’eredità del gospel e dei field holler utilizzando la ripetitività e il flusso verbale come amplificatori emotivi. La sua voce lancia rivendicazioni, accuse, fiere difese, per poi spezzarsi in frammenti di suono che rotolano pirotecnici e affamati, come se la portata emotiva del messaggio fosse troppo forte per potersi risolvere in una dichiarazione lineare. Ne risultano momenti dalla carica politica sincera e viscerale, particolarmente potente in Harlem Dances e Shutters as Windows: due brani in cui l’orgogliosa affermazione delle proprie radici e delle propria sofferenza diventa liberatoria, pervadendo l’intera rappresentazione musicale di una forza a pugni serrati impossibile da ignorare. Una forza che, pur travolgente e viscerale, non cede mai a facili verbosità politiche cui troppo jazz contemporaneo ci ha abituati. Insomma, al contrario dei facili declami degli Heroes Are Gang Leaders o degli slogan urlati sguaiatamente dai SoundNoiseFunk della stessa Fay Victor, in cui è lasciato poco spazio all’immaginazione o all’elucubrazione personale, i testi di William Parker mantengono una dimensione astratta e quasi criptica – un valore aggiunto alla sua poetica che, soprattutto in questi tempi di attivismo politico facilone e tagliato con l’accetta, non si può rimarcare mai abbastanza.
Ecco allora che un buon riassunto di questa opera potrebbe risiedere nella già citata A Good Day to Be Dead, un pezzo che riesce ad evocare con estrema naturalezza memorie d’infanzia, Gesù Cristo, Alice Coltrane e Betty Shabazz. Specchio ideale di dieci ore di musica che nel loro corso riescono a tenere insieme intimità, spiritualità, orgoglio e coscienza collettiva. Niente male per una pubblicazione del 2021.