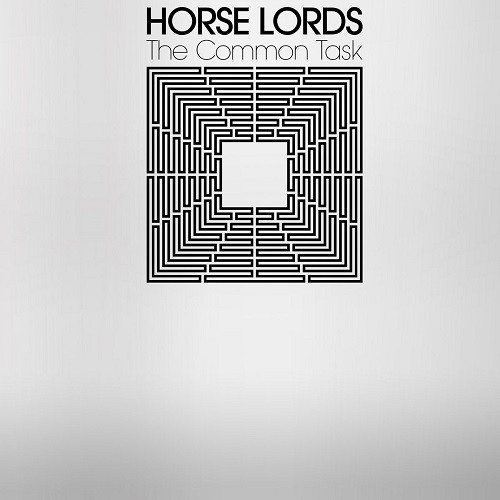HORSE LORDS – THE COMMON TASK
A giudicare dalle parole del chitarrista Owen Gardner, la Baltimora degli ultimi anni deve essere un posto interessante per vivere a contatto con il sottobosco musicale statunitense. Basso costo della vita che permette di concentrarsi sulla scrittura della musica, una scena vivace e popolosa che si destreggia tra musica sperimentale, hardcore e improvvisazioni assortite, ambiente poco competitivo e intimidatorio per le nuove leve: tutto sembra costruito su misura di quegli artisti emergenti che cercano di trovare la propria strada con una proposta innovativa. E, ascoltando gli Horse Lords, è lecito credere che in questa testimonianza ci sia del vero: fin dalla loro formazione nel 2010, gli Horse Lords hanno continuato a pubblicare con cadenza regolare diversi mixtape e full-length, scrivendo alcune delle pagine più promettenti della musica strumentale dell’ultimo decennio. (Ovviamente, eccezion fatta per una sparuta minoranza di appassionati e addetti ai lavori che si sono accorti in tempo reale dell’LP Interventions nel 2016, la quasi totalità del mondo ha pensato bene di girarsi dall’altra parte e ignorarle.)
Gli Horse Lords suonano, essenzialmente, rock. Lo testimoniano l’irruenza e il volume dei loro strumenti – che, se non fosse per qualche occasionale contributo del sassofono, sarebbero quelli più classicamente rock: solo chitarra, basso, e percussioni. E anche i loro incastri ritmici – spastici e cervellotici, ma dal groove propellente sempre marcato – rimandano immediatamente alle pagine più cerebrali della storia della musica rock (Don Caballero e Battles sono i nomi che saltano in mente più facilmente all’ascolto di un lavoro come Interventions, ma si può agilmente risalire l’albero genealogico fino a giungere ai King Crimson di Discipline, ai Can e alla Magic Band di Captain Beefheart). Ma al contrario di tutte le altre centinaia di gruppi che affollano le scene underground suonando musica rock strumentale e spastica, gli Horse Lords sembrano pervenire a questo suono quasi per una mera contingenza: la formazione musicale del quartetto è infatti più radicata nella tradizione rurale del blues e del folk americano, nei ritmi percussivi della musica africana, negli estatici ostinati del minimalismo e dei suoi sviluppi totalisti degli anni Ottanta. È in questi generi, più che nella musica rock, che bisogna rintracciare quindi i riferimenti più prossimi per comprendere il particolare stile di Gardner, che suona la sua chitarra, accordata specificatamente per rifuggire il temperamento equabile e potervi applicare le tecniche della musica della Mauritania, sfruttando i topoi del banjo nella musica blues e country; o per capire la provenienza culturale dei serrati poliritmi del batterista Sam Haberman, che coniugano le danze dei Wagogo con Glenn Branca e Rhys Chatham; o ancora per cogliere l’influenza degli intrecci polifonici dei Banda e delle ultime derive post-minimaliste di Keir Neuringer sugli interventi del sassofono di Andrew Bernstein.
È quindi più corretto dire che gli Horse Lords ripartano, essenzialmente, dalla musica tradizionale e folk di diverse parti del mondo infondendo in essa una nuova linfa vitale attraverso l’applicazione del rigore accademico del minimalismo, dei suoni del rock e della tecnologia elettronica (in studio il bassista Max Eilbacher, che ha anche studiato musica elettronica, riveste le jam del quartetto con ingenti dosi di registrazioni trovate, glitch, rumorini e manipolazioni assortite). E per questo, nel tentativo di definire la propria proposta, gli Horse Lords hanno coniato la formula (eccentrica, ma tutto sommato azzeccata) electrified vernacular minimalism.
I guess, rock n’ roll in a way, but in a very abstracted sense. Rock can absorb all these different things in an organic way. None of us really listen to a lot of rock music, honestly, and it’s not something that I feel very invested in. I guess we are a rock band. I don’t know if I care about the idea of rock music “progressing.” If it needs to, it’s not going to come from other rock music. It needs to be corrupted from within, I guess. Hopefully it can mutate into something else. But there are things about rock that are valuable too. You can be… you know, loud. It’s fun.
(Owen Gardner)
L’ultimo full-length The Common Task, uscito questo marzo per la Northern Spy, è il primo album degli Horse Lords che è riuscito finalmente ad attirare l’attenzione del pubblico e della critica – noi compresi, visto che li abbiamo scoperti solo quest’anno come più o meno chiunque altro. E il motivo è presto detto: è la cosa migliore che gli Horse Lords, tra mixtape e album, abbiano inciso fino ad oggi.
Il loro stile non ha subito drastici cambi di rotta, perlomeno per quanto concerne la musica che occupa la prima metà del lavoro: la formula rimane essenzialmente la stessa dei lavori precedenti, con la stessa peculiarissima sintesi di folk occidentale e africano, minimalismo, rock ed elettronica e lo stesso approccio alla composizione dei pezzi tramite sviluppi rizomatici e jam estemporanee. Anche la componente digitale della musica di Interventions è stata preservata se non ulteriormente ampliata – tanto che è all’esplorazione delle sue potenzialità è dedicata completamente The Radiant City, sorta di dialogo per elettronica e cornamusa (cortesia dell’ospite Duncan Moore) che offre la personale reinterpretazione degli Horse Lords di uno dei cliché della musica contemporanea: il rapporto tra uno strumento solista acustico e la live electronics, che ne soggioga e trasfigura la voce con riverberi e sibili minacciosi.

Quello che è cambiato è, semplicemente, il carattere e l’efficacia dei brani. La musica di The Common Task è più varia, meglio congegnata, e tutto sommato semplicemente più divertente di tutto ciò che gli Horse Lords abbiano mai registrato finora: è paradigmatico l’esempio di People’s Park, che in soli quattro minuti si evolve dipanandosi tra poliritmi percussivi africani, giocondi intrecci melodici degni dei Battles, e interventi elettronici esplosivi che tuttavia non mettono mai in discussione l’andamento quasi ballabile del brano. E anche quando la durata dei pezzi aumenta (superando sensibilmente i sette minuti su Fanfare for Effective Freedom e Against Gravity), questi esprimono sempre un’evoluzione coerente e logica, per quanto portata avanti impercettibilmente tramite microvariazioni e ostinate ripetizioni delle stesse cellule ritmiche e melodiche, richiamando alternativamente La Monte Young (ma tramite la lente dei Velvet Underground), Evan Parker, i NEU! e i Niagara.
Ciò che succede nella side B è invece un’assoluta novità nel catalogo degli Horse Lords, ed è probabilmente ciò che più di ogni altra cosa consacra The Common Task tra i dischi più interessanti di questo primo quarto d’anno. Integral Accident ha poco a che vedere con il resto del disco: è piuttosto una vera e propria composizione minimalista, dalla ragguardevole durata di oltre diciotto minuti, eseguita da un ensemble rock. Si apre con una lunga e sommessa ouverture per violino (Ledah Finck), fagotto (James Young), fisarmonica (Leo Svirsky), voce (Bonnie Lander) ed elettronica, che ricorda alla lontana tanto la Stimmung di Stockhausen quanto la Dolmen Music della Monk, e solo dopo sette minuti di climax qualche primo colpo di grancassa conduce il brano verso una seconda fase più riconoscibilmente rock, in cui il quartetto elettrico accompagna le evoluzioni della voce e le trame dal sapore vagamente folk del violino con un groove rubato al Broken Consort di Mikel Rouse. Infine, le disturbanti dissonanze della chitarra e il cupo incombere dell’elettronica chiudono Integral Accident e con esso The Common Task: difficilmente quest’anno troverete un gruppo rock capace di essere, al contempo, acuto e divertente quanto gli Horse Lords di questo brano.