Fin dall’invenzione della scrittura o giù di lì, il copiare ha fatto parte dell’esperienza artistica umana tanto quanto l’effettiva produzione dell’oggetto d’arte. Senza stare a scomodare Walter Benjamin, la discografia non fa ovviamente eccezione. I cilindri di cera di Thomas Edison, così come i primi dischi per grammofono, sono stati vittime di copie e modifiche non autorizzate non appena le tecnologie che permettevano la loro produzione sono divenute disponibili al pubblico. Pensare che già nei primissimi anni del ‘900 un personaggio come Wynant Van Zandt Pearce Bradley (nome incredibile, tra l’altro) fosse stato citato in giudizio dai tribunali di New York per la contraffazione di arie d’opera appartenenti all’etichetta italiana Fonotipia e di alcuni modelli di grammofono Victor (quelli di Nipper e di His Master’s Voice, per intenderci), alle nostre orecchie risulta strano e quasi scontato al tempo stesso. Nei trent’anni successivi al caso Bradley, il problema della pirateria rimane essenzialmente confinato alle retrovie del mondo discografico; è solo quando la Victor si rende conto che alcuni collezionisti stanno stampando autonomamente copie di introvabili 78 giri di artisti jazz di inizio secolo che le prime misure contro questi dissidenti alle leggi del mercato discografico vengono intraprese.
C’è da dire che, fin dall’insorgere del problema della pirateria, le soluzioni dell’industria discografica sono sempre sembrate particolarmente tiepide e poco convincenti; ad esempio, per contrastare i discofili di cui sopra, la soluzione che la Victor pensò di apportare fu quella di pubblicizzare la qualità sonora dei propri dischi come assolutamente superiore a quella delle vecchie copie pirata. Ovviamente, questa strategia commerciale mancava interamente il punto della pirateria dei fanatici di Bix Beiderbecke e di Jelly Roll Morton: il problema non era la qualità della registrazione, quanto più l’irreperibilità del supporto fisico che la contenesse.
Arrivati a questo punto, è interessante notare che la pirateria fino agli anni ’50 era un argomento legale particolarmente scivoloso. Molti giudici statunitensi avevano addirittura condonato la copia dei dischi da parte di questi primi, intrepidi bucanieri; la loro motivazione risiedeva nel fatto che, differentemente da libri, film o spartiti [sic!], la replica dell’oggetto fisico non indicava in maniera evidente la riproduzione illegale della musica contenuta al suo interno.
La situazione rimase in questo grigio stato di ambiguità fino al 1951, anno che coincide con due avvenimenti chiave nella storia dell’industria discografica. In quel periodo, infatti, un collezionista di dischi jazz di nome Dante Bollettino aveva messo in piedi, da qualche anno, una casa discografica pirata con il nome decisamente poco subdolo di Jolly Roger Records. L’intento di Bollettino era quello di trasferire le registrazioni di vecchi artisti blues e jazz dagli ingombranti 78 giri nel nuovo e pratico formato dell’LP come lo conosciamo; in un incredibile gioco di mano, Bollettino era riuscito a stringere un accordo nientemeno che con la RCA Victor per utilizzare le loro fabbriche e stampare questi nuovi dischi, corredati da grafiche esuberanti e che si guardavano bene dall’inserire menzioni sull’origine delle registrazioni originali. La Columbia, all’epoca la grande competitor della Victor, portò in tribunale Bollettino per una sua antesignana compilation di brani di Louis Armstrong di cui l’etichetta deteneva i diritti, vincendo e creando uno storico precedente nelle dispute riguardanti l’infrazione del copyright; probabilmente fu proprio in reazione a questo scandalo che la RIAA, la società americana che oggi gestisce i diritti della maggior parte dei compositori in maniera non dissimile dalla nostra SIAE, fu creata poco dopo.
Tuttavia, il fenomeno della pirateria non si arrestò negli anni Sessanta. Anzi, l’industria discografica dovette iniziare a confrontarsi, nel decennio successivo al caso Bollettino, con una nuova ondata di pirati ancora più affamata di quella precedente. L’improvvisa e capillare distribuzione di etichette di ogni tipo sul suolo americano diede vita a una nuova tipologia di pirati, quelli che oggi potremmo identificare come leakers: diversamente dai loro predecessori, i leakers riuscivano a ottenere in anteprima rispetto al mercato nazionale demo e master takes delle nuove registrazioni dei grandi artisti contemporanei, e dopo averle copiate le rimettevano in commercio a prezzi decisamente minori rispetto a quelli delle controparti originali. Risalgono a questo periodo in particolare Great White Wonder di Bob Dylan (che contiene al suo interno i germi di tutto The Basement Tapes) e Live’r Than You’ll Ever Be dei Rolling Stones (praticamente una versione più rozza di Get Yer Ya-Yas Out); la comodità di poter registrare la propria radio da casa con un semplice mangiacassette Philips permise la diffusione oltreoceano e in Europa delle John Peel Sessions degli artisti più in voga, in quegli anni riprese pedissequamente dalla BBC.
Gli anni Sessanta e Settanta, insomma, sono l’epoca d’oro della pirateria: è il momento in cui sacche di resistenza a quello che è il mercato dominante della musica si affermano e cementificano la loro reputazione. Basti pensare all’esempio dei Grateful Dead: in pieno stile hippy libertario, i Dead ammettono liberamente ai propri concerti i bootleggers e, dagli anni Ottanta, iniziano a riservare a questi ultimi una sezione di posti ai concerti da cui è possibile registrare il suono nel miglior modo possibile. I loro fan, poi, si scambiano freneticamente le cassette registrate tra una serata e l’altra, creando addirittura delle classifiche nelle fanzine dedicate al gruppo sui migliori bootleg da reperire. Sulla East Coast, invece, Bruce Springsteen è vincolato da un contratto con la Columbia, che lo fa aspettare tre anni prima di pubblicare Darkness at the Edge of Town; durante i concerti del tour di Born to Run, perciò, Springsteen invita apertamente i pirati a registrare le serate, dato che i pezzi sono già scritti, pronti per essere suonati e non c’è altro modo in cui i suoi fan possano sentirli. Allo stesso modo, numi tutelari del punk come Television e Patti Smith riescono a ottenere contratti con le case discografiche proprio perché le registrazioni dei loro live nelle bettole di New York circolano freneticamente tra gli appassionati.
Ovviamente, la favola non può durare: nel 1971 prima, e nel 1976 poi, il governo statunitense approva delle modifiche più stringenti in materia copyright, fissando inoltre il limite per la detenzione dei diritti sulla proprietà intellettuale a cento anni dalla pubblicazione o a settantacinque anni dalla morte dell’autore e facendo leva sulle altre nazioni del blocco occidentale per adeguarsi a questa misura. Nel 1973 la Rubber Dubber, una delle etichette pirata più celebrate e diffuse negli States, viene chiusa dopo un raid dell’FBI; il suo fondatore, Scott Johnson, è costretto a fuggire in Messico e tornerà negli USA anni dopo sotto falso nome. Ma l’industria discografica continua ad avere problemi che non riesce a risolvere.
Infatti, se l’FBI e la polizia possono (invano) provare ad arginare il fenomeno in patria, gli Stati Uniti non riescono in alcun modo fermare il traffico pirata che si diffonde a macchia d’olio in tutto il mondo: ad esempio, la colonna sonora di Grease diventa un bestseller in vari stati del Sud America ancora prima che il film raggiunga le sale; la Nigeria, che inizia timidamente ad affacciarsi sullo scenario mondiale negli anni Ottanta, diventa un sinonimo per lo smercio di CD copiati in tutto il continente africano; Taiwan, una delle poche nazioni al mondo a non aver accettato i cambiamenti statunitensi alle leggi sul copyright, diventa un hub attraverso cui i cittadini cinesi possono mettere le mani su musica che il PCC ufficialmente ha bandito come decadente propaganda capitalista, tipo Puff the Magic Dragon di Peter, Paul & Mary; nei paesi dell’Unione Sovietica, nel frattempo, il modo più facile per mettere le mani sugli album americani è quello di utilizzare le lastre radiografiche scartate dagli ospedali come materiale di stampa al posto del vinile. Intanto, la RIAA si trova a dover discutere per anni su come considerare legalmente i sample: la decisione arriva solamente nel 1991, quando il clearing, cioè il pagamento delle royalties all’artista, dei brani campionati diventa obbligatorio pena la denuncia. Tra i venditori pirata, ovviamente, questo discorso non vale: per strada, remix amatoriali e compilation illegali vengono vendute in libertà. Caso esemplare in questo senso è 50 Cent, il cui debutto per un’etichetta arriva dopo più di quattro anni in cui il nome del rapper si è affermato con mixtape e bootleg.
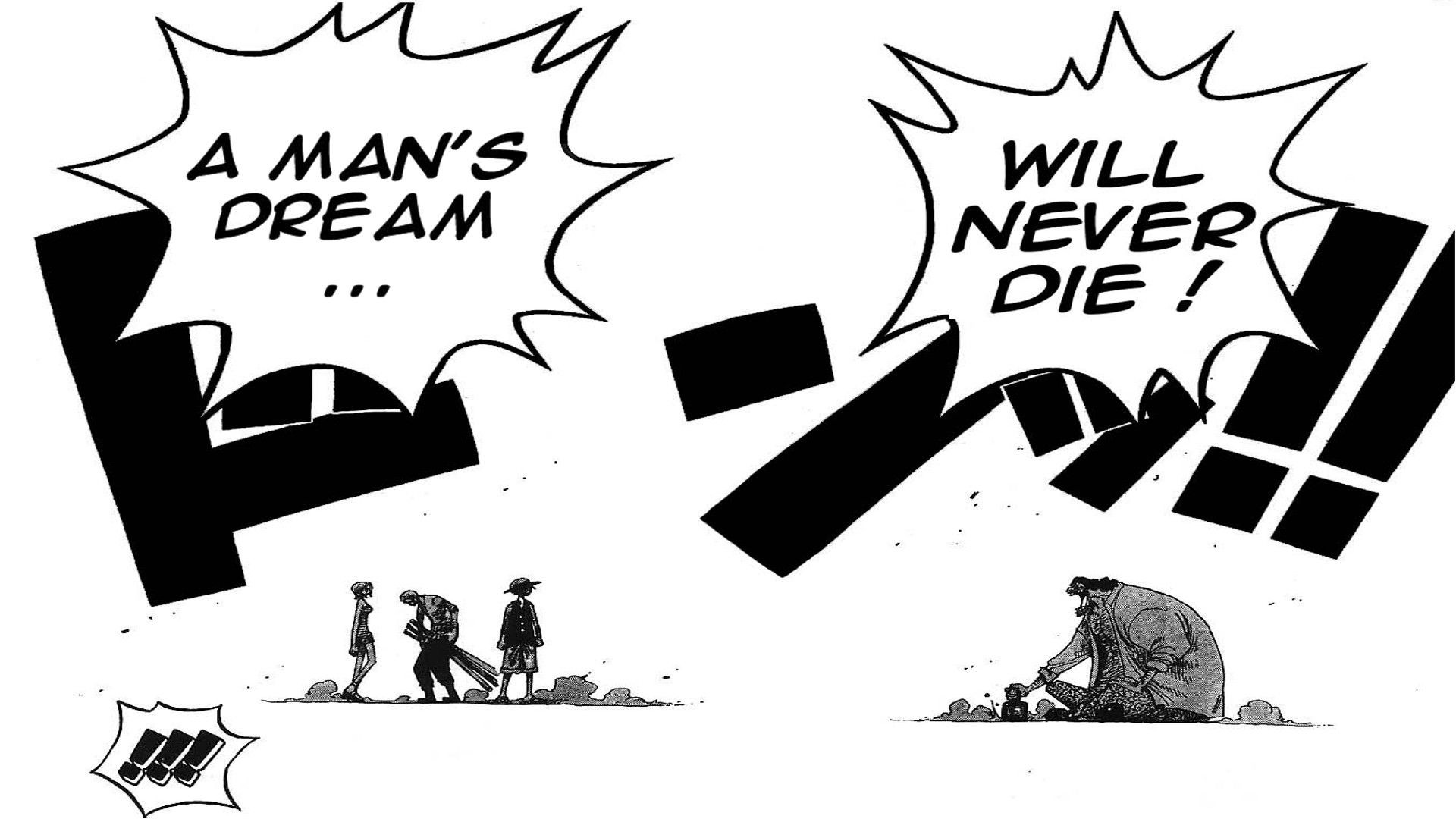
Tutto questo accade prima che internet entri nelle vite di tutti noi: la situazione sembra sfuggire ancora più dal controllo stringente quando l’industria discografica deve fronteggiare nuovi, temibili concorrenti come Napster e Limewire. La cifra monstre di 72 triliardi di dollari che tredici etichette chiedono a Limewire come risarcimento per i danni causati nei suoi dieci anni di attività è significativo di una nuova modalità di ascolto tra appassionati che i discografici non riescono a fronteggiare; e nemmeno le misure adottate da servizi come Apple Music riescono a tamponare l’enorme emorragia causata da nuovi servizi come YouTube. Questo, perlomeno, fino all’entrata di Spotify sul mercato e alla enshittification del sopracitato YouTube.
Se gli ultimi paragrafi vi danno le vertigini, è anche perché il panorama musicale si è espanso all’inverosimile: con l’avvento del villaggio globale, l’industria musicale anglofona ha perso inevitabilmente parte della propria rilevanza a fronte di mezzi di produzione discografica sempre più economici, come anche quelli della distribuzione resa liquida dalla information superhighway. E i pirati?
Il fenomeno vive di una condizione ambivalente: da una parte, è indubbio che il movimento pirata sia più attivo e frequentato che mai, ripopolato da cowboy dell’etere insoddisfatti dalla recinzione forzata dell’internet 3.0 e da comunità di Paesi impossibilitati a sostenere i costi, proibitivi al cambio, dei servizi legali. Dall’altra, è indubbio che creare copie pirata di album sia diventato più difficile; vuoi per il modo in cui la distribuzione dei dischi è stata de facto consegnata a Spotify e ai suoi metodi di protezione dei file, o per il modo in cui è la stessa Spotify (assieme ai vari Bandcamp, Tidal, Apple Music, ecc ecc.) ad aver reso comodo e semplice ottenere tutta la musica che si vuole ascoltare a un prezzo irrisorio di fronte al costo dell’acquisto di un album fisico. Eppure…
Solo qualche giorno fa un amico che vive la vita in bilico sul confine della legalità da anni mi ha fatto una domanda che, nell’immediato, mi ha colto di sorpresa. “Ma tu li collezioni i vinili?” L’amico in questione mi conosce da anni e sa che, come lui, sono infognato nel grande mondo della musica: abbiamo anche suonato insieme per qualche tempo. “Sì, come mai me lo chiedi?” La sua faccia si illumina; sa che una domanda così generica attira per forza l’attenzione. “Avevo un affare da proporti…” La mia, di faccia, evidentemente tradisce ancora una volta interesse. “Sto per stampare 300 copie in vinile della registrazione che ho fatto del concerto di Nick Mason a Pompei qualche anno fa, mi hanno già prenotato delle copie dalla Polonia e dall’Austria…”. Ecco, io non so se comprerò il vinile pirata del mio amico, ma non mi aspettavo che la sua idea potesse essere la chiave di volta di questo pezzo: in un momento storico in cui le registrazioni di buona qualità sono accessibili a tutti e i tempi dell’industria si fanno sempre più inutilmente lunghi unicamente per logiche di mercato, la rapidità istantanea del bootleg diventa un mezzo straordinario con cui creare testimonianze di eventi unici, il souvenir di una partecipazione a un rito sociale come quello della musica nella sua forma più brutalmente onesta, un’altra lente attraverso cui guardare quel mondo contorto che è l’industria discografica. Alla peggio, avrete tra le mani un altro Yeeshkul!





