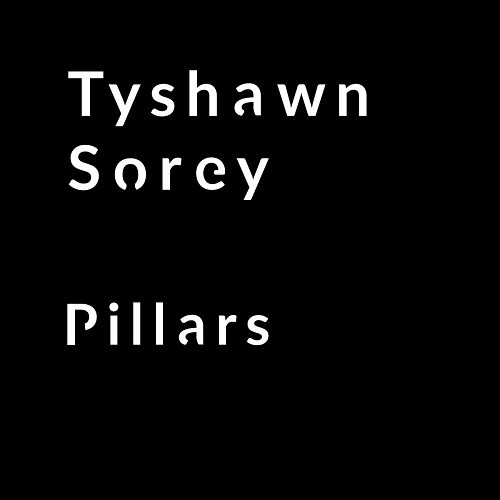TYSHAWN SOREY – PILLARS
Innanzitutto, un breve recap per chi si fosse perso uno dei più importanti artisti degli ultimi tempi: Tyshawn Sorey è uno dei massimi batteristi e compositori di quest’epoca. Negli ultimi quindici anni ha suonato con praticamente tutti i musicisti più avanzati dell’attuale scena avant-garde di New York (da Vijay Iyer e David Binney a Steve Lehman e Matt Mitchell), e con molte glorie del più o meno recente passato come Roscoe Mitchell, Anthony Braxton, John Zorn, Steve Coleman e, soprattutto, con Butch Morris, forse la personalità jazz concettualmente più influente sulla sua formazione. I maggiori riconoscimenti li ha ottenuti però in qualità di leader: a partire dal 2014, quando ha firmato con la Pi Recordings per Alloy, Sorey ha intrapreso una strada che l’ha portato a rivoluzionare il modo di concepire la zona di confine tra musica improvvisata e musica contemporanea realizzando alcune delle opere più lungimiranti degli ultimi anni, come The Inner Spectrum of Variables (2015) e soprattutto il suo ultimo capolavoro Verisimilitude (2017).

Per la registrazione della sua ultima composizione, Tyshawn Sorey è tornato alla Firehouse 12, l’etichetta che l’aveva lanciato nel 2007 con That / Not. Concepita per un ottetto comprendente Stephen Haynes (tromba, flicorno tenore e soprano, cornetta e percussioni), Ben Gernstein (trombone e melodica), Todd Neufeld (chitarra elettrica e acustica), Joe Morris (chitarra elettrica e contrabbasso), Carl Testa (contrabbasso ed elettronica), Mark Hellas e Zach Rowden (contrabbasso), oltre ovviamente a Tyshawn Sorey (che oltre a suonare batteria, percussioni, trombone e dungchen dirige anche l’esecuzione dell’ensemble), questa Pillars porta alle derive più estreme tutti i punti cardine dell’estetica che Sorey ha sviluppato nei suoi dischi per Pi.
È estrema la mole: parliamo di un immenso monolite lungo quasi quattro ore, registrato in soli due giorni di prove tra il 30 e il 31 luglio 2017. Il box set da tre cd (pubblicato questo 12 ottobre) ripartisce la musica di Pillars in sole tre tracce (una per disco), ognuna dalla durata non inferiore ai settantacinque minuti; su vinile esce invece come doppio LP con una versione modificata e “riassuntiva” della Pillars originale, intitolata semplicemente Pillars IV.
È estrema anche la proposta musicale: in queste quattro ore, Sorey presenta senza dubbio la musica più cerebrale e complessa che abbia mai scritto fino a questo punto della sua carriera. Il fulcro concettuale di partenza è come al solito la particolare interazione tra musica composta e musica improvvisata, ma sarebbe riduttivo pensare alla musica di Pillars solo come una nuova declinazione di quest’idea (ormai piuttosto esplorata e abusata, non solo da Tyshawn Sorey): Pillars è invece una composizione che sfida il concetto di musica, silenzio, tempo. Gli atomi di quest’opera sono eventi sonori realizzati da piccoli gruppi, composti da un numero variabile tra uno e quattro elementi, che si assemblano e disgregano spontaneamente (per tutta la sua durata Pillars non vede mai suonare l’ottetto insieme nello stesso momento). Questi eventi possono essere ostinati rulli pressati in solitaria, disarmonie di chitarra acustica o elettrica, abissali conversazioni tra i contrabbassi, mostruosi call & response di tromba e trombone, nebulose e sibili di elettroacustica, rintocchi di gong e percussioni, assoli oltretombali di dungchen: tutti questi sono soggetti continuamente a microvariazioni che ne modificano le dinamiche, il ritmo o il tempo di esecuzione, portando al naturale decadimento di una sezione che sfuma impercettibilmente nella successiva.
Pillars gioca così tra continue e graduali metamorfosi dell’impianto musicale di cui, per la loro natura subliminale, ci si accorge pienamente solo a posteriori, quando il processo è già radicalmente compromesso e lo scenario è definitivamente modificato. Su Pillars II, il dialogo tra chitarra elettrica e acustica viene dapprima accompagnato, poi sovrastato e infine sostituito dai fischi dell’elettronica; la contrita figura di contrabbasso e chitarra acustica che che apre la conclusiva Pillars III viene invece ripetuta ossessivamente, con impercettibili variazioni di dinamica e ritmo a ogni successiva iterazione, prima che il trombone prenda il sopravvento in una nebulosa di suoni alieni, lanciandosi in un assolo nel silenzio assordante degli altri musicisti. Quando il registro gravissimo del dungchen assume il controllo del brano, non si capisce nemmeno come sia avvenuto lo scambio di ruolo tra i due strumenti: l’effetto è ipnotico e straniante al contempo.
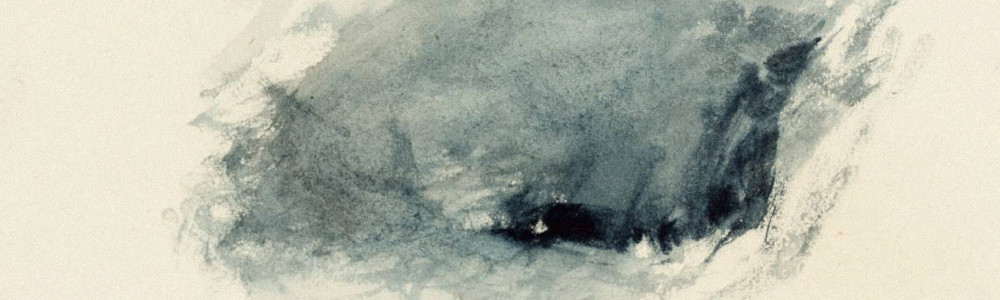
Pillars non si limita però a sperimentare sulla struttura della musica. La presenza di strumenti inusuali (la melodica che duetta con la tromba e le percussioni intorno ai venti minuti di Pillars II, o il dungchen che intorno alla metà della stessa traccia si erge in solitaria, proseguendo per oltre dieci minuti accompagnato esclusivamente dai colpi sporadici di un tamburo e di qualche piatto), così come il trattamento riservato agli strumenti più tradizionali, tra tecniche estese e sperimentazioni varie, mostrano un’estensiva attenzione al timbro. Le improvvisazioni e gli assoli di chitarra, instabili e incoerenti, provengono dalla scuola sperimentale di Derek Bailey; i fiati – tra skronk, sibili, suoni sporcati dal soffio irregolare – producono suoni alieni e terrificanti; i violoncelli sono suonati ora pizzicando le corde con le dita, dando così una pronuncia ritmica free jazz simile a quella di un Henry Grimes, ora con l’archetto, collegando le tecniche di Alan Silva con la musica di Salvatore Sciarrino.
D’altra parte, le percussioni non forniscono minimamente un sostegno ritmico alla performance degli altri musicisti. Nei momenti in cui appaiono sembrano anzi seguire una linea temporale propria e avulsa da quella del resto degli strumenti, con colpi che descrivono schemi astratti sfuggendo alla logica di un qualsiasi ritmo prefissato. Questa irregolarità ritmica, insieme alla sparsità della musica di Pillars, richiama l’elasticità temporale di Olivier Messiaen e, soprattutto, il Morton Feldman nel Philip Guston, ma sarebbe errato sottovalutare anche l’influenza del misticismo della musica ceremoniale tibetana nella concezione del tempo di Tyshawn Sorey in questa composizione.
Un ruolo chiave è giocato, infine, dall’elettronica e soprattutto dal silenzio. Se la prima manipola, altera e trasfigura il suono degli altri strumenti (soprattutto gli ottoni – come intorno alla metà di Pillars I, o nella conclusione di Pillars III), talvolta ponendosi come alter ego con cui dialogare come nella Répons di Pierre Boulez, talvolta spingendosi verso il linguaggio elettroacustico più estremo dello Iannis Xenakis di Persepolis (cfr. Pillars II), il secondo va considerato a tutti gli effetti come un altro strumento al servizio della visione di Tyshawn Sorey, e oltretutto uno dei più importanti. L’immensità del silenzio avvolge in una nube di mistero i monologhi dei vari musicisti, suggerisce una distesa siderale che fa risaltare la profondità dei registri più gravi delle parti di dungchen, violoncello, tamburi e grancassa (assoluti protagonisti per tutte le quattro ore dell’opera), e provoca l’eco che distorce e perturba il suono di ogni altro strumento, possa essere il rullante che apre Pillars I, le due chitarre su Pillars II o i piatti sfarfallanti in Pillars III, conferendo ulteriore fascino alla performance dell’ottetto. È l’antitesi dell’horror vacui: anziché riempire fittamente ogni spazio incastrandovi qualche strumento, Sorey lascia galleggiare la musica nel vuoto del silenzio – un approccio altamente rischioso, eppure qui estremamente vincente.
Pillars vive in un universo sonoro completamente suo. Non è jazz, ma non può prescindere dalle conduction più aliene di Butch Morris, dalle composizioni di Anthony Braxton, o dai gruppi di Roscoe Mitchell e Bill Dixon; non è classica contemporanea, ma mostra più di una traccia dei monumentali esperimenti di Morton Feldman, dell’alea di John Cage e della terrificante musica orchestrale di Giacinto Scelsi; non è musica elettroacustica, eppure spesso si avverte l’ombra di Karlheinz Stockhausen. È un ascolto complesso e difficile, non ultimo per il grado di attenzione che richiede fruire un lavoro del genere per quattro ore filate, ma è sicuramente una fatica che vale la pena provare, vista la grandezza della musica partorita da Tyshawn Sorey. Pillars è senza ombra di dubbio l’esperimento più ardito di tutta la sua carriera fino ad oggi, ma è anche vero che ripeto queste parole a ogni ascolto di un suo nuovo lavoro fin dal 2015. È impossibile prevedere verso quale direzione potrà ancora condurlo questa sua ricerca artistica: quel che è certo è che quest’anno ci ha consegnato una delle pagine più sorprendenti e profonde della musica d’avanguardia di questo tempo.