…I’m a poor boy and a long old ways from home.
Il Mississippi è stata la culla della musica afroamericana degli ultimi due secoli. Da Vicksburg a Memphis, da Clarksdale a New Orleans, le più importanti battute della cultura nera si sono svolte in questo inferno slabbrato e desolato, con scie che sono arrivate fino ai vicini Texas e Carolina. La storia della musica del Delta, e in generale del country blues che si è evoluto tra le due guerre, è fumosa, impalpabile e costellata di miti. La maggior parte dei musicisti che hanno avuto modo di debuttare nei juke joint o ai lati della stazione della ferrovia dopo aver ascoltato un singolo di Bessie Smith sono stati sicuramente ignorati dal lavoro filologico e appassionato di talent scout e case discografiche che avevano comunque l’interesse di vendere singoli e non altro. Di testimonianze dirette se ne hanno poche, e per lo più tarde. La più autorevole e poetica voce sul campo è quella degli etnomusicologi John e Alan Lomax, che negli anni ’30 e soprattutto ’40 hanno dato spazio a una grande quantità di vecchi mezzadri che hanno potuto raccontare delle loro condizioni e dei loro musicisti. In The Land Where the Blues Began c’è un affresco sicuramente un po’ romanzato ma anche molto chiaro e comprensibile delle questioni principali che hanno attraversato i feudi del Delta nel ventennio che va dalle registrazioni di W.C. Handy alla morte di Robert Johnson. Essendo, peraltro, un argomento delicato sulla questione della razza e nella visione di una storia della cultura americana, il Delta (con il suo esercito di bardi) è stato spulciato, analizzato e interpretato fino a fondo da una quantità di studiosi di diverse materie (come nella Cambridge Companion to Modern American Culture) senza che si avessero più di un pugno di nomi di cui ascoltare una registrazione (credo che non superino il centinaio). Una delle cose che ha permesso una quantità di studi così fiorente su di un argomento musicale del quale si hanno così poche fonti è la struttura modulare e generativa della stanza blues, i twelve bar, l’improvvisazione canonizzata, le tematiche “a mattoncino”: alcuni studiosi hanno addirittura ribattezzato Omero Blind Homer, per la comunanza di paratassi, topòi, e composizione modulare, nonché per il merito di essere stato l’enciclopedia della propria cultura. Quella che sto scrivendo io, invece, è solo una rimanipolazione di dati che ho letto in giro (a fine articolo c’è la bibliografia), costellata da qualche giudizio di valore personale nei commenti ai musicisti.
Comincerò a riassumere brevemente le radici comuni che sono state trovate da diversi studi etnomusicologici tra le varie forme primordiali di blues e tra una serie di tradizioni musicali etniche dell’Africa centro-occidentale, per poi spostarci (in seguito all’imperialismo e alla raccolta degli schiavi) in America del Nord e affrontare alcune tematiche della segregazione razziale, della guerra di secessione e delle espressioni musicali che sono state coniate all’interno di una società impregnata di schiavitù. Da qui andrò a citare quelli che si arrogano il titolo di “fondatori del blues”, con una brevissima panoramica sul rag e sui primi accenni di jazz nel melting pot di New Orleans, per poi discutere dei minstrel show, dei medicine show e dei vaudeville, l’ambiente nel quale è fermentato quello che ad oggi viene chiamato (un po’ blandamente) Classic Blues. Dopo aver fatto nomi e cognomi delle dive del blues classico passerò alla scoperta del folk/country blues, con una particolare attenzione al suo background culturale, molto diverso tanto dal panico metropolitano della Congo Square come dal depresso/speranzoso mugugnare degli holler degli schiavi del sud, e inizierò a raccontare qualcosa sui primi, enormi esponenti del blues rurale. Dopo una pausa per discutere delle relazioni che ha avuto la musica religiosa sulla cultura nera e, più nello specifico, sul blues e dopo aver affrontato il problema della crisi del ’29, passerò al rastrello (per quello che mi è possibile) i vari bluesmen di cui abbiamo una registrazione o un Complete Recordings che hanno suonato dal ’28-’29 alla fine degli anni ’30 e arriverò a scrivere del bluesman più famoso di tutti i tempi, cercando di stringare in una paginetta la sua vita, la sua musica e la sua morte. Dopo un ultimo sguardo sulle influenze dirette che il Delta Blues ha avuto sul blues elettrico di Chicago concluderò questo mio parto cercando di spiegarvi perché secondo me quel fazzoletto di fango che andava da Vicksburg a Memphis è stato uno dei luoghi più importanti della storia della musica contemporanea. Cominciamo.

Africa
Ci sono diversi fatti, diversi luoghi, diverse leggende sulle quali gli studiosi che hanno affrontato la storia del blues discordano, da chi ha scritto il primo blues a chi abbia insegnato a suonare la chitarra a Robert Johnson, ma su qualche punto sono tutti d’accordo, uno di questi è la provenienza remota del cuore duro del genere – scrive Martorella: «che il blues, come tutte le musiche nere, abbia radici e matrici africane è un dato di fatto incontrovertibile». Dello stesso parere sono Julia Rolf, Alan Lomax, Eileen Southern e così via. Quello su cui non tutti concordano, invece, è da quale Africa venga. Il Benin? La regione nera del Sudan? L’enorme striscia di staterelli dell’Africa occidentale? Che si parli di Benin o di Sierra Leone, comunque, tutte le supposizioni che sono state fatte riguardano una larga fascia di stati subsahariani che a livello cardinale vengono identificati come Africa centro-occidentale. La lingua musicale delle etnie dell’Africa centro-occidentale, effettivamente, ha una grande quantità di luoghi comuni condivisi con il blues (e con molti altri generi di black music), come l’utilizzo del call-and-response, la tendenza all’improvvisazione estemporanea, l’utilizzo di poliritmi, riff e intonazioni apparentemente “sbagliate” (che nell’America africana si sarebbero trasposte nelle blue note), ma soprattutto una visione particolare e fortemente diversa da quella europea, orientale, mussulmana, di musica: un unico movimento tra musicisti e ascoltatori che rappresenta un momento sociale di primaria importanza nella vita quotidiana o rituale, dove la composizione rimane un canovaccio dai margini fluidi che può e deve essere adattata alle esigenze del momento, della danza e dell’ebrezza. L’eredità della madre Africa si vede non solo nelle forme e le strutture della musica, ma anche in alcune similitudini tra gli strumenti prescelti: lo xalam della Senegambia secondo molti è il liuto africano progenitore del banjo, e la figura dello xalamkat – il suonatore di xalam – quando non suonano i loro fodet appartengono a una classe umile di lavoratori, dediti all’agricoltura o alla pastorizia. D’altro canto, il diddley bow (il nonno della chitarra bottleneck, come vedremo più avanti), che è stato usato anche da citaristi hawaiani, è uno strumento monocorde che viene direttamente dall’artigianato africano. Perfino gli enormi parti collettivi degli spiritual delle chiese battiste nere potrebbero trovare un loro antenato nella frenesia rituale sudanica, ma dopo aver vagliato tutte le possibilità e aver cercato in tutto l’antenato di tutto la somiglianza più importante che abbiamo rimane sicuramente quella delle finalità e delle funzioni della black music, che mantiene un’impressionante continuità tra l’Africa nera, le galere degli schiavi, gli holler nei campi di cotone, il country blues degli anni ’20, il gospel, perfino l’hip-hop. L’eredità più grande della madre Africa sulla cultura nera è data dallo stampo fortemente sociale e condiviso del momento musicale, un momento che ha il suo simbolo non nel concerto ma nel juke joint, non nella registrazione ma nel mugugnare in coppia, non nel musicista come figura ma nell’intero apparato musicista-luogo-fruitore, un sistema vivo, attivo e generativo che rende l’esperienza musicale unica e potenzialmente infinita.
Durante il colonialismo, le forme e le stanze della cultura mesoafricana saranno strappate via alla madre e sparse in una giovane America miope e razzista, che contaminerà religione e cultura degli schiavi neri e che sarà responsabile diretta di tutti i blues che saranno mai scritti. Dalla difficile e cruda vita da uomini liberi, gli africani deportati dovranno rimanere per diversi secoli sotto la morsa di una difficile e cruda vita da schiavi, con una vita grama e tremenda i cui unici momenti di fuga erano il sesso, le risate, la musica.

Jinte hard, shorty
Sebbene le radici comuni della musica e della cultura nera siano da trovare nell’Africa centro-occidentale, sta di fatto che il Blues (in particolar modo il country blues di cui parlo in quest’articolo) è una musica prettamente afroamericana. Secondo Amir Baraka “Il blues e l’uomo afroamericano sono nati contemporaneamente e sono due facce di una stessa medaglia”. I primi, timidi accenni di quello che sarebbe diventato il blues della Yellow Dog sono nascosti nei canti degli schiavi e delle loro donne.
Che si sappia, da quando gli schiavi afroamericani misero piede sul suolo statunitense cominciarono subito a cantare, un po’ per dare alito al “sospiro della creatura oppressa”, un po’ per mantenere in vita lo spirito di una tradizione musicale democratica che tingeva la tragedia di tinte rassicuranti e nostalgiche.
Le notizie che abbiamo sulla musica degli schiavi vengono comunque da viaggiatori occasionali, da diaristi inesperti di musica che hanno guardato le abitudini e le quotidianità degli schiavi con sguardi paternalistici e pietosi, mai di vero interesse etnomusicologico, ma è tutto quello che ci resta ed è l’unico patrimonio su cui si può basare un qualsiasi lavoro storiografico sull’argomento. Nonostante queste lacune, agli occhi dello studioso risulta evidente che fin dai primissimi esempi di holler (le corn songs, le boat songs, più tardi la musica a capella dei prigionieri di Parchman Farm e dei railway men) la vena dei blue devils è stata sempre presente nell’opera collettiva degli schiavi afroamericani. Gli holler (che in inglese è sinonimo di shout, altro sostantivo “urlante” che viene utilizzato per descrivere una forma di canzone nera) sono le worksongs, i canti da lavoro utilizzati prima degli schiavi, poi dei prigionieri e dei mezzadri, basati su uno schema call-and-response in cui un capo di coro dava battute stereotipate, con luoghi comuni relativi al lavoro che si stava effettuando o alla ricompensa, al cibo, alle donne, per instillare nel coro di lavoratori (la response) l’energia per continuare a faticare la loro fatica, fosse stata raccogliere il cotone, montare binari o spaccare pietre. Oltre ad alleggerire il lavoro degli schiavi e dei mezzadri, i fraseggi delle worksongs servivano a mantenere un ritmo uniforme e serrato e a concludere la giornata al più presto (ci sono, in The Land Where the Blues Began, testimonianze di rustabouts che cantando e oscillando riuscivano a portare in barca pesi di oltre un quintale). Oltre agli hollers, gli schiavi che avevano talento musicale «impararono come intrattenere i bianchi nei balli, nelle feste popolari e nei ricevimenti», ovviamente snaturando del tutto il loro retaggio africano e aprendo a suon di gighe e reel la strada alle caricature dei negroes che avrebbero sbancato nei minstrel show e nei vaudeville, anche se non è improbabile che siano state le prime contaminazioni con la cultura bianca imperante ad anticipare la commistione fangosa che sarebbe nata tra la musica pronipote delle worksongs e la musica pronipote della musica popolare bianca nel Delta del Mississippi. Negli anni della schiavitù ai neri deportati fu presentata e imposta coattamente la religione cristiana dai proseliti missionari e dalle comunità (anche se alcuni schiavi si avvicinavano al cristianesimo spontaneamente per mascherare i propri riti, o come una forma di rispetto nei confronti del “Dio dei vincitori”), la stessa religione cristiana che si sarebbe deformata in quelle correnti battiste e metodiste che fino ai tempi della secessione giustificavano la schiavitù nei confronti degli afroamericani come una “crociata per salvare le anime”. Ironicamente, gli schiavi convertiti si ritrovarono ad essere alcuni dei credenti più ferventi e viscerali di tutto il Nord America, e i loro spiritual sarebbero diventati leggenda, nonché uno dei principali canali comunicativi con cui prendere a fare musica in quanto comunità: esperienze estatiche, esuberanti e inebrianti (sempre in un mare di call-and-response e di improvvisazione vocale) di cui ci restano solo blandi riferimenti qui e lì e qualche testimonianza; una delle antenate della musica del diavolo era, effettivamente, la musica di Dio.
Dopo la guerra di secessione e la fine della schiavitù negli stati del sud la prassi musicale degli oramai mezzadri era piuttosto consolidata, anche per via della sua intrinseca fluidità: le worksongs rimanevano e c’era ancora la divisione tra chanter e coro, i predicatori che facevano da prima voce durante gli spiritual avevano ottenuto alcune riconoscenze e alcuni piccoli lussi (in effetti, molti mezzadri si vendicavano di questo status quo bersagliando i predicatori con feroci e divertenti battute, come testimonia Alan Lomax) e le feste clandestine negli appezzamenti dei padroni bianchi si stavano lentamente trasformando nei famosi juke joint neri di cui parlerò più avanti. Gli afroamericani adesso avevano ottenuto un certo margine di libertà, ma la situazione tragica non sarebbe cambiata granché. Alla guerra di secessione sarebbe seguita la legislazione Jim Crow, alla schiavitù la mezzadria strozzina e criminale dei feudi bianchi, alla minaccia della frusta la minaccia della prigione, dove ti avrebbero frustato.
Ma non tutti i pronipoti degli schiavi se la passavano così male, tra gli ultimi dell’800 e i primi del ‘900. Alcuni di essi avevano la fortuna di vivere più a nord di quella fila di staterelli affacciati sull’atlantico, altri avevano cominciato a integrarsi timidamente in marasmi culturali come quello di New Orleans e personaggi dello spicco di Buddy Bolden, Jerry Roll Morton, W.C. Handy, ‘Ma Rainey, Scott Joplin, avrebbero contribuito a rendere popolare la musica afroamericana dandogli nomi come Ragtime, Jass e Blues.

Classic Blues
I minstrel show erano spettacoli teatrali itineranti durante i quali gli attori bianchi si dipingevano di nero il volto e le mani per assomigliare a dei neri, scimmiottando e ridicolizzando le loro abitudini e le loro movenze. Dopo qualche decennio, intorno agli anni ’50 dell’800, iniziarono a comparire le prime compagnie minstrel afroamericane, dapprima proponendo spettacoli epurati dagli stereotipi, ma poi – dopo essere state acquisite dai proprietari bianchi – tornando sui passi della vecchia commedia tradizionale e razzista. Sebbene i connotati etici di queste manovre siano discutibili, tutti gli storici della musica sono più o meno d’accordo nel trovare in questa esplosione dei minstrel prima l’origine della diffusione e della solidificazione della cultura, della musica e della figura dell’uomo afroamericano. Ma è con l’avvento dei Vaudeville, dei varietà molto più tirosi e coinvolgenti dei minstrel che a volte raggiungevano dei livelli di veri e propri musical, che le più importanti e influenti manifestazioni di quello che da alcuni viene definito Classic Blues sono state elaborate.
Che i primi germi del country blues fossero già presenti nella cultura nera degli stati del sud è un dato di fatto che abbiamo già vagliato (basti vedere le testimonianze delle worksongs lasciate dell’archeologo Charles Peabody), ma fu con le scoperte di alcuni dei più importanti musicisti del Vaudeville che queste gemme grezze di folk rurale sarebbero state rimanipolate e portate al grande pubblico, bianco o nero che fosse. W.C. Handy, il compositore del St. Louis Blues, un importante cornettista e direttore di banda appassionato di J.P. Sousa, perse di vista la sua cotta per le marce quando, nel 1903, alla stazione di Tutwiler, incrociò un uomo con una chitarra che suonava slide con un coltello e che cantava un solo verso, eseguendo ogni volta delle variazioni: I’m goin where the Southern cross the Dog. Il Dog era la Yellow Dog, una delle più importanti linee ferroviarie che attraversavano il delta, e quella canzone improvvisata è il primo blues di cui abbiamo una testimonianza. Con i suoi rag e il suo Saint Louis Blues, Handy contribuì in maniera cruciale a portare questa nuova forma lamentosa di canzone nei Vaudeville e alla creazione di fenomeni commerciali e musicali come Mamie Smith, Sophie Tucker, Marion Harris e così via. Intorno agli anni ’10 la fama del Blues era legata per lo più a questi ambienti ambigui, il tent show, il vaudeville, il cabaret e così via, ed è in quest’humus che maturarono giganti del Classic Blues come Ma Rainey, Ida Cox, e Bessie Smith. La potentissima voce della Rainey, il suo downhome schietto e informale, contribuirono a formare una legione di cantanti nere (prima su tutte la stessa Bessie Smith, che non solo è rimasta la più famosa, ma che a livello musicale è sicuramente la migliore e più eclettica di questo mare di “imperatrici del blues”) che, una volta inciso su disco per una compagnia come poteva essere la Black Swan, sarebbero andate a influenzare profondamente la diffusione del blues nello stesso delta dal quale era stato preso in prestito da Handy nel 1903.
Sì, perché se prima la diffusione della cultura in tutto il paese avveniva con il minstrel itinerante, adesso che le tecnologie di registrazione erano più economiche e cominciavano a comparire i primi fonografi nelle case altoborghesi (bisognerà aspettare il 1927 perché venga venduto il primo juke box): lo sviluppo e la condivisione della musica delle dive del Vaudeville veniva coadiuvata in gran parte dal mercato discografico. È in questo ambiente che si muovevano le varie etichette e i vari appassionati di black music (o di soldi) che durante la seconda metà degli anni ’20 avrebbero (ri)scoperto il country blues e avrebbero dato voce alla musica nera proveniente dalle profondità del Delta.

La scoperta del blues rurale
Effettivamente, dai piedistalli della borghesia bianca i fonografi della Victor cominciarono lentamente a diffondersi (tra la fine degli anni ’10 e l’inizio dei ’20) fino ad arrivare alle misere baracche delle piantagioni del Mississippi. Questa democratizzazione dei fonografi portò alla creazione di una nicchia commerciale del tutto nuova, fatta peraltro da un pubblico che non era abituato al lusso del superfluo e, anche grazie al successo di figure come Bert Williams e l’Original Dixieland Jass Band, la Victor se ne accorse e cominciò a pensare ad una manovra che potesse accalappiare una consistente fetta di mercato che, fino a quel momento di rivoluzione tecnica, era rimasta scoperta. Fu grazie alla voce di una diva come Mamie Smith e al lavoro di Perry Bradford, un negoziante di dischi, che le canzoni del Vaudeville vennero recuperate e diffuse da etichette che sarebbero poi passate alla storia proprio per la produzione e la condivisione di black music, come la OKeh di Otto Heinemann e la Black Swan di Harry Pace, agenzia costituita unicamente da impiegati afroamericani, nata con lo scopo etico di promuovere la musica nera in tutto il paese, da Ethel Waters a Trixie Smith, da Alberta Hunter a W.C Handy. Mentre il colosso Columbia cominciava a registrare e a diffondere all’interno degli appezzamenti rurali i capolavori di Bessie Smith, Black Swan veniva assorbita dalla Paramount: ogni “major” adesso aveva un cavallo di razza nella sua scuderia (la Paramount aveva Ethel Waters, la Columbia aveva Bessie Smith, la Okeh Mamie Smith e Sara Martin), il classic blues aveva riempito il paese del suo stereotipo, con i dischi più che con i vaudeville, e i talent scout avevano annusato nell’aria una certa voglia di cambiamento. Nella seconda metà degli anni ’20 uno degli scout segnalò alla Paramount il nome di Blind Lemon Jefferson, e la musica dello Yellow Dog che era stata strappata al Delta dalle mani delle dive del vaudeville e che finora era stata solo registrata – senza troppo successo commerciale – dalla Okeh nella prima metà degli anni ’20 (in particolare con i guitar rag di Sylvester Weaver) entrò nel circuito discografico, e i rag chitarristici strimpellanti di piedmont cominciarono a farsi sentire nei fonografi del Delta, influenzando una quantità enorme di musicisti e permettendo all’industria culturale del blues rurale di espandersi. Il successo di Blind Lemon a quanto pare portò a «una smodata caccia all’oro, dove il metallo prezioso era rappresentato da musicisti altrettanto sconosciuti e magari più bravi di Blind Lemon», e la follia espansionistica della musica su disco cominciò velocemente a snaturare la forma situazionista e libera della stanza blues, censurando i versi troppo sconci e lasciando ai posteri il fumoso immaginario del country blues costruito dai soliti moduli di I woke up this morning, dodici battute da sviluppare in tre minuti e pesanti fruscii di fonografo, senza che la creatività del bluesman, del duo o del gruppo potesse esprimersi attraverso quel legame musicista-luogo-fruitore che tanto spesso accompagnava la quotidianità nera nel Delta del Mississippi. Dopo una prima ondata di euforia durata tutta la fine degli anni ’20, la parabola dell’industria discografica black si interruppe bruscamente nel 1929, per poi ricominciare a registrare i singoli degli esponenti di una “seconda generazione” di bluesmen (anche se a livello anagrafico e storico si parla comunque di persone che erano nate intorno ai primissimi anni del 1900 e che avevano cominciato a suonare di solito nei primi anni ’20) verso il ’33-’34. Le date di registrazione, però, non fanno veramente fede alle effettive date di attività dei musicisti, e i nomi che contiamo nelle nostre collezioni discografiche rappresentano solo una piccola frazione, la più famosa – ma non necessariamente la più valida – di musicisti neri che hanno imbracciato chitarre, banjo, armoniche nel Delta. Il blues rurale, come si può leggere nelle pagine di The Land Where the Blues Began permeava profondamente tutta la cultura dei mezzadri: non era certo nato nel 1926 e non aveva certo chiuso i battenti durante la crisi del ’29. Blind Lemon e Bessie Smith non avevano estirpato il razzismo, e la disponibilità dei fonografi non aveva reso obsoleti i juke joint: nelle piccole città del Delta, la cultura del country blues era sempre stata presente e ben viva, e anche quando cominciarono a puntarle sopra i riflettori, non si ritirò a guscio, ma continuò imperterrita a venare tutta la vita sociale dei pronipoti degli schiavi.

Cenni di cultura
Una delle città più vive del Delta (insieme a Memphis) era Clarksdale, che da quando aveva avuto la sua stazione ferroviaria era diventata una delle “capitali” della ricca terra del cotone. La sua zona più importante era un quartiere nero, ghetto residuo delle leggi Jim Crow che veniva chiamato ironicamente Nuovo Mondo dai lavoratori delle piantagioni. Lomax parla di strade affollatissime e piene di gente, per lo più neri che avevano voglia di divertirsi nel bimestre che andava dalla semina al raccolto e in locali e bar come il Dipsie Doodle o il Chicken Roost musicisti come David ‘Honeyboy’ Edwards imbracciavano la chitarra e ripetevano la magia nera dei loro padri, coinvolgendo nel call-and-response delle worksongs (adesso dedito all’ozio e al divertimento) le donne e gli uomini del pubblico. In un’atmosfera piena di sudore ed alcool illegale si ripeteva per l’ennesima volta un rito comunitario che aveva le sue radici nei locali di ragtime di fine ‘800 e si sarebbe allungato fino alle mosse primitiviste della blues house party del Poppa Jazz di William Ferris e fino alle feste urbane dei locali honky-tonk. Un juke joint era una forma di rito fluido e incredibilmente coinvolgente che annodava al suo interno la presenza massiccia di alcool, dei soldi del sabato dei lavoratori di piantagione, di qualche musicista blues e di un pubblico fortemente protagonista e reattivo, di solito con uno sgangherato coro di donne a fare la corte al cantante e diverse coppie di ragazzi che ballavano fino allo sfinimento, costringendo i musicisti ad arrampicarsi su improvvisazioni sempre più lunghe e dionisiache per tenere il ritmo dei passi di danza dei loro destinatari, utilizzando un retaggio umoristico e sconcio che veniva dalle gare di insulti, di luoghi comuni e di barzellette.
L’insieme di battute e leggende costituiva tutto il bagaglio culturale dei neri del Delta, che non avevano grandi possibilità d’istruzione ma che potevano passare la breve infanzia che avevano (molti di loro “diventavano adulti” anche prima dei dieci anni) a raccontarsi vecchie storie e a gareggiare in giochi di parole. Le forme legalizzate di mezzadria e di strozzinaggio rendevano la vita dei lavoratori di piantagione un mezzo inferno, con una legislazione razzista e priva di qualsiasi copertura (uccidi un mulo, ne compri un altro, uccidi un negro, ne compri un altro), con la tremenda prigione di Parchman Farm sempre dietro l’angolo (e dall’esperienza delle prigioni Lomax avrebbe tirato fuori alcuni dei suoi resoconti più commoventi, nonché musicisti del calibro di Leadbelly) arrivando a creare un sistema socioeconomico che molti storici avrebbero definito come un nuovo feudalesimo del Delta e fenomeni criminosi come quello del linciaggio di massa a Tupelo di cui canta il rapsodo cieco Turner Johnson in The Land Where the Blues Began. Senza scendere troppo nel dettaglio sui particolari di una società e di un gruppo etnico ormai scomparsi da decenni (se avete interesse di approfondire – e vi assicuro che ne vale la pena – basta fare un giro sui libri in bibliografia) si può comunque cominciare a identificare la funzione di una musica che ha avuto la sua esplosione in un’epoca ben precisa, quella dei joint, dello sconcissimo slow drag, della ferrovia, del fiume e dei jitterbug fatti in casa: la musica del diavolo, ribattezzata così a causa delle sue tematiche, dei suoi strumenti e della sua mitologia, al pari della musica di Dio (di cui parleremo poco più avanti) aveva per i suoi ascoltatori una doppia finalità: il primo effetto era un purissimo distillato di divertissement, la forma più adatta di musica per fare musica, per ballare, per poter inibire il cervello e dimenticarsi momentaneamente, in preda dei fumi dell’alcool e dei versi delle donne, del lavoro bruto che sarebbe dovuto tornare a inizio settimana, delle vessazioni dei capi bianchi, del rischio sempre presente della morte violenta o della prigione, con testi che se in superficie trasmettevano e descrivevano quest’ansia trasposta magari nell’ennesima baby infedele, su un piano di lettura più profondo (quando si era sicuri che nessun bianco stesse ascoltando) criptavano feroci messaggi contro la classe di dominatori bianchi responsabile di questa tragica situazione socioculturale.
L’altro fine del country blues si sviluppava su un altro livello, e non era raccontato all’interno delle canzoni né durante i live: era un disperato appello alla speranza, la speranza che attraverso il musicare itinerante e attraverso le roche urla che accompagnavano i virtuosi della chitarra qualcuno si sarebbe accorto della situazione drammatica degli stati del Sud e che attraverso la diffusione e la vendita di dischi la controcultura nera avrebbe potuto conquistare una nuova forma di dignità forte che avrebbe permesso ai suoi componenti di ascendere lentamente verso una posizione sociale meno precaria e più rispettabile. La scoperta del blues rurale da parte delle major della black music (di cui ho parlato poco prima) è stata, effettivamente, un passo importantissimo nella storia dell’emancipazione afroamericana. Il lascito dei suoi protagonisti è ancora palpabile, e i loro blues sono tutti inscatolati nelle varie raccolte che abbiamo ancora oggi la facoltà di ascoltare.

I primi
Blind Lemon Jefferson era nato a ovest del Delta, in Texas, nel 1893. Cieco di nascita, cominciò a suonare nelle cittadine del Texas orientale da adolescente; a causa del suo handicap era l’unico modo che aveva per guadagnare qualche soldo, e durante la sua carriera, dopo essersi spostato a Dallas per suonare agli angoli delle strale e nei bordelli di Deep Ellum, fece la conoscenza di bluesmen che avrebbero registrato solo molto dopo (negli anni ’30) come T Bone Walker e Leadbelly. Negli ultimi mesi del 1925 fu scoutato dalla Paramount e nei primissimi mesi del 1926 uscirono i suoi primi singoli, Booster Blues, Dry Southern Blues, Long Lonesome Blues, Got The Blues, e così via. La sua voce acuta e il suo virtuosismo chitarristico e compositivo, come abbiamo visto, aprirono la strada alla registrazione di decine di altri musicisti, e permetterono alla Paramount di mettersi in competizione con altre label nere come la Okeh (con la quale avrebbe cominciato a registrare nel 1927) e la Columbia. Jefferson, pur essendo stato il primo grande bluesman ad essere registrato dopo musicisti come Sylvester Weaver, Papa Charlie Jackson o Daddy Stovepipe, non aveva nulla della figura del povero musicista che è rimasta nello stereotipo del Delta blues: conduceva una vita da star, si comportava come un dandy e vestiva elegante, mangiava molto e a quanto pare era anche un buon donnaiolo. La sua musica era nuova e vecchia allo stesso tempo (mai registrata, eppure appartenente a un patrimonio tradizionale che tutti conoscevano) e la sua voce era cristallina e flessibile; il suo fingerpicking fu molto influente nello sviluppo del blues del Delta e texano che non si appoggiava ad una base rag alla Piedmont. Morì assiderato in una tormenta di neve nel 1929, lasciandoci, con i suoi complete recordings, una collezione di alcuni tra i blues più belli della storia, come il Match Box Blues, l’Easy Rider Blues e Where Shall I Be.
Le tracce di Charley Patton, invece, portano ancora più indietro. Nato sotto l’egida di Henderson Chatmon tra il 1887 e il 1891 nella provincia di Edwards, Mississippi con un retaggio afroamericano-cherokee e patrocinato da una figura imponente come quella di Henry Sloan, si dice che abbia composto il suo Pony Blues a 19 anni (quindi tra il 1906 e il 1910) e che già negli anni ’10 fosse una figura di riferimento nell’ambiente musicale nero degli stati uniti del sud. Già prima delle sue registrazioni tardive (le prime concluse nel 1929) Patton si era guadagnato il posto di uno dei chitarristi più influenti della storia, grazie tanto ad acrobazie da showman come suonare la chitarra dietro la testa o in ginocchio sulle assi di legno quanto alle sue seminali doti da strumentista e cantante. Morì nel 1934, ma il lascito che donò alla musica fu ben più grande di un paio di giochi da palcoscenico e della creazione della figura mitologica nomade e diabolica del bluesman: il suo stile chitarristico fortemente percussivo e le sue acrobazie compositive furono un’ispirazione essenziale per pezzi da novanta come Tommy Johnson, Son House, Robert Johnson, mentre la sua voce roca e profonda attirò (direttamente o indirettamente) generazioni di cantanti, da Blind Willie Johnson a Howlin’ Wolf. La sua influenza e la sua fama non si fermano nell’ambito del blues del Delta, e le sue virtù furono riconosciute da artisti del calibro di Bob Dylan e (soprattutto) Blind Joe Death/John Fahey (che si laureò con una tesi su Patton). La raccolta Screamin’ and Hollerin’ the Blues rappresenta a oggi uno dei documenti più completi che abbiamo su un singolo artista come Patton, una raccolta esaustiva e commovente che al suo interno raccoglie alcuni dei pezzi più genuinamente belli della storia del country blues, dal già citato Pony Blues alla concitata Shake it and Break it, dalla slap guitar del Jersey Bull Blues al tristissimo Devil Sent the Rain Blues.
Della figura di Blind Blake, invece, si sa poco o niente. Gli unici punti fissi della sua biografia sono le date di nascita (1896), registrazione (1926-1932) e morte (1934). Sarebbe nato in Florida, a Jacksonville, e i suoi impegni discografici l’avrebbero costretto a spostarsi a Chicago. Sarebbe morto nel ’34 a Glendale per un caso di tubercolosi polmonare. Dalle registrazioni di Blind Blake si riescono a indovinare senza troppe difficoltà le sue doti da virtuoso. Funambolo della chitarra e cantante eccellente, solo uno strumentista veloce e creativo come lui avrebbe potuto portare ad un punto così alto il blues delle colline di Piedmont inaugurando di fatto la corrente del Piedmont Blues, una forma di blues rurale che si appoggiava su una chitarra pizzicata con uno stile elaborato e complesso che faceva il verso al pianismo honky-tonk del ragtime e i cui esponenti più famosi sono stati lo stesso Blind Blake, Blind Willie McTell e i posteriori Blind Boy Fuller e Blind Gary Davis. Riuscì ad incidere blues con una chitarra stride la cui ombra si è proiettata su un’intera generazione di chitarristi ragtime. Nella famosa raccolta Ragtime Guitar’s Foremost Fingerpicker c’è un’ottima selezione dei suoi singoli più belli, spesso accompagnati dalla voce di Leola Wilson: con pezzi come Skeedle Loo Doo Blues, Blind Arthur’s Breakdown e Police Dog Blues Blake dimostra di essere pienamente all’altezza dei suoi seguaci.
Meno specifico e più eclettico fu Lonnie Johnson, un vero e proprio genio della chitarra che è nato nell’ultimo decennio dell’800 e che ha vissuto una vita molto più lunga della media dei primi country bluesmen (è riuscito a tirare a campare fino al 1970). Effettivamente, l’etichetta “bluesman” non è molto adatta per un artista polimorfo e creativo come Alonzo Johnson: sebbene le sue prime registrazioni siano state buttate giù nel 1925/1926 con la Okeh e fossero degli effettivi blues, la sua chitarra ha spaziato con versatilità tra il ragtime, il jazz e lo swing (ha registrato addirittura con Louis Armstrong e gli Hot Five, e più tardi con Duke Ellington) ed è stato anche un grande violinista jazz. Il suo è stato un nome di spicco per tutti gli anni ’20, e oltre alle session con Armstrong ha avuto anche il modo di accompagnare una diva del blues classico come Bessie Smith. Chitarrista da plettro, al contrario di Blind Blake, la sua influenza sembra essere stata decisiva per la linea di chitarristi blues che come al solito arriva alla leggenda di Robert Johnson, ma il vero punto forte della carriera di Lonnie Johnson non è tanto nella collocazione in un contesto storico preciso (anche perché a causa della sua longevità ha avuto il modo di barcamenarsi in qualsiasi genere e in qualsiasi tipo di contesto storico) ma – semplicemente – nella sua musica: la sua raccolta Steppin’ on the Blues conserva alcune delle perle più splendenti della sua discografia, il Mr. Johnson’s Blues, l’eponima Steppin’ on the Blues (che conserva una delle parti di chitarra più tirose della storia del blues), Have to Change Keys e il rag jazzato di 6/88 Glide.
Gli uptempo di Barbecue Bob erano lontani tanto dalle nenie acute di Lemon quanto dalla commistione di Blues e Jazz di Lonnie Johnson, e si avvicinavano ad un blues che oggi definiremmo molto più pop e sicuramente di ascolto più facile. Non per questo le sue esecuzioni restano meno magistrali (sebbene siano state per certi versi meno influenti). In Chocolate to the Bone, una raccolta di brani registrati nel 1927, lo stile di Barbecue Bob (al secolo Robert Hicks) viene sviscerato e presentato agli ascoltatori degli ultimi anni del ventesimo secolo in una ventina di brani spettacolari, come al solito rinchiusi nel recinto dei tre minuti. Ad Atlanta la sua chitarra a dodici corde divenne presto leggenda, e il suo stile da banjoista alternato a grandi momenti di bottleneck lo resero uno dei musicisti da juke joint più amati della città. La sua discografia contiene capolavori del country blues come il concitato Motherless Chile Blues, lo Yo Yo Blues, che con una velocità estrema nei bottleneck e degli accenni di slap guitar riusciva ad essere profondamente originale nella camicia di forza dei twelve bar, e l’omonimo Barbecue Blues, forse uno dei suoi brani più famosi e belli. Il suono argentino della sua chitarra a dodici corde sarebbe stato di grande ispirazione per un altro musicista di grande spessore come Blind Willie McTell, che avrebbe cominciato a registrare un anno dopo.
Tommy Johnson, nato nel 1896 a Terry e morto nel 1956 a Crystal Springs, era l’originale bluesman del patto col diavolo, spesso confuso con Robert Johnson per motivi di parziale ominimia (ma zero parentela). Al di là delle speculazioni sul voodoo o sui mojo, la musica di Tommy Johnson era di una qualità bestiale, altissima e molto avanti coi tempi. Più che dal diavolo il suo chitarrismo era stato influenzato dalle figure di Charley Patton e Willie Brown, con il quale aveva avuto degli effettivi contatti, ma la sua musica era spesso completamente alla deriva rispetto ai rapidi volteggi sabbatici dei suoi maestri, e il suo struggente falsetto era quanto di più lontano ci potesse essere dal roco e rozzo preaching pattoniano, ma anche dalla voce chiara e liquida di Blind Lemon. Un pezzo incredibile come Cool Drink of Water Blues (brano che peraltro verrà omaggiato dai Gun Club in Fire of Love) risulta quasi strano ad un ascoltatore di blues, con i suoi versi staccati dalla successione AAB e con la sua voce acutissima che sembra sul punto di cadere da un momento all’altro. I suoi brani registrati con Victor e Paramount sono conservati nei suoi complete recordings e nelle sue raccolte: lo stile incespicante e fragile di brani come il già citato Cool Drink of Water Blues e Lonesome Home Blues è quasi avanguardistico ed è uno dei richiami più chiaramente riconoscibili in pietre miliari del blues un po’ più tardo come i recordings di Robert Johnson; d’altro canto brani del calibro di Sliding Delta e di Morning Prayer Blues non fanno che alimentare la leggenda del crocicchio e del diavolo. Nel sorriso quasi beffardo e strabico di Tommy Johnson serpeggia la fiamma della musica del diavolo, che sarebbe divampata per un altro decennio scarso nella vita nomade e dissoluta dei chitarristi che attraversavano Memphis e che sognavano Chicago, ma dall’altro lato della ruota la musica nera non aveva nessuna voglia di essere identificata con le fiamme dell’inferno, e le dodici battute venivano usate per cercare la grazia. In effetti, forse molti dei reverendi che sfruttavano (magari inconsapevolmente) la musica “del diavolo” non avrebbero trovato la grazia, ma le loro registrazioni a volte rappresentano uno degli stili musicali più belli e commoventi che siano mai usciti dagli stati del sud.

Dio e le sue voci
La questione della religione nella black music è una roba vecchia, molto più vecchia di Sylvester Weaver e della Yellow Dog, e le sue radici arrivano fino ai secoli della schiavitù, in parallelo al pigro sviluppo delle worksongs. Il legame tra la religione cristiana e la massa di schiavi provenienti dall’Africa centro-occidentale era a doppio filo, a volte piuttosto ambiguo e non sempre ben delineabile. Nel corso degli anni la religione è stata a volte introdotta in modo coercitivo nella vita degli schiavi, a volte è stata abbracciata spontaneamente e per questioni culturali e per la ricerca ossessiva di una redenzione che nel mondo terreno non arrivava, di una morale degli schiavi che avrebbe prima o poi riportato uguaglianza e distribuito punizioni sull’oppressore. Per una buona fetta della popolazione nera, la cultura ecclesiastica si distribuiva su un’asse diversa rispetto a quella della mezzadria, del joint e del country blues: spesso i riti metodisti e battisti del sud erano occupati da un lato da figure di gran spicco come i ministri della chiesa e i pastori e dall’altro da un pubblico di fedeli formato per lo più dalle frange femminili di ogni età della società nera. L’ingombrante presenza di coriste, donne anziane e ragazze ha fatto sì che alcuni etnomusicologi vedessero nel rito ecclesiastico il completo contraltare dell’honky tonk e del juke joint, momenti di condivisione che erano destinati per lo più agli uomini gravati dal lavoro e alle donne libere che facevano loro da controcanto. Effettivamente è comodo smussare le varie venature della storia della musica per trovare dei tipi ideali confortevoli e facili da usare, ma i documenti che abbiamo ci dicono che la comunità degli antichi spiritual di cui parla Lomax (che si distinguono dai gospel, una forma di musica molto più incamiciata, meno africana e concitata) è anche formata (e soprattutto guidata) da uomini e le registrazioni che ci rimangono di musica rurale religiosa conservano alcuni duetti uomo-donna che sono tra i più bei pezzi della storia della musica per chitarra degli stati del sud.
Sebbene il tema degli spiritual sia stato caro a vari bluesmen che hanno avuto una carriera più all’insegna del diavolo che dell’acqua santa (basti vedere le raccolte di gospel di Fred McDowell, le prime registrazioni di Blind Lemon sotto lo pseudonimo di Deacon Bates, o più semplicemente la quantità di When the Saints nei singoli dei bluesmen dell’epoca) pochi musicisti erano effettivamente legati alla comunità cristiana del Delta e degli stati confinanti. I più importanti (non gli unici: ricordiamo tra gli altri Robert Wilkins e Pearly Brown) erano Reverend Gary Davis e Blind Willie Johnson.
Gary Davis è nato nel 1896 e ha avuto una vita molto longeva. Imparò presto a suonare la chitarra seguendo lo stile di Piedmont, l’armonica e il banjo e in North Carolina collaborò con Blind Boy Fuller e il suonatore di washboard Bull City Red, e la sua carriera durò fino alla fine degli anni ’30, quando diventò ministro della chiesa battista e cominciò a suonare gospel. Gary Davis non ha registrato durante il boom discografico della fine degli anni ’20, sebbene fosse già attivo. Di lui abbiamo una serie di album registrati durante il revival folk degli anni ’60 che non essendo stati registrati negli anni ’20 o ’30 non hanno i difetti dei fonografi dell’epoca, riescono a portare su disco i suoi brani ad una qualità alitissima e ci permettono di apprezzare a pieno il suo virtuosismo chitarristico. Brani come Samson and Delilah dipingono storie lontane dalla tradizione poetica del country blues e riproposte in un uptempo tirosissimo che ha le sue radici nel fingerpicking di Blind Blake ma che riesce con molto poco a superare e ad aggiornare lo stereotipo del piedmont blues derivato dal ragtime. Brani come Pure Religion e Death Don’t Have no Mercy dimostrano che a suo tempo sarebbe stato possibile dare un forte scossone al country blues senza la necessità di trasferirlo in città, a Chicago, e di snaturarlo e contorcerlo rinchiudendolo nel blues amplificato elettricamente di Muddy Waters. Gary Davis è morto nel ’72. Samson and Delilah, uno dei suoi brani più belli, era If I Had My Way di Blind Willie Johnson, il chitarrista gospel più grande della storia.
La vita di Blind Willie Johnson non è stata esattamente tranquilla: nato vedente nel 1897 dalle parti di Brenham, in Texas, a cinque anni si costruì una cigar box guitar e disse a suo padre di voler diventare predicatore, e qualche anno dopo la morte di sua madre la sua matrigna gli buttò dell’acido in faccia, facendolo diventare cieco. Tra due matrimoni, passò la sua vita sempre sul ciglio della povertà, cantando agli angoli delle strade del Texas e quando la sua casa fu buttata giù da un incendio nel 1945, passò gli ultimi giorni della sua vita in un letto bagnato a morire di febbre malarica (sul certificato di morte si cita anche la sifilide, ma siccome negli stati del sud la sifilide era vista come la “malattia base” degli afroamericani questa documentazione è incerta). Registrò trenta brani in cinque sessioni separate per la Columbia dal 1927 al 1930, con un bottleneck e una vocalist sconosciuta (alcuni pensano che fosse sua moglie). Nelle session per la Columbia, raccolte nel box set The Complete Blind Willie Johnson ci sono alcune delle registrazioni più belle e potenti della musica blues-related e della musica in generale. Il famosissimo mugugnare di Dark was the Night Cold was the Ground ha affascinato generazioni di musicisti, l’esplosiva If I Had My Way si dice abbia scatenato una rivolta a New Orleans per la quale il Blind Pilgrim sarebbe stato arrestato, i duetti di I’m Gonna Run e John the Revelator convertirebbero l’anima di un ascoltatore (pezzo di merda) che non trova nulla in Robert Johnson e gli estatici ruggiti di Jesus is Coming Soon, più profondi di quelli di Charley Patton e molto diversi da quelli di Armstrong, avrebbero ispirato decine dei cantanti dentro e fuori il Delta, da Howlin’ Wolf a Don Van Vliet e Tom Waits. Nell’ombra della slide guitar e del growl l’anima di Blind Willie Johnson stava sicuramente macinando chilometri verso il paradiso, ma per ogni santo ci sono cento peccatori e mentre il pellegrino registrava i suoi successi con la Columbia per un pugno di soldi, il Delta si riempiva di “generi del Diavolo”. Le case discografiche avevano capito che registrare quei mezzadri fruttava non poca pecunia, e negli anni immediatamente precedenti e successivi la crisi riuscirono a trovare una quantità impressionante di rapsodi in giro per gli stati del sud che con le loro registrazioni avrebbero invaso i fonografi di tutti gli stati uniti.

Il Delta si copre di dischi
Due sono i periodi di massima della produzione discografica di country blues: il primo interessa il biennio 1928-1929 (alcuni in realtà registravano già dal ’27), subito prima della crisi, e rappresenta la venuta alla ribalta di tutti i chitarristi che magari suonavano già da tempo nel Delta e che, spinti dal successo commerciale di pezzi da novanta come Blind Lemon Jefferson, sarebbero stati scoutati da aziende come la Paramount o la Okeh e in quattro e quattr’otto sarebbero finiti a registrare qualche singolo. Il secondo, invece, è il lasso di tempo che va dai primi anni ’30 dell’uscita dalla crisi fino, più o meno, alle date di registrazione dei singoli di Robert Johnson, che per molti storici rappresentano un po’ la chiusa appropriata di un’epoca e di tutta una corrente musicale. Avendo già considerato più volte che non si può dare una cronologia veramente adeguata delle composizioni di blues rurale (magari delle registrazioni sì, ma è un lavoro gravoso e con non pochi scogli) sarà meglio evitare di cercare l’accuratezza totale del dettaglio e limitarci a citare una parte del mezzo centinaio di nomi di musicisti country blues, soffermandoci sui più importanti.
Peg Leg Howell aveva perso la gamba destra per un colpo di pistola e ad Atlanta per un periodo diresse i Peg Leg Howell & His Gang. Registrò alcune sessioni per la columbia nella seconda metà degli anni ’20 che sono raccolte nei Complete Recordings della Matchbox Records: i suoi brani migliori sono quelli dove è accompagnato da Eddie Anthony e Jim Hill nelle registrazioni del 1928-1929, in particolare il Too Tight Blues e il Ball and Chain Blues, e alcune delle registrazioni più vecchie, come lo Skin Game Blues e il suo Peg Leg Stomp. Furry Lewis, una figura che sarebbe arrivata a stregare la Joni Mitchell di Hejira, era invece di Greenwood e fu uno dei primi country bluesmen ad essere scoperti durante il revival degli anni ’60, ma già negli anni ’20 era un genio. Aveva avuto occasione di suonare con nientemeno che W.C. Handy, e i suoi viaggi lo esposero all’influenza dei più famosi musicisti blues, da Bessie Smith a Blind Lemon. Nella seconda metà degli anni ’20 ebbe modo di registrare da solista e poi con la Memphis Jug Band per la Victor ed entro l’anno della crisi riuscì a mettere su disco alcuni singoli che nel tempo sarebbero diventati leggendari. Il suo stile, che spaziava senza troppa difficoltà tra il fingerpicking alla Piedmont e la slide guitar discendente dai jitterbug ha regalato ai posteri grandi brani come la sua versione di Casey Jones e il suo Jellyroll, entrambi presenti nella sua comp più famosa: Furry Lewis in his Prime, che contiene le registrazioni del 1927 e del 1928.
Leroy Carr sarebbe rimasto uno dei pianisti blues più famosi e influenti della storia: nato nel 1905 a Nashville, dopo un’adolescenza turbolenta diventò un vero e proprio “professionista dell’intrattenimento”, e invece di suonare nei juke joint il suo piano strimpellava nelle feste private di Indiana Avenue a Indianapolis. Il suo sodalizio con il grande chitarrista Scrapper Blackwell diede vita ad alcune delle registrazioni più belle e melancoliche della storia del piano blues. Nonostante si fosse tenuto piuttosto alla larga dalla vita dissoluta e incasinata del chitarrista del Delta, Leroy morì per colpa dell’alcol nel 1935. La sua finezza compositiva e la sua voce argentina e berciante sono conservate, insieme con i contrappunti di Scrapper Blackwell, in raccolte come Blues Before Sunrise, che ci riportano alcuni dei loro brani più pesi, come il Midnight Hour Blues e Hurry Down Sunshine. Sempre nel 1927 registrava Ed Bell, di cui ci rimangono i Complete Recordings (1927-1930). Nato nel 1905 a Forrest Deposit e morto nel 1960 a Greenville, sebbene sia stato apprezzato da vari appassionati di country blues, i suoi contributi all’evoluzione della musica sono piuttosto poveri ed eccessivamente tipici: i suoi singoli più venduti come il Mamlish Blues rimangono comunque un buon documento e sollevano un certo interesse per lo studio delle registrazioni più vecchie della prima ondata del blues rurale.
Big Bill Broonzy, al contrario, sarebbe diventato col tempo uno dei bluesmen più famosi della storia, grazie anche ad assist abbastanza importanti come quello di Muddy Waters (il cui primo disco è Muddy Waters sings Big Bill Broonzy) e alla sua tenacia e capacità di reinventarsi: cominciò a registrare nel 1928 per la Paramount, ma lavorò come musicista fino alla sua morte (1958) e molti suoi dischi furono rilasciati postumi nel boom degli anni ’60, tra i quali compare anche il suo fratellastro, Washboard Sam. La comp The Young Big Bill Broonzy è il miglior documento che abbiamo sull’epoca che ci interessa: raccoglie infatti tutti i singoli usciti per Paramount, Vocalion, Blue Bird dal 1928 al 1935. Vale la pena ascoltarsela tutta. Sempre rimanendo nel limite del 1928/1929, i Complete Recorded Works in Chronological Order di Ishman Bracey (1901-1970) sono un importante lascito di un bluesman relativamente poco conosciuto, il cui stile vocale lascivo e traballante che ha il suo punto più alto nel bellissimo Woman Woman Blues.
Blind Willie McTell, invece, è rimasto uno dei bluesmen più famosi gli stati del Sud. Nato nel 1898 a Thomson, in Georgia, imparò presto a scrivere e leggere musica in Braille e negli anni ’20 cominciò a suonare nei cornerstreet di Atlanta. Il suo virtuosismo nel fingerpicking (suonava Piedmont), la sua bella voce da tenore e la sua chitarra a dodici corde lo resero appetibile agli occhi della Victor e già nel 1927 cominciò a registrare – e i suoi brani si diffusero fino al Delta e al Texas. L’influenza di Blind Willie McTell si estende soprattutto agli ambiti spuri del blues: i suoi brani più famosi furono oggetto di cover da parte degli Allman Brothers (lo Statesboro Blues) e addirittura da quei cafoni dei White Stripes (Southern Can Is Mine, in De Stijl). Al di là del seguito un po’ troppo ingombrante e casinaro, Blind Willie McTell era un grandissimo musicista e con il suo chitarrismo a 12 corde non aveva nulla di invidiare a quello di Barbecue Bob. Nella grossa raccolta The Classic Years 1927-1940 ci si può sguazzare per ore, senza paura di limitarsi ad ascoltare i suoi brani più famosi (e sputtanati). Da Kind Mama a Scarey Day Blues, da Atlanta Strut a Hillibilly Willie, una mente creativa e una voce importante come quella di Blind Willie McTell stancano difficilmente.
Un altro nome molto importante, che avrebbe contribuito a diffondere l’uso del bottleneck era quello di Tampa Red. Non era certo l’inventore della slide guitar (il bluesman della Yellow Dog descritto da Handy suonava con un coltello, per dire, e i diddley-bow erano uno strumento antico), ma la sua fama e la sua abilità, che gli regalò il titolo di Guitar Wizard, furono essenziali per la crescita del bottleneck nel blues di Chicago. Sebbene i suoi contributi più famosi e importanti furono i brani registrati nella seconda metà degli anni ’30 e negli anni ’40 con Big Maceo, Tampa Red cominciò a registrare già nel 1928, e la sua raccolta Bottleneck Guitar 1928-1937 ci dà uno scorcio di come suonavano i suoi slide nel tempo di Scrapper Blackwell e Furry Lewis. Formidabile, invece, era il fingerstyle di Mississippi John Hurt, uno dei Delta bluesmen più dotati della storia. Nato a Teoc nel 1892 e cresciuto ad Avalon, passò la sua infanzia suonando e lavorando in piantagione e solo nel 1928 fu notato dalla Okeh che gli permise di registrare i suoi Avalon Blues. I suoi pick di chitarra furono fondamentali quanto quelli di Charley Patton nella formazione di un chitarrista come Fahey, ma al di là della sua importanza storica, come al solito, la musica stessa di John Hurt rimane uno dei suoi regali più belli alla storia dell’umanità: nella piccola raccolta Avalon Blues sono concentrati i recordings del ’28 per la Okeh, e vale la pena di ascoltarli per intero (sono solo tredici), perché insieme costituiscono un vero e proprio capolavoro.
Gli anni ’20 passavano rapidamente sotto i colpi del fonografo e strumentisti come il banjoista Gus Cannon, il pianista Roosevelt Sykes, i chitarristi Pink Anderson e Frank Stokes venivano assoldati dalle case discografiche, in preda alla sbornia del grande successo del country blues. Nel ’29 ci fu però il crollo di Wall Street, ad esso seguì la grande depressione e alla grande depressione seguì un fortissimo calo delle vendite che costrinse al minimo gli investimenti delle varie Paramount e Columbia che infestavano gli stati del Sud. Quando qualche anno dopo si ricominciò ad avere interesse per il blues rurale il testimone era stato passato ad un’altra generazione, e in giro rimanevano solo alcuni degli artisti che abbiamo ascoltato (ad esempio Blind Willie McTell e Big Bill Broonzy), mentre una “nuova generazione” di musicisti, non necessariamente anagraficamente più giovani veniva scoperta dai talent scout. Fu dal 1930 in poi che la maggior parte di essi venne registrata, ma a quel punto il richiamo urbano di Chicago era già piuttosto forte, e gli stilemi del Delta andavano lentamente scemando e facendosi spuri.
Sleepy John Estes veniva chiamato così perché soffriva di epilessia. Che si sappia, viveva come musicista di strada a Brownsville e con Yank Rachell e Jab Jones formò una Jug Band (fenomeno che andava piuttosto di moda all’epoca, si vedano i Mississippi Sheiks o la Memphis Jug Band). Sebbene abbia inciso anche nel 1929 la maggior parte delle sue registrazioni risalgono al lustro tra il 1935 e il 1940, per Champion e Decca. Dopo una lunga carriera e una lunga vita (morì nel 1977) le sue prime registrazioni sono state raccolte dalla Document nei suoi Complete Recordings. Di ben altra caratura era invece la persona di Son House, mezzadro di bell’aspetto che fu scoperto dalla Paramount nel 1928 (anche se registrò e non pubblicò alcuni brani per la Columbia nel 1927). Eddie House aveva un passato da preacher che si riflette pienamente nel suo stile musicale, innovativo e distaccato dagli stereotipi del country blues che erano sopravvissuti fino agli anni ’30. House ebbe la fortuna di incontrare personaggi di un peso non indifferente, come Willie Brown e soprattutto Charley Patton, che riuscì tramite i suoi contatti a proporgli l’ingaggio alla Paramount. L’intensità e la passione di Son House sono tra le più potenti e sincere del folk blues e il suo amore per la musica gli permise anche di trasmettere qualche insegnamento a Robert Johnson, che quando Son House suonava era ancora un ragazzino. Eddie è stato uno degli uomini più intervistati di tutto il Delta, un po’ per la sua longevità (visse fino al 1988) un po’ per la sua personalità aperta al dialogo ed estremamente gentile, quindi al suo volto si associa senza troppo sforzo la voce narrante del Delta, delle sue difficoltà (come ho scritto è stato un lavoratore stagionale), del suo apartheid e della sua storia musicale. Di lui ci rimangono un pugno di registrazioni le cui più importanti sono raccolte nei Complete Recordings 1929-1934 e soprattutto nel suo capolavoro, l’LP Father of Folk Blues uscito sotto Columbia nel 1965. Nella storia del blues tutto le eco di Grinnin’ in Your Face, Leevee Camp Moan e Death Letter sono tra le più potenti e vive, tutt’oggi.
Skip James diceva di essere «uno degli uomini migliori che abbiate mai conosciuto». Nato a Yazoo City nel 1902, James fu uno degli artisti più consumati dal revivalismo degli anni ’60; da bambino suonava il piano e la chitarra e intorno al 1918 cominciò ad esibirsi in “pubblico” nei bordelli di Weona. Eventually, nel 1931 vinse una competizione musicale al negozio di dischi di H. C. Speir a Jackson ed ebbe l’occasione di andare a registrare alla Paramount, e in quell’occasione incise i 18 brani che ci sono rimasti nelle Complete 1931 Sessions. Un brano come Devil Got My Woman (ispirato alla fuga d’amore della prima – e ultima – moglie) ha stupito migliaia di ascoltatori per la sua struttura sghemba e completamente slegata dai canoni del country blues (un’ottima analisi si trova ne Il Blues di Vincenzo Martorella, nel capitolo a lui dedicato), e l’altro suo singolo più famoso, I’m so Glad, ha un tempo incespicante che sembrerebbe toccare l’outsider ma che in realtà ha una sua perfetta coerenza interna. La voce disperata di Nehemiah risuona cupa sui fulminei sleghi di chitarra che lo accompagnano, il tripudio delle sessioni del ’31 è una delle cose più commoventi e strane che siano uscite dal country blues, ma la crisi impedì ai suoi recordings di vendere, e Skip divenne uomo di chiesa fino alla sua riscoperta. Morì nel 1969 a Philadelphia, quando il suo nome era già diventato leggenda.
Durante il primo lustro degli anni ’30 molti musicisti furono chiamati a registrare: Peetie Wheatstraw (popolare pianista e chitarrista di St. Louis Blues), Booker “Bukka” White (zio di secondo grado di B.B. King, amico di Furry Lewis, conoscente di Charley Patton, famoso anche tra i profani ma poco interessante nell’ottica di quest’articolo), Kokomo Arnold (grande chitarrista bottleneck), Blind Boy Fuller (erede prediletto del Piedmont Blues), Leadbelly(riscoperto da Lomax a Parchman Farm ma già famoso negli anni ’10 con Blind Lemon, musicista enorme di cui purtroppo spesso si ricorda solamente la sua bellissima versione di Where Did You Sleep Last Night?), Big Joe Williams (pioniere della chitarra a nove corde, autore di Baby Please Do Not Go), Memphis Minnie (cristallina voce del blues acustico di Chicago, una delle poche chitarriste donna della storia del blues acustico), Fred McDowell (eroe delle colline al confine col Tennessee che ha potuto registrare solo nel 1959 con Lomax, come del resto è successo a R.L. Burnside e Sid Hemphill) e molti altri di cui in questa sede non si ha né lo spazio né le conoscenze per parlarne – già stringere in una parentesi artisti come Leadbelly e Bukka White è stato abbastanza doloroso.
Nonostante ci fosse una vera valanga di adepti approdati alle varie case discografiche nella prima metà degli anni ’30, era evidente che non tutti potevano raggiungere le vette emotive di un Son House, l’originalità di uno Skip James o il virtuosismo di un Blind Willie McTell e anche tra i talent scout stava cominciando a farsi largo l’idea che forse sarebbe iniziato a servire qualcosa cominciare a investire verso forme di blues diverse e contaminate, visto che il Delta Blues cominciava a mantenere, con rare eccezioni, una forma stagnante e piuttosto stereotipata. Il mercato sarebbe stato soddisfatto qualche anno dopo con la grande migrazione urbana e con le forme chiassose e amplificate del Chicago Blues, ma nel 1936 il Delta non aveva ancora concluso il suo discorso: fu in questo periodo che una schiappa della chitarra, uno che “nemmeno un cane sarebbe rimasto ad ascoltarlo” tornò dopo un viaggio di due anni alla sua Robinsonville, imbracciò la chitarra davanti a Son House e Willie Brown e cominciò a suonare.
I said ‘Look who’s wiggling through the crowd with a guitar.” He said “Where?” I said “Look, look it is little Robert, Will.” We called him Little Robert, he said “Sure is.” Now I wonder what he thinks he is going to do. He ain’t going to annoy these people to death. He wiggled until he got over there and he hammered some. He said, “Hey what do you think boys?” We stopped playing and I said, “Where you think you are going with that thing?” He said “Oh I just want to play a little bit. When y’all get tired let me play some.” I said “Robert I don’t know, I don’t think we can afford to do that for the man that we are playing for wouldn’t like it so well.” He said, “I don’t know, just give me a try.”

Little Robert
Robert Johnson è stato il più grande bluesman della storia. Pochi cazzi. È nato l’8 maggio 1911 a Hazlehurst, Mississippi e il suo cognome originale era Spencer, aveva una decina di fratellastri più grandi, ma lui era nato da una relazione extraconiugale tra sua madre e Noah Johnson, un bracciante. A quanto pare da bambino Little Robert cominciò a suonare la chitarra grazie all’influenza di suo fratello Charles Leroy (che sarebbe poi diventato un pianista dilettante), sebbene in casa avessero anche un diddley-bow che veniva suonato frequentemente; in seguito imparò anche a soffiare nell’armonica. Visse con il patrigno C.D. Spencer a Memphis dal 1914 al 1918, ma poco dopo si ricongiunse con la madre e si trasferì insieme alle sorelle a Robinsonville, cittadina nella quale visse un periodo duro durante il quale – tra le altre cose – subì diverse «intemperanze fisiche e verbali» da parte del patrigno Dusty Willis, un lavoratore dei campi che conduceva uno stile di vita severo e in linea con l’etica del lavoro protestante. Nelle serate torride di Robinsonville Robert se la svignava da casa e andava a partecipare alle feste proibite e ai Juke Joint del quartiere nero: fu in queste occasioni che fece la conoscenza di alcuni dei suoi mentori, i già citati Son House e Willie Brown ma anche il leggendario Charley Patton, che fu per lui un’importante fonte di ispirazione, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista della visione del mondo. A diciotto anni Little Robert si innamorò di Virginia Travis, una ragazzina di Robinsonville, e la sposò. La piccola morì di parto insieme al bambino un anno dopo le nozze, e gli storici sono concordi nell’affermare che la perdita straziò Robert, e che la sua dipartita fu la causa principale che spinse il genio a inoltrarsi nel mondo gramo dei bluesmen del Delta. Come scrive Tom Graves: «Le canzoni che avrebbe scritto e che sarebbero state cantate da decine di altri musicisti nei decenni a venire parlano quasi sempre del rapporto con una donna e del terrore di perdere una persona amata».
Non aveva più motivo di restare, e infatti se ne andò. La strada dissoluta della musica «era di gran lunga preferibile alla morte lenta della mezzadria». Durante i suoi giri per il Delta si accompagnò sempre a dei grandi musicisti, pur essendo piuttosto scarso con la chitarra fu accolto come amico da Son House, che divenne per un periodo il suo mentore. Ma la musica non ingranava, quindi partì. Tornò due anni dopo, e la testimonianza di Son House è quella che è citata alla fine dell’ultimo capitolo: quando Little Robert iniziò a suonare Willie Brown e Son House si guardarono con la bocca spalancata: «il ragazzo era decollato». Dei due anni di vagabondaggio e di hoboing di Little Robert non si sa moltissimo – e la maggior parte delle leggende nascono attorno a queste lacune – ma dalle testimonianze si riescono ad evincere alcune informazioni: avrebbe incontrato Johnny Shines e Robert Lockwood facendo l’hobo, la sua vita si sarebbe trasformata in breve in quella di un donnaiolo, un menefreghista e un ubriaco molesto. Si sarebbe sposato di nuovo con una certa Callie Craft, che però mollò a Clarksdale senza lasciare notizie. Durante i viaggi avrebbe suonato con una quantità di bluesmen famosi o che sarebbero diventati famosi, da Lonnie Johnson a Sonny Boy Williamson II, da Honeyboy Edwards a Howlin’ Wolf.
In pochi anni Robert aveva realizzato il suo sogno di diventare un bluesman itinerante – e ignorando i problemi della grande depressione riusciva a vivere alla giornata e a farsi amare come musicista nei juke joint. Gli mancava solo un ultimo passo: la registrazione. Nel 1936 andò al negozio di H.C. Speir a Jackson (come abbiamo già visto Speir oltre che venditore era anche scout per le major della musica nera), si sottopose a un provino e riuscì a ottenere l’invito per l’incisione di una demo. Speir passò il nome di Little Robert a Ernie Oertle della ARC, e nel novembre del 1936 in quel di San Antonio, Texas, Johnson incise su disco le session che conosciamo oggi grazie ai suoi Complete Recordings. Si dice che registrò dando le spalle a Don Law, il produtttore responsabile della filiale della ARC e agli altri presenti: varie ipotesi sono state avanzate su questa scelta (si parla di imbarazzo, meticolosità, corner-loading) ma la spiegazione più plausibile sembra essere che Johnson si girasse semplicemente per evitare distrazioni che avrebbero rovinato il prodotto finale. Durante altre sessioni, nel giugno del 1937, registrò una decina di pezzi tra i quali Hellhounds on My Trail e Me and the Devil Blues, che avrebbero presto alimentato il mito del diavolo e del crocicchio. A quel punto della sua carriera le case discografiche avevano cominciato a notare i suoi successi, e alcune stavano preparando dei contratti anche piuttosto importanti, ma nessuno di essi vide la firma di Little Robert. Morì nell’agosto del 1938, non si sa come (avvelenato? Da chi? Sifilide? Intossicato dal moonshine?) e non si sa dove fu seppellito (Greenwood? Quito? Morgan City?). Non importa. La vita e il mito di Robert Johnson sono state tra le cose più importanti dell’intera storia del blues del Delta, hanno contribuito a crearne il folklore e le leggende sebbene fossero disegnate addosso a un ometto che arrivava fin troppo tardi, in un’epoca di chiusura e di riscoperta, in cui Alan Lomax cominciava ad interessarsi alla musica afroamericana del Delta e delle Colline e i musicisti andavano in pensione, o a Chicago. La data della sua morte rappresenta forse la data della morte dell’intera ondata di country blues proveniente dal Delta del Mississippi e dintorni, la morte di un brutto anatroccolo rigorosamente nero che nel suo ultimo rantolo è stato invaso dai blue devils nella possessione più tremenda della sua storia.
Della musica di Little Robert, ovviamente, non posso parlare. Non è di questa città.
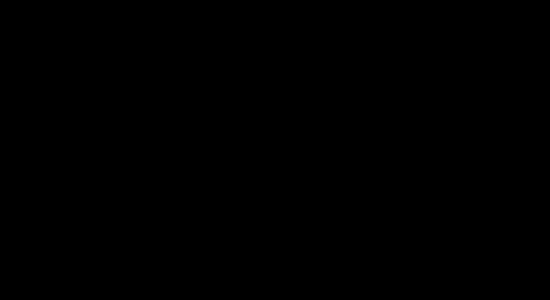
Conclusione
Il blues rurale negli ultimissimi anni ’30 e negli anni ’40 era diventato piuttosto vecchio e stantio: il colpo di coda di Robert Johnson era stato un unicum, e gli ascoltatori cominciavano a cercare da un lato la novità, l’amplificazione, il blues elettrico e il blues di gruppo, dall’altro la collezione, l’inchiesta, l’indagine, la riscoperta delle radici. La musica nera era in fermento, Muddy Waters veniva registrato da Lomax e nel Jazz cominciavano ad apparire le prime forme di Bebop, il gospel stava evolvendo, nasceva l’R&B e di lì a un decennio sarebbero apparsi i primi germi del Soul. Musicisti come Big Bill Broonzy posavano la chitarra acustica e imbracciavano la semi-hollow o addirittura l’elettrica e il mercato delle varie Okeh e Columbia e Victor iniziava a muoversi verso altri lidi. Son House tornava a lavorare in piantagione. Sebbene non si abbia un riscontro fisico, nelle registrazioni e nelle pubblicazioni, sappiamo da varie testimonianza che mentre la musica evolveva in ambito nazionale e internazionale, il Delta del Blues avrebbe continuato a cantare, nel suo intimo, per ancora qualche decennio: finché c’è un motivo per cui lamentarsi – un motivo vero – è giusto fare blues.
Alan Lomax avrebbe trovato negli anni ’40 le stesse persone e le stesse situazioni che avrebbe trovato un viaggiatore negli anni ’20 e ’30, idem William Ferris negli anni ’50. I juke joint rimanevano attivi, il call-and-response permeava la vita di lavoratori e bighellonatori, il razzismo non avrebbe mai avuto fine. Non so se ancora oggi tra le colline che confinano col Tennessee c’è qualcuno che suona come la folle famiglia di Sid Hemphill, ma credo di sì. Quello che so per certo è che oggi, grazie a tutte le varie ristampe degli anni ’90 e al lavoro di centinaia di appassionati, il country blues è disponibile per chiunque, e chiunque può intraprendere una ricerca come la mia, riempendosi di libri e registrazioni e rimpiangendo di non poter fare un’effettiva ricerca sul campo. So anche per certo che la lente di ingrandimento che ha messo a nudo le ansie del Delta e dei paesi confinanti ha permesso a centinaia di musicisti di interfacciarsi con un tipo di musica che in europa e in generale nei paesi bianchi non si era mai vista, una musica poliritmica suonata con le strutture che abbiamo già visto e che ha avuto un’influenza abnorme nei confronti della storia della musica contemporanea se la confrontiamo con la circoscrizione della zona e dell’epoca a cui appartiene.
Al di là dei richiami più ovvi come quelli dell’hard rock, del british blues, del folk rock, del garage e così via, il blues puro ha avuto degli ammiratori che verrebbero rispettati da chiunque. John Fahey, che ha scelto lo pseudonimo Blind Joe Death per le sue prime pubblicazioni è uno di questi, e con lui tutti i suoi seguaci che hanno abbracciato il primitivismo americano. Captain Beefheart, una figura ovviamente mastodontica per la musica contemporanea, è un altro. Tom Waits, Jon Spencer, i Gun Club, Nick Cave, Jandek, Derek Bailey sono altri. In generale, chiunque abbia mai preso in mano un disco di Charley Patton, di Blind Lemon Jefferson, di Robert Johnson o di qualsiasi caposaldo del blues rurale non può che esserne stato profondamente cambiato, e sarà obbligato a portare con sé una cicatrice profondissima, la stessa cicatrice che porta con sé tutta la musica contemporanea che ha attinto a piene mani dal blues del Delta, omaggiando – o rubando, e che ha la sua origine nello schiocco di una frusta.
It was late one Friday evenin
In wicked Tupelo
The storm begin to risin
And the wind begin to blow.
Wasn’t that a storm at Tupelo?
Wasn’t that a storm, wasn’t that a storm?
Bibliografia in pillole:
- Alan Lomax – The Land Where the Blues Began
- William Ferris – Blues from the Delta
- The Cambridge Companion to Modern American Culture
- Vincenzo Martorella – Il Blues
- Tom Graves – Crossroads
- Julia Rolf – Blues: una storia completa
Fonti internet (utilizzate soprattutto per le biografie):
Varie ed eventuali, conoscenze personali e – ovviamente – i dischi.





