Se nelle ultime settimane avete passeggiato per il centro di Bologna schivando la pioggia battente, è probabile che abbiate intravisto un manifesto con una pecora che galleggia beata in una bolla di sapone sopra un prato verde. Questa visione bucolica è solo l’ultima della lunga serie a cui ci ha abituato AngelicA, il festival che da più di trent’anni invade la città e i suoi luoghi di artisti d’avanguardia di fama mondiale. Siamo riusciti a contattare Massimo Simonini, fondatore e direttore artistico del festival dal 1991, e in una lunga intervista-fiume telefonica, che poi abbiamo trascritto, abbiamo discusso con lui di suoni, sogni e di tutti i processi che bisogna attraversare per creare qualcosa di veramente unico.
L: Partiamo da una singola parola: AngelicA. Da dove viene il nome?
MS: Viene dal fatto che io, Mario Zanzani, cioè la persona con cui ho fondato AngelicA nel 1991, e altri due nostri amici con la quale condividevamo questa avventura eravamo impegnati a deciderci su come chiamare il festival. Io spingevo perché volevo inserire la dicitura “festival internazionale di musica”, non “di nuove musiche” o “di musica jazz” o che si identificasse in un genere: io volevo parlare di musica, anche se ovviamente mettendo in risalto la componente che riguarda la ricerca musicale. E cercavo un nome di persona per il festival, ma non ci trovavamo d’accordo sul nome, ne uscirono tanti e un nostro amico, Gaetano La Rosa (ndr. direttore artistico del Wallofsounds a Palermo) disse “Perché non lo chiamate Angelica?”. Effettivamente, “AngelicA – Festival Internazionale di Musica” suonava bene; e fu il nome che utilizzammo e che ci mise d’accordo. Anche perché eravamo in ritardo e dovevamo pubblicare i programmi della prima edizione che sarebbe iniziata poco dopo.
L: Una storia di decisioni prese anche all’ultimo minuto, quindi. Avviciniamoci un po’ a quello che succede prima del festival: la cosa che notiamo ogni anno è il materiale promozionale che distribuite, che si distingue quasi testardamente dai flyer appariscenti che vediamo troppo spesso per gli eventi musicali convenzionali con biografie approfondite e passaggi al limite del letterario. Da dove viene questa scelta stilistica?
MS: Ci fa piacere che abbiate notato questa scelta perché soprattutto è frutto di un duro lavoro che forse rispetto ai tempi è un po’ controcorrente; qualcuno ci dice, sicuramente con delle motivazioni condivisibili, che quello che facciamo è un po’ superfluo e che bisognerebbe essere più sintetici. È anche il frutto del lavoro di collaboratori e curatori che aiutano AngelicA a costruire i suoi programmi, come ad esempio Walter Rovere che cura gli editoriali e i testi che mettiamo sul sito e nei programmi. Ma torniamo al discorso della sintesi: sul libretto noi abbiamo quindici o venti righe che presentano ogni concerto e che fanno da sintesi, però poi sul sito inseriamo approfondimenti, schede, profili degli artisti. Io ci tengo molto a capire il nome di un progetto musicale, chi sono i suoi componenti e cosa suonano, anche quando ci sono dei musicisti sconosciuti; e poi bisogna segnalare chi ha il sostegno di questa o quell’ambasciata, chi è il curatore di quel concerto… Quando guardo altri siti per avere informazioni su un concerto, vedo spesso queste immagini molto “sexy” dei musicisti, pagine piene di fotografie, e poi quando clicchi capita che trovi i biglietti ma non riesci a trovare chi suona e che cosa si suona. Forse sono informazioni che non interessano più a nessuno, ma per me sono importanti e necessarie. Per esempio il concerto, a cura di Luca Vitali, che abbiamo presentato lo scorso 17 maggio, l’Azione_Improvvisa Ensemble, era composto da una chitarra elettrica, una fisarmonica, una tiorba ed elettronica: un quartetto formato da strumenti molto difficili da vedere insieme e questo oltre ad essere motivo di interesse, comunque spiega meglio cosa si andrà ad ascoltare. I programmi di AngelicA sono pieni di queste particolarità, ogni concerto è un mondo e almeno per me, l’interesse si accende, rispetto per esempio a vedere un organico più comune. E tutti questi elementi, che sono accompagnati dalle grafiche a cura di Massimo Golfieri e Concetta Nasone, sono anche loro frutto di discussioni, a volte molto accese, di visioni che arrivano da tutti i nostri collaboratori e poi vengono tradotte nella realtà. Penso che caratterizzino il festival nella sua dimensione di originalità e di quello che cerca di dire.
L: Parliamo invece dei vostri spazi: il Teatro San Leonardo ospita la maggior parte dei vostri concerti, ma le diramazioni di AngelicA sembrano spingersi sempre di più in luoghi “altri”. La scelta di proporre quest’anno il concerto di Sarah Davachi alla Basilica dei Servi ne è un esempio: come ragionate e come vi organizzate quando dovete scegliere il “fuori casa”?
MS: Noi abbiamo lavorato moltissimo sul contesto. Una determinata musica presentata in un determinato luogo cambia sia la musica che il luogo. Quindi, per me, contestualizzare o decontestualizzare è stato uno dei principali motivi per cui siamo andati a cercare altri luoghi, a trovare altri spazi, e attraverso questo si potevano comunicare a diverse comunità o portare altre comunità in quel determinato luogo. Andare al Comunale con Cecil Taylor nel 2000 e farlo suonare piano solo prima del concerto per orchestra di Morton Feldman, Coptic Light… Ecco, a quel punto la composizione della serata diviene particolarissima, perché hai messo a confronto un maestro della musica free, della storia del jazz che si è inventato una sua musica per come l’ha trattata che poi è diventata anche un classico, e dopo l’orchestra che esegue Coptic Light. Poi Taylor, e in quel luogo, si potrebbe anche considerare come un Maurizio Pollini dell’avanguardia, mi spiego? Tra l’altro, anche Pollini ha eseguito brani di Stockhausen e altri contemporanei, ma è noto ai più per un repertorio classico, consumato, che viene suonato nei teatri d’opera, in quei luoghi appunto. Come abbiamo presentato al TPO e al vecchio Link dei concerti che avevano un carattere più “da camera”, sebbene sempre d’avanguardia. Abbiamo disorientato. Ovviamente chi conosce la musica e la segue nella sua varietà, non si disorienta ma resta impresso qualcosa di diverso rispetto alla fruizione più classica. Torno a Taylor perché mi piace l’esempio ma in trentatré anni di storia ce ne sono veramente tanti di esempi di questo tipo che si possono fare, anche quelli che erano abituati a seguirlo nel contesto dei festival jazz, a vederlo nel contesto di un teatro d’opera prima di un concerto per orchestra potevano percepire che l’ascolto cambiava. E cambia sempre, anche se pensiamo che non cambi: e tutto cambia anche per i musicisti; io ricordo che Taylor rimase colpito e ci disse: “Mi interessa più Xenakis di Feldman”, quindi con una critica, se vogliamo, al concerto per orchestra. Però anche questo è interessante: chi cerca di muovere la musica rimuove le appartenenze a quella musica, di quel pubblico verso quella musica. E per qualcuno questo è un problema: per qualcuno, nel 2000, andare al Comunale era un problema. Avrebbero preferito se avessimo presentato Taylor senza l’orchestra, da un’altra parte, in un luogo più tradizionale… A me queste codificazioni sono sempre state troppo strette, le sento come qualcosa che non tende ad aprire. Poi ovviamente bisogna cercare di rispettare la musica, i musicisti, come sono nate le cose, come si trasformano nel tempo, però le scelte che abbiamo operato aiutano comunque a vederle, a essere viste in modo diverso. E questo provoca qualcosa: provoca non per provocazione, ma perché è frutto di un’idea, di una visione; e io per quell’idea provo rispetto, sperando che possa trasmettere, magari anche a poche persone, qualcosa di diverso; e magari quelle persone che condividono quell’idea possono scoprire che il concerto ha aperto una finestra su qualcos’altro. E non è detto che questo qualcos’altro riguardi essenzialmente la musica, perché ci tengo anche a dire che AngelicA non parla solo di musica. Parla di vita legata alla musica e di musica legata alla vita, perché il musicista vive, compie dei passi, cresce, evolve, incontra, e così via.
L: Ecco, parliamo di queste vite, degli artisti: il roster che portate ogni anno è sempre eccezionale nella varietà e nell’altezza della proposta: qual è il metodo con cui scegliete gli ospiti di ogni edizione? Quali sono i fili che vi legano ai grandi nomi che riuscite ad attirare?
MS: Anche quelli sono frutto di fatica, di idee, visioni. Ormai da un tot di anni anche di visioni diverse, quelle di curatori, appassionati, persone che aiutano AngelicA a costruire i suoi programmi, tanto che io spesso mi ritrovo a fare il vigile urbano, quello che cerca l’equilibrio tra tutte queste diversità che ci tengo a mettere insieme, perché è da sempre la natura di Angelica fin dal 1991. Però è bellissimo ritrovarsi con tutte queste proposte e queste idee che arrivano. Anche perché da un’idea di qualcuno magari mi viene in mente un’altra idea, per esempio organizzare un concerto in un’altra location, o pensarlo in un altro modo. Poi, dopo trentatré anni, i musicisti conoscono quasi sempre il festival: molti conoscono i nostri eventi in tutto il mondo, quindi le cose sono più semplici. Tutta un’altra storia rispetto a quando muovevamo i nostri primi passi, dovevamo spiegare tante cose, non c’erano le email, usavamo il fax… E poi è frutto di un flusso, che a volte riusciamo a cogliere, altre volte è più complicato farlo scorrere. A volte guardo il nostro programma e mi dico che può far pensare che sembra nato per caso, ma poi si colgono relazioni e combinazioni che sarebbero state difficili trovare senza quel “caso”, cioè senza lasciar scorrere le cose e farle andare anche dove vogliono andare. Il messaggio di un artista comunica con quello di un altro, e poi può esserci un disco che bisogna presentare, o un musicista che è di passaggio e ti chiama all’ultimo momento, oppure i Matmos che l’anno scorso erano qui a suonare e che quest’anno diventano curatori perché dicono a Lauren Sarah Hayes che dovrebbe venire a suonare ad AngelicA. E poi ci sono le collaborazioni e le coproduzioni che organizziamo, come quella con il conservatorio di Bologna, con persone con cui collaboriamo da diversi anni come il direttore Aurelio Zarrelli e i docenti Walter Zanetti, Maurizio Pisati e da lì nascono altre idee.
L: Sempre parlando di artisti e flussi, è impossibile non notare come AngelicA esplori in ogni sua edizione percorsi tematici non convenzionali: ci vuole spiegare qual è il fil rouge che quest’anno riesce a collegare voci estremamente diverse tra loro?
Come dicevo prima, dato che il programma è sempre così variegato io invito tuttə a seguire il festival per trovare, se lo si trova, un filo, una comunicazione tra i vari eventi. A volte nella stessa serata ci sono due concerti molto diversi, e che però spesso sono in comunicazione tra di loro; spesso mi rendo conto che funzionano, ma se c’è attrito è un attrito interessante per notare qualcos’altro di non immediato. La prima settimana Wadada Leo Smith ha addirittura presentato un festival nel festival, cioè il suo Create Festival, una sua idea in cui raccoglie organici diversi per suonare le musiche che ha composto nella sua lunghissima carriera, e la due giorni di Wadada raccontava una storia, ma venendo da Jim O’ Rourke con Eiko Ishibashi che presentavano invece un doppio set di musica elettroacustica è chiaro che la tendenza al suono jazz di Wadada Leo Smith assume un’altra tonalità, anche se la musica era come che cercasse altri luoghi.
L: Sì, quartetti d’archi, doppia batteria, doppio pianoforte; eravamo alla prima serata.
MS: Ecco, se foste venuti anche alla seconda avreste visto un altro mondo. Si è chiusa con un pezzo pseudo-dance per due batterie, basso elettrico e pianoforte preparato, un flusso di dieci minuti quasi trance. Vabbè. Quindi i fili sono tanti e tutti aperti verso altro, e questa apertura comporta che ognuno può trovare la propria storia: è nell’astrattezza tra la storia che si vuole raccontare, o che si cerca di raccontare, che ognuno di noi ha la possibilità di trovare qualcosa che lo riguarda. A volte parliamo con i nostri amici e i collaboratori, curatori, e ognuno ha trovato delle chiavi di lettura diverse, perché ognuno parte da una storia, da uno studio e da un’evoluzione diversi. C’è chi ha iniziato ad ascoltare musica da appassionato di jazz; io, anche grazie a vari amici nelle zone in cui sono nato, che non è Bologna, ho ascoltato tanta musica etnica, un certo tipo di rock, il primo ambient, il jazz delle origini, e tanto altro che potrei individuare anche come ibrido. Io cercavo suoni che mi intrigavano e mi parlavano, mi mettevo le cuffie se non potevo ascoltare a volume alto, poi mi mettevo ad occhi chiusi in una stanza e ascoltavo questo o quello, Ed Blackwell, la musica dei pigmei, le polifonie Mongo, Ornette Coleman; tante storie, tanti registri… Per quello parlavo anche di vite. Crescendo con la musica, oltre a vedere la mia vita cambiare e le tribolazioni che ho passato per cercare di comunicare la musica che amavo agli altri o ai miei amici, ho avuto modo di leggere e scoprire aspetti nella musica di quei musicisti e nella vita che vivevano. A questo proposito AngelicA cura anche dei documentari sulle vite dei musicisti che si chiama Voci dall’aldilà, sempre curato da Walter Rovere: quando li guardi capisci che quelle vite e quelle storie non potevano fare altro che regalare musiche molto originali, musiche ispirate: forse non tutte, perché poi entriamo nel discorso della forma, a volte qualcuno si è inventato quella forma e poi tanti l’hanno seguita, no?
L: Appunto, lei ha menzionato Ornette Coleman…
MS: Un uomo che ha inventato un suono, una musica. Poi in tanti sono andati dietro a quella storia e a quella musica, certo con delle differenze, interpretazioni, alcune ispirate, altre meno, imitazioni, fotocopie… Forse mi sono perso.
L: No, macché, è un discorso che come dice lei parla soprattutto di vite. Parliamo di quella di Bologna, ad esempio. Bologna è sicuramente un bioma ricettivo, ma strutturare il proprio festival attorno all’avanguardia offre tante possibilità quante sono le sfide da affrontare. In questi trentatré anni di direzione avete notato cambiamenti nel modo in cui la città reagisce ad AngelicA?
MS: Io a volte parlo di cicli della città; d’altronde i cicli sono dappertutto, ci sono quelli nostri personali, quelli di un gruppo, di una storia, di una musica… A volte una musica diventa più di moda, se c’è l’elettronica ai concerti viene più gente, lo dico un po’ per banalizzare però è così. In questi cicli, in queste onde che hanno le città, che a volte sono più o meno ricettive, Bologna ha una marea di cose. Ha molte cose in più, molti più festival, molti più concerti: quando siamo nati noi, c’era molto meno in città. Quindi è chiaro che se durante un fine settimana ci sono trenta, quaranta concerti, più spettacoli teatrali, più tutto il resto, più migliaia di bar che fanno l’aperitivo con il concerto dentro è chiaro che c’è una dispersione tale che riuscire a fare da calamita è diventato più difficile. Nonostante il fatto che ci sono tanti affezionati, anche se ogni sera entra qualcuno in teatro e guarda in alto verso le cupole e si capisce che è la prima volta che entra… E poi molta gente viene da fuori città e fa un po’ impressione, rispetto alla città degli studenti come si fa chiamare a volte Bologna. Forse è il “disordine” che non aiuta.
L: Ecco, appunto: AngelicA si distingue, tra i tanti festival musicali, anche perché sembra che spingiate molto sulla proposizione di première e di materiale inedito (come abbiamo già detto nel caso di Wadada Leo Smith quest’anno, addirittura a riproporre “un festival nel festival”). Qual è il modo con cui vi rapportate con gli artisti su questa conditio sine qua non? Riuscite a pensare a delle difficoltà che questa scelta ha involontariamente creato?
MS: Mi prendo la responsabilità per la maniera, anche un po’ ossessiva, di scrivere “prima assoluta”, “prima italiana”, “prima europea”… Però a volte accade, a volte no. E non stiamo per forza a cercare l’evento esclusivo: certo, se c’è il festival e un artista ha già presentato l’anno prima a Bologna o a Modena quello che ci sta proponendo, forse ha poco senso. Poi, noi generalmente facciamo il festival a maggio fino ai primi di giugno, e dopo abbiamo un’altra stagione di eventi che va da settembre e dicembre e da gennaio e aprile. La stagione, che comunque contiene diverse prime, è soprattutto per i musicisti che sono in tour (anche perché abbiamo un budget più basso), ed è una dimensione forse più giusta per quel tipo di eventi. Al festival invece, anche se pure lì ci sono musicisti in tour, possiamo invitare qualcuno chiedendogli: “Vieni per presentare questo? Vieni per provare a fare questo?”. Noi in trentatré anni siamo andati al Cimitero della Certosa, siamo andati al TPO, al Link, per strada, abbiamo fatto processioni… Abbiamo veramente visitato tanti spazi. Quindi diciamo che sì, cerchiamo di fare dei progetti originali, ma se un musicista ci propone un progetto non necessariamente nuovo basta che ci convinca per farci dire “Facciamolo!”
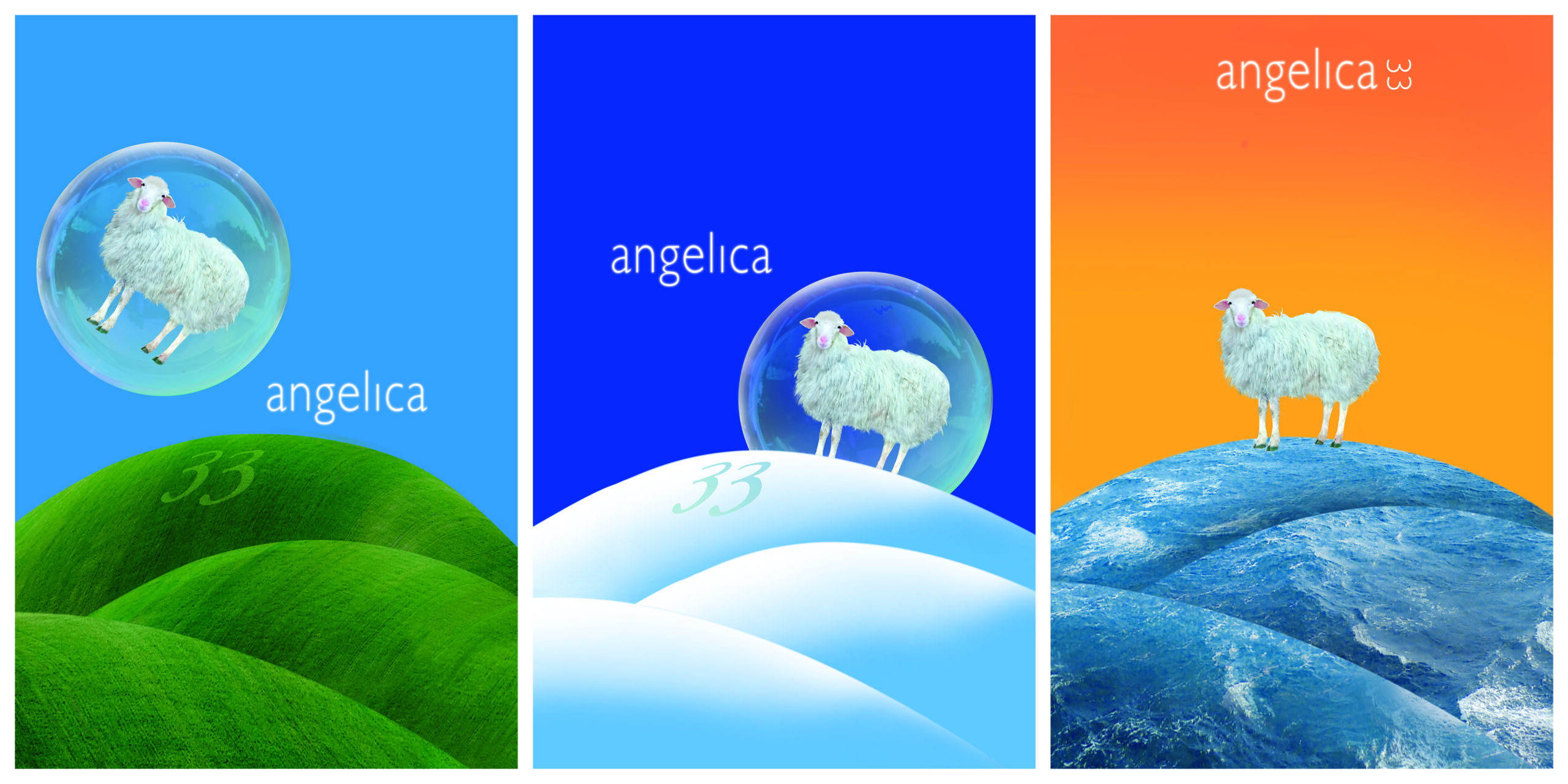
L: Abbiamo accennato a questa cosa delle prime perché volevamo ricollegarci ai dischi di AngelicA, cioè all’uso che fate del festival come “sala registrazioni” per progetti che acquisiscono un’unicità replicabile e poi ridistribuibile. Quali pensa che siano le uscite discografiche imperdibili della storia di AngelicA da questo punto di vista?
MS: È difficile per me dirlo, in ogni disco ci ho messo il cuore e tanto lavoro. Poi sai, nel tempo, questi oggetti sonori, che a volte io chiamo anche “veicoli artistici”, cambiano col tempo: ascolti qualcosa e vent’anni dopo ti stupisci della loro bellezza oppure dell’ingenuità con cui ti sei approcciato a quel materiale, non so. Poi a volte ascolti le cose con più distacco, altre volte pensi a quanto sia bello l’oggetto che hai prodotto, alla follia che c’era dietro… E il singolo disco è importante, però per me conta l’insieme, le voci diverse che entrano nella collana di AngelicA. Prendi la nostra ultima uscita: si tratta di un disco che aveva fatto uscire privatamente Pandit Uday Bhawalkar, che ha fatto due concerti ad AngelicA nel 2008 e nel 2014. Di quei concerti abbiamo delle buone registrazioni, ma quella versione sua, privata del Raga Yaman che lui dava agli organizzatori dei festival in giro per il mondo in pochissime copie per me è bellissima. Quindi gli ho chiesto: “Visto che l’hai esaurito perché non lo stampiamo?” e l’abbiamo fatto. Però Raga Yaman, quando lo metti insieme al nostro disco precedente, quello di Massimo Pupillo, Tony Buck e Toshinori Kondo, o a quello prima ancora, di Francisco Lopez con Reinier van Houdt, assume tutto un altro tono. Anche perché I dischi di AngelicA non è un’etichetta che fa musica classica indiana o tradizionale, abbiamo pubblicato tante espressioni musicali diverse. E poi alcuni dischi sono venuti fuori da soli: in qualche caso ho chiesto io di fare il disco, ma in altri casi sono state delle proposte che ci sono arrivate… Quindi sono come dei regali, dei frammenti di tempo che ci hanno regalato dei musicisti che sono pezzi di storia della musica.
L: Beh sì, non è da tutti avere un concerto per piano solo di Taylor in catalogo, per tornare a un disco che abbiamo già toccato…
MS: Quel concerto poi è uscito su doppio disco: il primo CD è il concerto; il secondo invece è un incontro pubblico, con Franco Fabbri a fare da moderatore; un flusso unico, dove Taylor parla di tutto, dall’architetto Calatrava all’ultimo concerto di Billie Holiday. È un documento preziosissimo, e l’ho chiamato Rap. Anche perché Franco Fabbri ha fatto poche domande, ma lui è stato a parlare per un’ora. E mi è venuto naturale mettere, come ultima track, un pezzo del concerto per piano solo e un pezzo di lui che parla montati assieme. Se vai ad ascoltare il pezzo sembra una composizione, è una composizione.
L: Sempre parlando dei dischi di AngelicA: qual è il legame che vi lega a Bob Drake (ndr. fondatore dei Thinking Plague e ingegnere del suono della maggior parte dei catalogo di AngelicA)?
MS: Bob Drake è una cara persona, innanzitutto. Una persona buona. Sembra una banalità dirlo, ma è l’esatto contrario. E con me è sempre stato disponibile nel cercare di arrivare alla soluzione giusta. A me sembra di parlare con lui, ma non parliamo nemmeno al telefono: ci scriviamo, per lui sono mail di poche righe, mentre io per spiegare scrivo mail molto più lunghe, e così poi arriviamo ai missaggi, a masterizzare… Cerchiamo di trovare i suoni migliori che possiamo nel tempo che ha a disposizione.
L: La nostra redazione è sempre stata vivamente appassionata di etnografie musicali al di fuori della visione occidentale dell’industria troppo spesso limitata al mondo anglofono e poco più. Se doveste indicare un Paese che reputate fervente di nuove opportunità, quale sarebbe?
MS: Con AngelicA vogliamo sempre portare qui musicisti da tanti luoghi lontani, e abbiamo fatto come potevamo, perché poi i viaggi da certi Paesi costano tantissimo e non sempre si può o non si hanno gli aiuti per farlo. Ogni Paese ha la sua musica e bisogna solo trovarla. Trovare quei musicisti in un momento è più semplice e in un altro invece è più difficile. Per esempio, nel ciclo a cura di Fabrizio Gilardino che abbiamo iniziato nel 2018, Asia-Sud-Est, che abbiamo intenzione di portare avanti, ho notato anche una fragilità di partenza in questi musicisti arrivati in Europa per la prima volta e una sensibilità che io trovo belle. Si percepisce la distanza, la lontananza, un’altra provenienza. Tutto questo accende altre domande e risposte, e possibilità di incontro. Ti chiede di andare oltre. Questa fragilità può parlare più forte di qualcos’altro che invece rischia di essere nella routine. Questa sensibilità ha qualcosa di giovane. C’è della freschezza, ecco. E questa freschezza è dovuta anche al fatto che magari devono ancora trovare la propria musica, rispetto a quegli artisti che possono rischiare di cadere nella routine.
L: Oramai sono diversi anni che ci ritroviamo a girare per i vostri concerti e notiamo con piacere che non vi spaventa il mettervi alla prova con contesti radicalmente differenti tra di loro: qual è, secondo voi, la situazione più complicata che vi siete ritrovati a gestire nella storia del festival?
MS: Innanzitutto, c’è il musicista che ha la sua visione e che vuole portarla a compimento. Quella visione va tradotta, e qualche volta qualche cosa va storta per il musicista o l’organizzatore, non si riesce a raggiungere quel livello tecnico che si vorrebbe, o magari ci si arriva molto vicino, soltanto dopo molte discussioni… Diciamo che sono le relazioni che nel momento in cui il lavoro è tanto ci mettono alla prova, a volte davvero a dura prova. Puoi litigare, discutere, però bisogna cercare, anche magari quando si litiga, di trovare il modo di andare oltre e di dire che lo facciamo per arrivare al miglior risultato possibile. Dobbiamo uscire dalla zona di comfort, come si dice, anzi: vogliamo fare il contrario di una “zona di comfort”. E poi penso che “lavorare insieme è anche uno svegliarsi a vicenda”. Ricordo qualcuno di quei luoghi abituati solo ai repertori classici che mi diceva: “Ah, vedrai con Stockhausen, ti troverai male perché non riuscirai a organizzare niente!” Eppure io con lui mi sono trovato benissimo. Era diventato un amico per me. Stockhausen cercava il meglio possibile da ogni produzione che affrontava: e per lui “il meglio” voleva dire che questa cosa andava fatta così, quest’altra cosa andava messa lì, che quella luce lì doveva andare così. Puoi immaginare quanti problemi possono nascere a più livelli. Con buona volontà e tanto lavoro ci si riesce; ma vanno cambiati degli schemi legati al passato. Però che regali che ci ha fatto Stockhausen. Anche con Taylor mi dissero le stesse cose. È vero, era umorale. E allora? Io ho cercato di accontentarlo come potevo. Uno viene dall’estero, si fa un viaggio di dieci o quindici ore; io come organizzatore devo cercare di trattarlo al meglio, di fargli avere quello di cui ha bisogno, di farlo riposare, di accompagnarlo. Insomma fare il possibile perché ognuno si trovi a suo agio. E contemporaneamente quando organizzi devi anche trovare il modo di essere gentile, di scendere a compromessi, di chiedere permesso quando entri in un teatro che ha altre regole rispetto a quelle che conosci tu, di avere rispetto per tutti, chiedere, se possibile, rispetto agli altri.
L: La nostra ultima domanda è anche una domanda sui sogni: cosa c’è nel futuro di AngelicA?
MS: Il sogno è una fondamentale dell’esistenza. I sogni possono essere torbidi, possono annunciare delle cose. A me capita spesso. Nutriamo i sogni, diamo spazio ai sogni e a quelli che sognano, e alle nostre visioni. Non uccidiamo il sogno, lasciamolo parlare. Lasciamo che un musicista porti la sua visione, potrebbe essere folle, o incomprensibile, ma proprio per questo necessaria più di un’altra cosa. Portare avanti un sogno vuol dire, con tutte le difficoltà del caso, lavorare su se stessi, lavorare su qualcosa che nemmeno tu che hai sognato sai ancora cos’è, ma piano piano prende forma; e quando vedi che quel sogno si è concretizzato ti può far piangere perché fai fatica a crederci. AngelicA per me è un sogno, o forse sono io ad essere un sogno di AngelicA: se penso a quello che è successo, a come è successo, per me è un piccolo miracolo, un figlio di un sogno… Un sogno di qualcuno di giovane, come ero io all’epoca, che cerca, e va avanti con un progetto perché vuole creare questa cosa e vuole capire come farla. Si chiudono dinanzi a te un sacco di porte fino a quando non incontri quell’amico che ti dice: “Perché non parli con lui?” e quel lui è Mario Zanzani, ha vent’anni più di te, e ti dice di passare nel suo ufficio per provare a fare qualcosa. E il mondo si riempie di speranza. Questa cosa piano piano nasce, magari non ti soddisfa mai, non hai mai i soldi e lavori gratis… E tu intanto stai lì, ci provi, un musicista ti aiuta perché capisce ed è d’accordo con la tua idea, le istituzioni ti danno qualcosa in più, qualcuno crede più in te, dai il sangue. E questo è il sogno che si avvera. Io ho sudato settantasette camicie. Per qualcun altro succede tutto in un attimo. Io penso che AngelicA abbia del miracoloso in sé: hai una visione, cerchi di portarla avanti. E poi ti chiedi: sarà la cosa giusta? A circa sessant’anni, però, mi dico anche che è importante avere questi dubbi e cercare di sciogliere le paure, a cui ovviamente cerchi di mettere anche un freno, altrimenti rischi di essere imprigionato. Avevo ventidue o ventitré anni quando è nato il festival. C’è anche chi va all’estero perché non trova qui certe corrispondenze, o la sua vita si deve forse svolgere altrove: ma in questa Italia tutta rivolta al passato così non può funzionare, e non trova spazio chi potrebbe aiutare a farla funzionare meglio.
A questo punto, Simonini deve scappare, occupato con la preparazione frenetica dell’ennesimo evento del festival. Ci salutiamo rapidamente, dandoci del tu e augurandoci di incontrarsi di nuovo alla prossima occasione: mentre rileggiamo questa intervista prima di pubblicarla, fatichiamo a renderci conto di come si possa essere così fortunati ad avere, oggi, delle persone così appassionate ed emotive da spingerti a pensare a quello che ti hanno detto dopo giorni e giorni; e di come queste persone siano capaci di pensare a un’idea così matta e meravigliosa come un festival completamente fuori da ogni schema. Lunga vita ad AngelicA!





