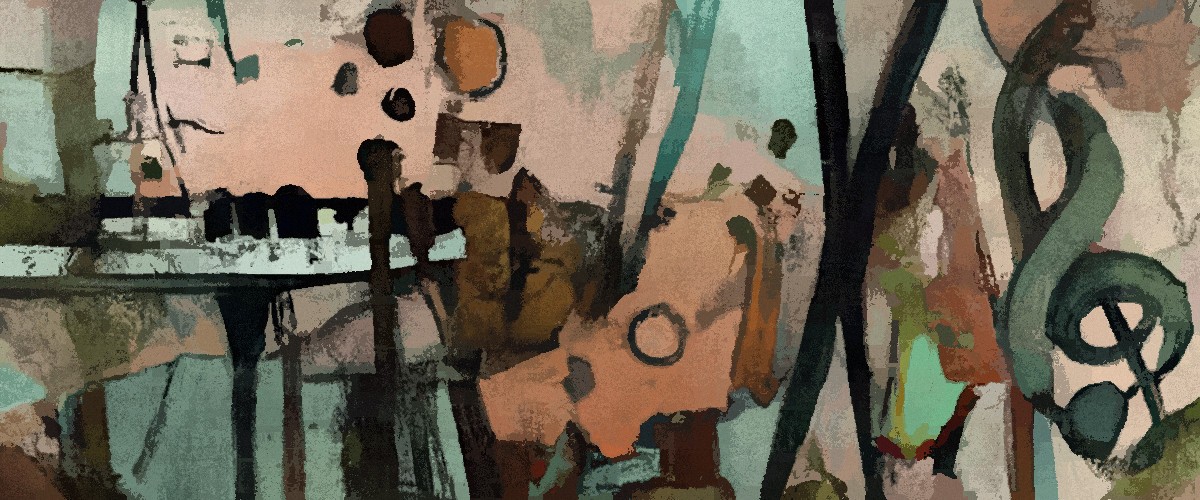Per tutta una serie di motivi che vanno dallo strettamente musicale al sociologico, il jazz è uno dei generi più seguiti e apprezzati degli ultimi anni. Il che non è propriamente il sintomo di un sedicente rinascimento dopo decenni di medio evo creativo: in tutto questo tempo il jazz ha sempre continuato a rinnovarsi, a esplorare nuove vie, a produrre – perché alla fine quello è ciò che conta davvero – musica bellissima, anche molto dopo quegli anni Settanta che rappresentano l’ultimo decennio che è stato effettivamente storicizzato dalla critica (e che, quindi, è conosciuto almeno parzialmente anche dai non appassionati). Semplicemente, da un po’ di tempo a questa parte anche il pubblico non specialistico è tornato ad accorgersi in tempo reale che ehi, ma sai che ‘sti jazzisti non sono gente che si suona addosso arroccata nelle proprie accademie?, e ha ripreso ad ascoltare dischi usciti dopo A Love Supreme scoprendo che quella del jazz bloccato nell’eredità culturale del bebop e incapace di andare oltre quell’esperienza fossero cazzate inventate da una critica pop ignorante e che vive di luoghi comuni senza ascoltare la musica. Come dicevamo sopra, le ragioni per questa riscoperta non vanno rintracciate soltanto nei canali di comunicazione preferenziali instaurati dal jazz con forme di musica popolare più trendy come l’elettronica IDM, l’hip hop, il pop di matrice black e il rock, ma sono dovuti anche alla recente centralità assunta da tematiche anti-razziste, anti-coloniali, e di rivendicazione identitaria all’interno del dibattito sociale e politico attuale – che ben si sposano con quelle portate avanti da una musica da sempre pan-culturale e inclusiva il jazz. Quel che rimane, in ogni caso, è che anche solo dieci anni fa un fenomeno come la scena londinese non sarebbe stato nemmeno immaginabile; a partire dal 2018, invece, la locuzione “scena londinese” è diventata progressivamente una buzzword facilmente spendibile nella stampa musicale, pure da parte di gente che prima di Kamasi Washington poteva individuare al più in Lanquidity il loro ascolto jazz più recente.
Nel 2022, il jazz non avrà visto la pubblicazione di dischi spartiacque (a livello di consenso popolare piuttosto che di qualità effettiva) come The Epic o Your Queen Is a Reptile, ma ha continuato a far uscire album in numeri impressionanti, alcuni dei quali anche discretamente chiacchierati pure nei circoli alternativi – tra questi, ci siamo già occupati almeno dei Black Flower, di Mary Halvorson e degli Anteloper. Per questo, mimando la struttura della carrellata metal di qualche mese fa, vogliamo presentarvi (al solito senza alcuna pretesa di enciclopedicità) dieci lavori jazz usciti quest’anno appartenenti a quell’insieme scelto di dischi su cui c’è qualcosa di interessante da dire: spesso sulla musica, qualche volta sul modo in cui tale musica è stata percepita dal pubblico, qualche volta su altri aspetti collaterali ancora. In certi casi è un’occasione per recuperare roba che è stata piuttosto chiacchierata di cui non abbiamo avuto modo di scrivere approfonditamente in precedenza, ma contiamo comunque sul fatto che questo pezzo sia un’occasione per voi di scoprire qualcosa di nuovo e nascosto del jazz 2022. Buon ascolto.

I SOMMERSI
Binker and Moses – Feeding the Machine (Gearbox)
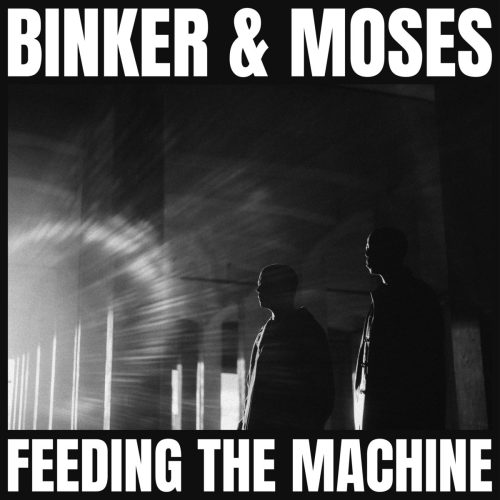
Nel 2017 Binker Golding (sassofonista) e Moses Boyd (batterista) si erano imposti come due delle voci più promettenti del jazz inglese grazie al monolitico Journey to the Mountain of Forever – o almeno così ve li vendevano all’epoca gli altri, da queste parti la loro formula tra neo-bop e free jazz venato qua e là di misticismo orientale un tanto al chilo non ha mai attecchito. Da allora, il progetto Binker and Moses sembrava essere in pausa: eccezion fatta per la pubblicazione di un paio di live insieme (Alive in the East?, uscito nel 2018, rimane forse tuttora il documento essenziale dell’attività del duo), i due avevano perseguito strade diverse sia come leader che come sideman – e forse anche per questo alcuni hanno accolto il loro ritorno in studio con Feeding the Machine in maniera particolarmente entusiasta. Sulla carta, il nuovo album targato Binker and Moses dovrebbe essere un ardito esperimento improvvisativo giocato interamente sul dialogo di sax e batteria, che viene alimentato e parzialmente indirizzato dai sample, dai loop e dalla live electronics dell’ospite Max Luthert – descrizioni molto simili a questa sono state riportate da più o meno chiunque si sia occupato del disco, probabilmente prendendo ispirazione dalle parole usate nello stesso press-kit presente su Bandcamp. Ancora una volta, però, Golding e Boyd disattendono prepotentemente le premesse, visto che il contributo di Luthert si esprime in un mero tappeto elettronico dal sapore ambientale e minimalista che si muove perpetuo sullo sfondo, subliminale quando non impercettibile in varie occasioni. E quando diciamo “impercettibile”, intendiamo che una delle prime volte in cui Luthert tenta davvero di imporre la propria presenza è quando manipola e riveste di bleep e glitch il sax di Golding nella prima metà di After the Machine Settles, dopo circa mezz’ora dall’inizio dell’album. Come sottolineato da molti, sia Golding sia Boyd sono buoni musicisti: il primo in particolare dimostra di aver ben assimilato la lezione di grandi tenoristi come Sonny Rollins e John Coltrane, mentre quando passa al sax soprano la sua voce riecheggia quella di John Surman – impressione particolarmente vivida quando Golding sfrutta overdub del proprio strumento durante l’improvvisazione, sempre sospesa su questo sfondo di tastiere che talvolta richiama le atmosfere fuori dal tempo di lavori ECM come Upon Reflection e Private City. Tuttavia, l’infelice scelta di relegare l’elettronica a un ruolo tanto marginale produce un vuoto nelle frequenze medio-basse che risulta quasi opprimente, mentre le frasi del sax e le escursioni della batteria continuano imperterrite con poche variazioni dal punto di vista timbrico e dell’interplay. La conseguenza naturale è che Feeding the Machine sfuma ben presto nella dimensione di piatta background music, e a poco valgono le deflagrazioni più free degne di Frank Lowe e Rashied Ali che il duo tenta di imbastire qua e là.
Heroes Are Gang Leaders – LeAutoRoiOgraphy (577)

Pur attivo dal 2014, ho scoperto il collettivo newyorchese Heroes Are Gang Leaders solo nel 2020 con il loro (all’epoca) ultimo album Artificial Happiness Button, che sembrava proporre una rielaborazione in chiave meno sferzante della formula degli Irreversible Entanglements. Vale a dire: testi poetici di matrice anti-capitalista e anti-razzista recitati sopra questo jazz post-free militante che richiama simultaneamente l’Archie Shepp di Fire Music e quello di Attica Blues – non a caso, sono nati in onore del poeta, attivista e critico jazz Amiri Baraka, i cui dischi anni Settanta tipo It’s Nation Time sono altri ottimi punti di riferimento per inquadrare gli Heroes Are Gang Leaders. Purtroppo però la loro musica manca dell’energia esplosiva che le parole sembrerebbero voler invocare, e pure i testi sono abbastanza monodimensionali da risultare più fastidiosi che infottanti. (A loro parziale discolpa, sono in buona compagnia nel crogiolarsi in questo difetto, e alcuni degli esempi più eclatanti in questo senso io li trovo in certa roba uscita per ESP-Disk’ ultimamente, come We’ve Had Enough di Fay Victor, del 2020.) Il loro ultimo LeAutoRoiOgraphy, gioco di parole non particolarmente brillante tra autobiography e LeRoi (il nome di battesimo di Baraka), contiene un’esibizione live risalente al febbraio 2019 e prosegue sulla scia di Artificial Happiness Button senza correggere assolutamente alcun difetto: groove funk che non sembrano portare da nessuna parte, intrecci corali di vocalità soul e jazz che citano titoli e versi di poesie di Baraka esaltandone le gesta letterarie, intrecci di sax dal sapore spiritual che ogni tanto si lasciano andare in skronk particolarmente dissonanti quando rapportati con la relativa placidità delle parti degli altri strumenti. Lungo l’ascolto, si percepisce sempre un sentimentalismo patetico che mal si sposa con certe asperità del suono del collettivo, e ci si continua a chiedere se LeAutoRoiOgraphy voglia essere un gioioso requiem per Baraka o una fiera intimazione alla militanza – probabilmente, la risposta degli Heroes Are Gang Leaders sarebbe “entrambe le cose”, ma è altrettanto chiaro che il gruppo non sia capace di coniugare musicalmente le due missioni in maniera adeguata. La mente torna spesso a un altro accorato tributo alla vita di un gigante della cultura nera (Curtis Mayfield), vale a dire quell’I Plan to Stay a Believer pubblicato da William Parker nel 2010 – per altro, in quel disco presenziava pure lo stesso Amiri Baraka. Anche in quel caso, si trattava di un disco che pur radicato nell’idioma free jazz non si faceva problemi ad aprirsi a scorci più funk e ad eruzioni soulful di celebrazione gioiosa; eppure, lì funzionava tutto ciò che gli Heroes Are Gang Leader non riescono a far funzionare su LeAutoRoiOgraphy.
Kokoroko – Could We Be More (Brownswood)

Nel 2018, dopo qualche anno che la gente aveva cominciato a prestare attenzione a ciò che veniva prodotto nei sobborghi inglesi, la Brownswood Recordings ha fatto uscire una compilation intitolata We Out Here, che sembrava voler urlare al mondo: è proprio così, la scena jazz londinese esiste, siamo giovani, siamo energici, e siamo qui. E in effetti dei musicisti che presenziavano su quel disco diversi si sono affermati e sono riconosciuti come alcuni dei più illustri esponenti di quel panorama – qualche nome: Theon Cross, Nubya Garcia, i Moses Boyd e Shabaka Hutchings citati giusto in questo articolo (ma c’è da dire che quest’ultimo era già un nome ingombrante prima di apparire su We Out Here). Di questi household name, prima di questo agosto, i Kokoroko erano gli unici a non aver ancora esordito su full-length – in realtà ci sarebbero anche i Triforce, ma a livello di popolarità e impatto sulla scena ci sono diverse categorie di differenza tra questi ultimi e gli artisti citati prima. Nonostante ciò, il loro EP omonimo del 2019 era stato comunque acclamato da più parti per un approccio originale all’afrobeat di Fela Kuti tramite il jazz funk di scuola CTI, colorato dal piglio incendiario della front line di sax contralto/tromba/trombone e dagli ammalianti fraseggi liquidi della chitarra. Perciò, dal loro debutto Could We Be More era lecito aspettarsi un’evoluzione di quelle sonorità tanto accattivanti. Non è stato così: anziché ridurre la componente più melensa per favorire quella nerboruta di pezzi come Adwa, i Kokoroko hanno fatto esattamente il contrario. La produzione di Could We Be More (molto più bass-driven e ovattata negli alti rispetto a Kokoroko) esalta i punti di contatto con il jazz funk più smooth della stagione anni Settanta e con il neo-soul contemporaneo, con melodie levigate dei fiati che rimandano direttamente alla stagione della blaxploitation e arrangiamenti ariosi di tastiere che sembrano pregare di essere usate come beat da un qualunque producer che voglia realizzare il disco hip hop conscious più noioso, prevedibile, e quindi acclamato dei prossimi due anni. Ogni tanto qualche pulsazione ritmica sembra voler tornare sui passi dell’afrobeat vitale del primo EP, ma per ogni Soul Searching e War Dance che prova a perseguire questa strada ci sono troppe più Tojo, Age of Ascent, Home, Those Good Times. Avrebbero potuto essere di più, i Kokoroko; e invece si sono accontentati di fare Could We Be More.
Shabaka – Afrikan Culture (Impulse!)

Forse c’è qualche lezione da imparare dal fatto che dei cinque dischi inseriti nella sezione “flop” di questo articolo, tre siano stati incisi da musicisti attivi in Inghilterra. Di questa schiera di artisti, Shabaka Hutchings è sicuramente l’esponente più illustre: barcamenandosi tra The Comet Is Coming, Ancestors, Melt Yourself Down, Heliocentrics e Sons of Kemet, la musica dei suoi numerosi suoi gruppi è stata – nel bene e nel male – la fotografia più nitida della poetica del nuovo jazz britannico, così contesa tra la celebrazione del proprio retaggio sudafricano e la contaminazione con le culture musicali che emergono dall’affollato melting pot etnico di Londra. Eppure, dopo oltre dieci anni di attività intensa, ad Hutchings mancava ancora una di quelle tappe quasi inevitabili per un sassofonista, ovvero un disco in solo – lacuna che è stata colmata verso fine maggio da questo EP, pubblicato semplicemente a nome Shabaka. Tuttavia, Afrikan Culture è un’opera completamente diversa dal solito album per solo sax, e in effetti è anche molto distante dai territori sondati dalla discografia di Hutchings in passato; a dirla tutta, è uno stretch anche il solo definirlo “jazz” («e allora perché parlarne in un articolo del genere?» perché mi andava di farlo). Il suono di questo EP, ascetico e solenne, è delicatamente tratteggiato da strumenti provenienti dalle tradizioni più disparate – sassofoni, clarinetti, shakuhachi, mbira, kora e tastiere con opportuni overdub, tutti suonati dal solo Hutchings: ne emerge uno soundscape ipnotico che rievoca rituali ancestrali, un tenue acquerello che suggerisce corrispondenze con le musiche tradizionali dell’Africa e, in misura minore, dell’Asia. A giudicare da quello che sappiamo di Hutchings (compresa la sua passione per improvvisazioni estemporanee in contesti urbani e naturali dal carattere pensoso e spirituale) e dalla scelta di titoli come Black Meditation, Ritual Awakening, Explore Inner Space o Rebirth, è lecito supporre che lo scopo che il sassofonista si è prefissato mentre componeva Afrikan Culture fosse proprio quello di scrivere una musica votata alla meditazione e all’espansione della propria coscienza; tuttavia, quello che si ricava da questi ventotto minuti è una musica in cui purtroppo non accade nulla, concettualmente molto, troppo vicina a quella di quei lavori di new age jazzata e patinati di glassa misticheggiante che vari musicisti jazz usavano pubblicare negli anni Sessanta – mi riferisco a robe come Inside di Paul Horn o Music for Zen Meditation di Tony Scott, per intenderci. Qua e là si può apprezzare il timbro degli strumenti o lo stile di Hutchings, che si percepisce ancora nelle sue frasi di clarinetto e shakuhachi; ma Afrikan Culture manca di brio e creatività, e lo vedrei bene nelle sezioni dei supermercati con le registrazioni del rumore della pioggia e dell’acqua che scorre.
Tyshawn Sorey Trio – Mesmerism (Yeros7)

Se ci seguite, non avete alcun tipo di scusa per non sapere ciò che Tyshawn Sorey fa nella sua vita di musicista e compositore: abbiamo ripetuto in ogni salsa quanto la sua discografia per Pi Recordings sia una delle saghe più innovative e visionarie della musica anni Dieci, senza trascurare però ciò che è stato capace di offrire anche su altre etichette (come, per esempio, il capolavoro Pillars). Per Sorey questo è stato un anno di magra: questo Mesmerism è uno dei soli due dischi finora usciti nel 2022 a vederlo come performer – il che la dice lunga sull’estrema prolificità che ha mantenuto nel recente passato. Nonostante sia accreditato al Tyshawn Sorey Trio, l’ensemble che suona su Mesmerism è però molto diverso dal trio Sorey/Tordini/Smythe che suonava sui dischi usciti per Pi. Al basso troviamo Matt Brewer, un musicista che – pur a suo agio in contesti più astratti – nei suoi album da leader si è specializzato in quella forma di hard bop moderna ed elastica che ha fatto la fortuna della Criss Cross Jazz; al pianoforte c’è invece Aaron Diehl, che non conosco ma che a occhio non è esattamente il pianista più avanguardista sulla piazza. E anche il materiale è completamente inedito rispetto alla poetica cui Sorey ci ha abituato negli ultimi anni: Mesmerism è infatti una dichiarazione di amore nei confronti dell’American Songbook (e di quei brani che, secondo Sorey, dovrebbero esservi inclusi), volutamente inciso da un gruppo senza esperienza pregressa in poche ore di prove, completamente dedicato a riproposizioni di standard jazz. La selezione dei pezzi copre compositori come Horace Silver (Enchantment), Bill Evans (Detour Ahead), Muhal Richard Abrams (Two Over One), Paul Motian (From Time to Time) e Duke Ellington (REM Blues), oltre allo standard Autumn Leaves. Ciò nonostante, anche all’infuori di Detour Ahead, è il trio di Bill Evans l’evidente riferimento nella performance di questo gruppo: Mesmerism è un disco anemico, giocato tra il pianismo rilassato e avvolgente di Diehl (che, come Evans, rifugge dolcemente dal centro tonale dei propri brani senza puntare ad asperità timbriche o divagazioni particolarmente erratiche) e dagli elaborati contrappunti di Brewer, sorta di Scott LaFaro di questa session. Come è successo anche ad altri luminari del jazz d’avanguardia, tipo Anthony Braxton, l’incontro tra Sorey e gli standard di altri compositori produce una musica che scorre via senza lasciare troppo il segno, o talvolta lasciandolo anzi in negativo (il confronto tra il pianismo swingante e trascinante di Ellington dell’originale REM Blues e quello invece ingessato esibito da Diehl in questa versione è sinceramente impietoso). Le uniche eccezioni sono forse Autumn Leaves e soprattutto From Time to Time, dove approfittando del carattere già evanescente della composizione originale Sorey prende la melodia principale e la usa come trampolino di lancio per una delle sue caratteristiche divagazioni sfilacciate e impressioniste. Ma non sarà di certo un passo falso occasionale a mettere in dubbio la statura di un gigante contemporaneo come Sorey ai nostri occhi.

I SALVATI
Keefe Jackson / Oscar Jan Hoogland / Joshua Abrams / Mikel Patrick Avery – These Things Happen (Astral Spirits)

Se del bassista Joshua Abrams abbiamo seguito abbastanza attentamente le sue avventure tra jazz spirituale, trance psichedeliche e ostinati minimalismi con la sua Natural Information Society – così facendo, prestando attenzione anche a Mikel Avery, che di quell’ensemble è il percussionista – meno noto ci è il background del pianista Oscar Jan Hoogland e del sassofonista Keefe Jackson, che pure a quanto pare possono vantare una discreta mole discografica di cui personalmente non conosco nemmeno mezza nota. Eppure, se si vuole cercare un leader in questa breve session (appena ventidue minuti di musica per sei brani), forse la scelta dovrebbe ricadere proprio su Hoogland: il suo pianismo poliglotta, colmo di swing ma anche delle astrattezze armoniche di Thelonious Monk, è tra gli elementi più prominenti di questo These Things Happen, ed è sempre lui il firmatario dei due unici numeri originali di questo set, ovvero la dolce ballata (ma con twist erratico sul finale) Wimpel e il giocondo avant-garde Aanhanghuis, dominato da sibillini motivi di pianoforte disegnati sul registro acuto dello strumento e da assoli serpentini di sax sopranino – l’head è uno dei più divertenti mi sia capitato di ascoltare nel 2022. E forse non è un caso che per completare questo EP si sia scelto di reinterpretare proprio dei pezzi presi dall’almanacco di grandi innovatori del piano jazz – vale a dire Epistrophy e Bemsha Swing di Monk, Gotta Get Some Sleep del sassofonista Dewey Redman (ma composto per l’album Bop-Be del quartetto americano di Keith Jarrett), e The Happenings di Herbie Nichols. Sono versioni abridged ridotte a pochi minuti che dei pezzi originali mantengono solo il tema principale, e talvolta neppure questo è immediatamente riconoscibile: su Gotta Get Some Sleep arriva solo dopo un minuto buono di divagazioni collettive in & out, su Bemsha Swing addirittura il sax lo esegue in maniera sgangheratissima, ribadendo ogni nota della melodia più volte mentre sotto la base ritmica suona la propria impressione dell’Andrew Hill di Compulsion. (Su Epistrophy, invece, il motivo è quello, immutato e immutabile: scelta saggia da parte del quartetto, visto che qualsiasi altra opzione avrebbe sfigurato di fronte a una delle melodie più sublimi della storia del jazz.) Tuttavia, forse la cover più sfiziosa è quella di The Happenings, probabilmente perché essendo molto meno praticata e nota delle altre (non si conoscono nemmeno registrazioni di questo brano incise da Nichols) il suo incedere marziale, dal sapore comunque inconfondibilmente nicholsiano, apre mondi su cui non mi sono mai affacciato. Con musica tanto spassosa, è veramente un peccato che ci si debba accontentare di soli venti minuti e spicci.
Nduduzo Makhathini – In the Spirit of Ntu (Blue Note)

In aprile, la Blue Note e la Universal hanno annunciato con orgoglio uno dei più interessanti progetti discografici degli ultimi anni, ovvero la Blue Note Africa, con l’esplicito scopo di pubblicare la musica di jazzisti provenienti esclusivamente dal continente africano. È un’idea che, a livello storico, è giustificata ampiamente dall’importante contributo che la cultura africana ha dato al jazz anche ben dopo il suo concepimento – a tal proposito, nell’articolo linkato si fanno giustamente i nomi di Art Blakey e McCoy Tyner – ma che in un’epoca in cui tutti siamo più attenti a ciò che accade (musicalmente parlando, perlomeno) al di là del Primo Mondo assume una ricchezza di significati ancora più ampio. Musicisti jazz provenienti dai margini dell’impero trovano finalmente un canale preferenziale attraverso il quale veicolare il proprio lavoro, e per di più tale canale è fornito da un gigante della discografia jazz mondiale (pur obiettivamente in decadenza rispetto ai fasti degli anni Cinquanta e Sessanta). La Blue Note Africa è stata infine varata ufficialmente a fine maggio con la pubblicazione di In the Spirit of Ntu del pianista Nduduzo Makhathini, che per Blue Note aveva già pubblicato Modes of Communication: Letters From the Underworlds ma che probabilmente è più noto al pubblico generalista per il suo lavoro come tastierista per gli Ancestors di Shabaka Hutchings. Il disco, lo chiariamo subito, non è imperdibile: le concessioni alle derive più mainstream e laccato del neo bop a volte danno lo spiacevole senso di una musica che, pur avendone le possibilità, preferisce (o forse è costretta) a rimanere addomesticata e giocare su binari più safe. Tuttavia, in ogni pezzo diversi dettagli sembrano indicare a una via più selvatica e vitale: il fraseggio sinuoso del pianoforte di Makhathini, che da melodie hard bop è capace di divagare verso uno stile più febbrile e percussivo; la ritmica del batterista Dane Paris e del bassista Stephen de Souza, che insieme imbastiscono un groove vigoroso e trascinante che spesso sfuma in intrecci poliritmici; le profonde inflessioni delle voci ospiti, che restituiscono le vibrazioni del canto del jazz e del pop sudafricano (certe linee, come quelle di Omagugu Makhathini su Mama, sembrano pronte per essere campionate su qualche produzione amapiano). Ma più di tutto, colpisce la delicatezza e il gusto del vibrafonista Dylan Tabisher, che si accontenta di un delicato ma prezioso lavoro dietro le quinte aggiungendo tridimensionalità e dinamismo ritmico all’ensemble del gruppo – anche quando la musica si adagia troppo tranquillamente su territori “americani”, è lui a speziare i brani con poliritmi e riff subliminali che riescono comunque a rubare la scena alla front line degli ottoni. E certe volte, tutti questi dettagli si sintetizzano in brani ottimi e compiuti Unonkanyamba e Amathongo su tutti. Dategli una chance.
Myra Melford’s Fire and Water Quintet – For the Love of Fire and Water (RogueArt)
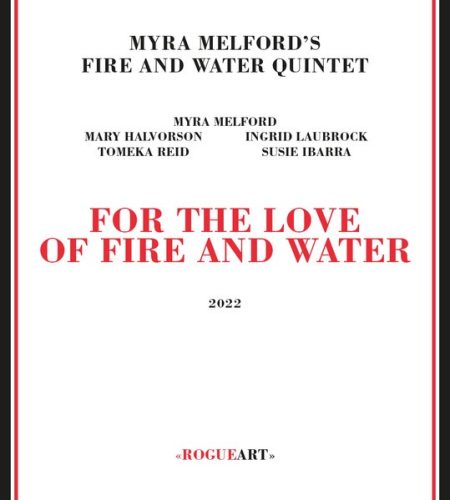
Dall’alto dei suoi sessantacinque anni, Myra Melford è l’unica musicista presente in questa selezione il cui output artistico appartiene effettivamente a un’epoca diversa dalla contemporaneità: ha cominciato a registrare dischi a partire dalla fine degli anni Ottanta, e diverse sue incisioni degli anni Novanta come Alive in the House of Saints o Even the Sounds Shine sono da annoverarsi come modern classic del pianismo jazz; se poi si aggiungono anche registrazioni da sideman per Henry Threadgill (Makin’ a Move), John Zorn (Cobra Live at the Knitting Factory) e Butch Morris (Dust to Dust e le conduction n. 38, 39 e 40 poi apparse su Testament), si delinea un profilo originalissimo e poliglotta, che ha dato un contributo fondamentale all’evoluzione del lessico del piano jazz degli ultimi trent’anni. For the Love of Fire and Water è simultaneamente il titolo della sua ultima opera e il nome del quintetto che la suona, composto da una formazione all-star femminile che vanta Ingrid Laubrock (sassofono), Mary Halvorson (chitarra), Tomeka Reid (violoncello), Susie Ibarra (batteria e percussioni). L’ispirazione per la musica di questo suo ultimo ensemble proviene dal ciclo Gaeta Set: For the Love of Fire and Water del pittore Cy Twombly, di cui però Melford non vuole semplicemente esprimere la sensibilità in linguaggio musicale, né tantomeno vuole emulare l’espressione artistica; piuttosto, Melford parla esplicitamente di voler instaurare un dialogo con l’opera di Twombly, il cui gesto pittorico in sé è percepito come molto affine al suo approccio al pianoforte – fisico, materico, fatto di linee impulsive e urgenti che restituiscono un’energia dinamica e al contempo estrosa. In realtà, i dieci movimenti di For the Love of Fire and Water, che come spesso accade in questi ambiti d’avanguardia jazz è in parte composta e in parte improvvisata, non sono sempre così arrembanti e intensi; anzi, il quintetto non si esime dal concedersi momenti più pensosi e contemplativi, giungendo a un algido jazz da camera dal sapore minimalista – un sapore che, va detto, si è spesso potuto apprezzare nella discografia di Melford. Si può forse imputare una certa sameness umorale a questa registrazione, che comunque beneficia della creatività eclettica di strumentiste strabilianti come Reid e Halvorson, che con i loro glissando e pizzicato (la prima) e con le loro distorsioni oblique (la seconda) offrono sempre tanti spunti timbrici da seguire, anche quando le sonorità si distendono in atmosfere più letargiche; tuttavia, rimane musica estremamente creativa in cui è sempre ben distinguibile l’originale idioma proprio dell’universo musicale di Melford – universo che, tra aspri momenti di avanguardia post-free come III e V, è capace anche di esplodere in groove sghembi (II) e in numeri più istrionici che richiamano anche le bislacche composizioni di Henry Threadgill per i Very Very Circus (VII). Recuperatelo.
Rhabdomantic Orchestra – Almagre (Agogo)

La Rhabdomantic Orchestra di Manuel Volpe è uno dei segreti meglio celati della musica italiana – anche se, visti i suoi obiettivi artistici apertamente pan-culturali, è forse un po’ riduttivo rivendicarla come un prodotto solamente italiano. Fondata a Torino nel 2014, la Rhabdomantic Orchestra ha fatto dell’esplorazione di un Mar Mediterraneo immaginario la propria principale poetica: un Mediterraneo di un’intensità viscerale e sanguigna, che profuma sì di musica mediorientale e folk nord-africano ma che contiene anche suggestioni dall’afrobeat dell’Africa continentale e dai generi popolari dell’America Latina, magari con il twist avant- della Vanguarda Paulista. La musica di Almagre scaturisce, quasi naturalmente e senza sforzo artificioso, dal denso accumularsi di temi di sax tenori dall’inconfondibile sapore latin, delicati volteggi di flauti bossa nova e samba che occasionalmente sfumano in suoni che potrebbero provenire da un ney (cfr. El martir), fraseggi di chitarra liquidi sullo sfondo, ritmiche dub e funk che insieme alle linee di organo Hohner e Farfisa si avvicinano tanto al rock sperimentale e selvaggio dei Moonshake quanto al jazz cosmico dei The Comet Is Coming, addirittura acquerelli di tastiere e manipolazioni di nastri in reverse su Woland’s Dance e Siber: ne emerge una musica inclassificabile che, nella sua stratificazione in tante micro-vignette sonore e nel suo impianto simultaneamente atmosferico e melodico, non può non ricordare la gloriosa stagione della library music italiana degli anni Settanta. Allo stesso tempo, però, Almagre è un carnevale coloratissimo di ritmi propellenti e timbri variopinti che, pur raccolti dai quattro angoli del pianeta, finiscono con decisione per indirizzare il Nord magnetico della nostra bussola mentale verso il Sud America (il cui realismo magico, Volpe afferma, è effettivamente la fonte di ispirazione principale per Almagre insieme all’estetica surrealista). È un’impressione anche rafforzata dalla performance vocale di Maria Mallol Moya, artista colombiana qui alle prese con testi in castigliano, francese e inglese: il suo timbro suadente e misterioso, sopra una musica tanto ricca di rompicapi ritmici e armonici, finisce inevitabilmente per suonare particolarmente simile a quello di Juçara Marçal dei Metá Metá, specialmente su brani come Suffer! Suffer! e Cadenas y Amanecer. Almagre è un disco affascinante e bellissimo, che in poco più di mezz’ora apre scorci pittoreschi sulle tradizioni musicali più disparate portando avanti un discorso logico e coerente per tutta la sua durata: lavori del genere – molto più che crossover stantii e scontati tra jazz arcadico e folk orientale che vengono spesso incensati solo perché escono per ECM – portano davvero avanti quel discorso di folklore immaginario che jazzisti come Don Cherry avevano intrapreso negli anni Sessanta e Settanta. Fatelo vostro a tutti i costi.
Joel Ross – The Parable of the Poet (Blue Note)

Joel Ross non è un nome nuovo su Livore: estasiati dalla sua prima prova da leader su KingMaker nel 2018, e ulteriormente impressionati dalla sua performance per il quartetto Being and Becoming di Peter Evans due anni più tardi, abbiamo dedicato molte parole per analizzare nel dettaglio le sue capacità tecniche e soprattutto il suo gusto peculiare come arrangiatore, compositore ed esecutore, qualità che l’hanno reso uno degli astri nascenti del vibrafono jazz degli ultimi anni. Dopo il mezzo passo falso di Who Are You? del 2020, The Parable of the Poet è il suo terzo disco pubblicato per Blue Note, e rappresenta un parziale ritorno alla brillantezza di quell’album di debutto per la storica etichetta americana. Supportato da un ottetto composto da molti nomi caldi della scena neo- e post-bop della East Coast, comprendente anche gente come Immanuel Wilkins e Maria Grand (sax contralto e tenore, rispettivamente), Marquis Hill (tromba) e Craig Weinrib (batteria), Ross scrive una lunga suite in sette movimenti che vaga in maniera brillante e creativa per tutto lo spettro del jazz mainstream, da brani delicati del calibro di Prayer, The Impetus (To Be and Do Better) e Benediction, infusi della spiritualità del gospel e del blues, a pezzi più elastici come Choices e Wail, dove i dettami ritmici si fanno più sfumati e le improvvisazioni dell’ensemble raggiungono un’espressività più intensa che fa pensare perfino al Coltrane modale – anche per via dell’enorme influenza che la sua figura esercita sullo stile di Wilkins. È una musica colma di lirismo anche nei suoi momenti più accidentati, meno vibrafono-centrica rispetto a KingMaker e più legata a un’esecuzione corale, dove le voci dei singoli strumentisti si mischiano e si confondono, talvolta perfino imbastendo assoli all’unisono che si contrappuntano in una maniera sorprendentemente caotica per gli standard cui Ross ci ha abituato – i suoi lead e quelli di Wilkins nella seconda metà di Wail offrono forse la dimostrazione più luminosa delle capacità di Ross di giocare con le dinamiche e i timbri che il gruppo mette a sua disposizione. Ciò non nega l’impostazione essenzialmente tradizionale della musica di The Parable of the Poet, che non impedisce ai singoli strumentisti di mettere in risalto le proprie capacità solistiche – pur ricollocando i loro assoli in maniera creativa e fluida all’interno delle texture dell’ottetto: ne ne è un esempio l’assolo di contrabbasso di Rick Rosato che apre Guilt, o la sommessa outro per trombone portata avanti da Kalia Vandever, o il sinuoso fraseggio della front line di ottoni che viene incalzato da contrabbasso, batteria e vibrafono su Doxology (Hope). Non sono un grande fan dei momenti più soulful, ma all’infuori di questi The Parable of the Poet offre un altro gustoso assaggio del processo di maturazione di Ross.