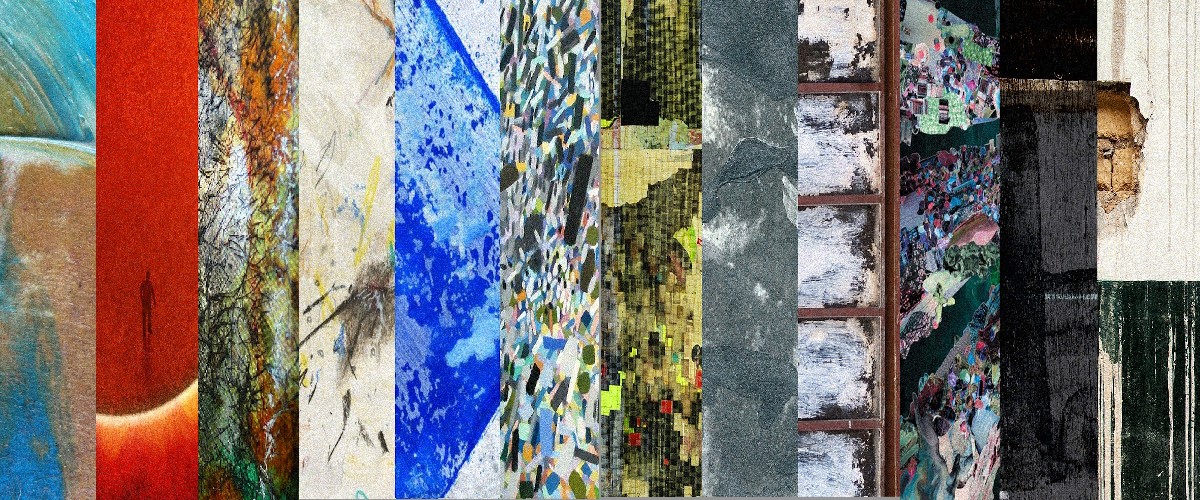Con gli anni Dieci del nuovo millennio giunti quasi al termine, e tenendo fede al nostro credo secondo cui entità dallo spessore artistico enorme meritano articoli che rendano loro giustizia, era doveroso costruire una disamina approfondita della Pi Recordings, un’etichetta dietro a parecchie opere molto vicine ai nostri cuori. Questo articolo è lungo e molto denso – in quanto originariamente creato per essere suddiviso in quattro parti – ed è pertanto da leggere con calma, un poco alla volta, entrando passo dopo passo in un ecosistema da molti inesplorato. Se avrete la voglia di spendere tempo leggendo con attenzione e ascoltando dischi il cui significato non vi salta in faccia subito e la cui estetica stimola la vostra testa invece di farla atrofizzare, è nostra speranza che alla fine questa etichetta rimanga vicina anche a voi.

In questo decennio, forse per la prima volta dagli anni Settanta, il jazz ha ricevuto una rinnovata, per quanto modesta, attenzione anche tra un pubblico esterno alla ristretta cerchia di addetti ai lavori e appassionati del genere. I motivi sono molteplici: di certo il riaccendersi del dibattito sulle questioni razziali, coadiuvato dall’affermarsi sulle scene mainstream di artisti come Kendrick Lamar e BADBADNOTGOOD (che hanno integrato il jazz in generi dal numero di ascoltatori ben più vasto come l’hip hop, e che hanno aperto la strada ai vari Kamasi Washington e Thundercat che hanno dominato le scene in questi anni), ha giocato un ruolo fondamentale nella riscoperta di un genere di musica storicamente nero e afro-americano. Probabilmente, non va sottovalutata nemmeno la frequente pubblicazione di lavori “perduti” o dimenticati in un cassetto che ha caratterizzato questi anni. L’ultimo di questa serie è il nuovo di zecca Rubberband, che Miles Davis cominciò a registrare nel 1985 e che non vide mai la luce; ma non si può non citare almeno il caso più emblematico del decennio, Both Directions at Once, che l’anno scorso ha riscosso un successo enorme – ben superiore a quanto l’effettiva importanza della musica contenuta potesse giustificare.
Come già spiegato a suo tempo, però, questo interesse da parte del pubblico generalista è un fuoco di paglia. Alla fine a beneficiarne sono solo quegli artisti già estremamente famosi fuori dagli appassionati irriducibili oppure gli emergenti che hanno potuto approfittare di una vicinanza musicale di qualsiasi tipo con il mondo della musica popular, di un’estetica particolarmente rivendibile al pubblico pop/rock appassionato di problematiche razziali identitarie, o di entrambe. Dei lavori d’archivio hanno fatto clamore solo quelli di John Coltrane e in misura minore di Miles Davis, ma sono passati virtualmente inosservati dalla stampa e dal pubblico i tentativi analoghi con opere di Thelonious Monk, Eric Dolphy o Sam Rivers (il suo Emanation di quest’anno, primo di una lunga serie di ripescaggi inediti dal suo repertorio, è particolarmente gustoso, di certo più di Rubberband, ma è pacifico sostenere che abbia molto di più da offrire anche rispetto allo stesso Both Directions at Once). E per quanto oggigiorno si sprechino le infusioni di elettronica, pop, rock, neo-soul, funk e hip hop nel jazz mainstream del nuovo millennio, o il recupero della spiritualità pan-africana del jazz spirituale ed elettrico anni Settanta, i nomi davvero frequentati sono sempre e inevitabilmente quelli di Kamasi Washington, dei BADBADNOTGOOD, di Flying Lotus, e poco altro. Forse solo la scena jazz inglese (e in particolar modo quella londinese), grazie al suo suono urbano e moderno a metà tra spiritualità afro-americana, fusion, elettronica e hip hop, è riuscita a guadagnare qualcosa in termini di popolarità da questa situazione. Non sarà quella più creativa e innovativa tra quelle attualmente attive, ma non si può ignorare il successo e i riconoscimenti riscossi in questi anni dai vari Ill Considered, Binker Golding e Moses Boyd, Alfa Mist, Yussef Dayes e Kamaal Williams, Nubya Garcia e, ovviamente, da Shabaka Hutchings e i suoi (esageratamente sopravvalutati) The Comet Is Coming e Sons of Kemet.
In ogni caso, nonostante tutte le serie di luoghi comuni sul jazz ucciso dagli ambienti angusti delle accademie e da conservatori come Wynton Marsalis che l’hanno fossilizzato in una forma “classica” e poco aperta alle contaminazioni, il jazz degli anni Dieci ha davvero sfoderato una pluralità di linguaggi, un eclettismo e una vivacità come pochi altri generi e stili hanno fatto in questo periodo di tempo. I contributi positivi a questo status di salute della musica jazz provengono da ogni luogo e direzione e attraverso le proposte stilistiche più disparate. Etichette affermate come la ACT Music e la Criss Cross Jazz hanno prodotto alcuni dei lavori più belli del panorama neo-bop e post-bop di questi tempi (giusto un paio di nomi per chi fosse interessato: Accelerando di Vijay Iyer e Bird Calls di Rudresh Mahanthappa per la ACT, Destinations Unknown di Alex Sipiagin, Exception to the Rule di John Escreet e Today’s Opinion di Yosvany Terry per la Criss Cross), mentre la scena latina e afro-cubana ha ritrovato una nuova linfa creativa tramite l’operato di personaggi di spicco come Arturo O’Farrill, Miguel Zenón, Dafnis Prieto o Aruán Ortiz (che hanno ricevuto importanti premi in America); nel frattempo, una nuova generazione di artisti sotto l’egida della Ropeadope (Christian Scott, Mark de Clive-Lowe, più recentemente Logan Richardson) e della International Anthem (Makaya McCraven, Jaimie Branch, Ben LaMar Gay) ha sposato il formato del jazz con i suoni, le tecniche e l’estetica contemporanea di generi come l’hip hop, la drum & bass, la breakcore, finanche la trap. E tutto questo senza menzionare i contributi di numerosi nuovi interpreti di spicco (come Matana Roberts, Ambrose Akinmusire, Mary Halvorson, Nicole Mitchell), di vecchie glorie affermate da tempo che hanno pubblicato lavori notevoli (Wadada Leo Smith, Nels Cline, Steve Coleman) e promettenti stelle emergenti (l’ultima è Joel Ross, che ha fatto uscire per la Blue Note il suo esordio KingMaker proprio quest’anno e si appresta a diventare una delle nuove star del vibrafono dopo Stefon Harris). O, volendosi spingere al limitare del mondo jazz verso quello dell’improvvisazione non idiomatica che da esso comunque prende piede, si potrebbe parlare dei nuovi sviluppi dell’improvvisazione elettroacustica e delle sue ripercussioni sul jazz (cfr. Rob Mazurek, Nate Wooley, Christian Lillinger, e soprattutto il quintetto di Peter Evans), oppure delle improvvisazioni per solo sax di derivazione post-minimalista che da Colin Stetson (non il migliore del gruppo, comunque) in poi sono tornate in auge negli ultimi anni con i vari Keir Neuringer e Battle Trance (un ensemble di sassofoni a dire il vero, ma la sostanza non cambia poi molto). La quantità di nomi da fare è virtualmente sterminata, e qui non si ha la minima pretesa di stilare un elenco anche solo lontanamente esaustivo.
In questo panorama in continuo fermento, la Pi Recordings di Seth Rosner e Yulun Wang ricopre comunque un ruolo di spicco. Di certo non sarà l’etichetta più famosa attualmente in attività, e sicuramente non ha ancora l’influenza e la nomea che ancora appartiene a un gigante in rovina come l’ECM, che nonostante non produca più nulla di davvero interessante nell’ambito jazz da diversi decenni (a parte Far from Over di Vijay Iyer, Bells for the South Side di Roscoe Mitchell, e qualche altro fuoco fatuo), continua a essere la label più chiacchierata e in vista tra coloro che ricercano il jazz meno ortodosso. Ancor più di certo (come la sfilza di nomi sciorinata qui sopra testimonia), la produzione Pi non è l’unica responsabile dell’ottimo stato di salute attuale del jazz e delle varie musiche corollarie. Sicuramente, però, la Pi Recordings è tra le etichette che maggiormente hanno contribuito a rinnovare la tradizione jazzistica nel nuovo millennio grazie a una proposta sempre rivolta al nuovo, a un’estetica coerente in tutte le sue uscite nonostante la diversità di generi e sensibilità dei suoi interpreti, e – più semplicemente – a una quantità considerevole di dischi bellissimi, tra i più creativi di questi ultimi anni nell’ambito jazz (e non solo), che hanno ridefinito i canoni del jazz d’avanguardia della East Coast. Non è un caso perciò che la Pi sia una delle etichette che continua a guadagnare più consensi tra la critica jazz, che sempre più frequentemente inserisce i dischi del repertorio Pi nelle chart di fine anno – anche il prestigioso critico Nate Chinen del New York Times ha inserito varie registrazioni Pi tra la sua lista dei migliori 129 album jazz del nuovo millennio nel suo ultimo libro Playing Changes: Jazz for the New Century.

La Pi non è esattamente una novità degli anni Dieci. Fu fondata nel 2001 da Seth Rosner, che era stato manager della Knitting Factory Work dal 1997 al 1999; lavorando lì era entrato in contatto con Henry Threadgill, e aveva quindi deciso di mettersi alla prova inaugurando una nuova etichetta tramite la quale produrre e distribuire in completa autonomia un paio di suoi lavori. Nel novembre del 2001, videro la luce i primi due dischi della Pi Recordings, cioè Every Mouth’s a Book (PI01) e Up Popped the Two Lips (PI02). Dall’anno successivo, Rosner venne affiancato da Yulun Wang, ex finanziere, rimasto folgorato da quei dischi di Threadgill; ad oggi, sono ancora loro due a guidare la label.
Da allora, la Pi è stata l’osservatrice più fedele dello stato di salute della scena underground di New York. Rosner e Wang partecipano direttamente ai concerti nella Grande Mela per trovare nuovi talenti e saggiare personalmente le voci dei musicisti attivi nell’area, e una volta scritturato un artista, Rosner e Wang assistono alle sue prove in studio per essere testimoni oculari dello sviluppo delle sue idee, della direzione delle sue composizioni, del progresso delle registrazioni. Non sorprende quindi che la Pi abbia prodotto solo un’ottantina di dischi in quasi vent’anni di attività, di cui circa cinquanta negli ultimi dieci anni: la politica adottata è “cinque album pubblicati ogni anno”, in modo da dare possibilità agli artisti di registrare e lavorare con calma, e a Rosner e Wang di curarne adeguatamente la pubblicità e la distribuzione. Anche per questo, la Pi non firma contratti esclusivi, permettendo ai propri artisti di registrare in libertà assoluta con altre etichette – cosa che va a vantaggio di entrambe le parti, generalmente. Con un modus operandi tanto anacronistico, ci si potrebbe chiedere come la Pi sia riuscita a sopravvivere così a lungo in un mondo in cui l’industria discografica sta subendo un’importante battuta d’arresto di fronte ai nuovi servizi di streaming e download. In principio, è stato il legame con l’AACM a permetterle di andare avanti nonostante l’esigua quantità di materiale registrato: nei primi anni Duemila, la Pi divenne un’etichetta di approdo per molti giganti dell’organizzazione (non solo Henry Threadgill, ma anche Roscoe Mitchell, Anthony Braxton, Wadada Leo Smith, l’Art Ensemble of Chicago, perfino il fondatore Muhal Richard Abrams), che ne dettarono anche un po’ l’estetica progressiva ed eclettica che perdura, pur con qualche variazione e aggiornamento, ancora oggi. (Dedicated to the Innovative è, da sempre, il mantra che dirige l’operato di Rosner e Wang.) Non a caso, i primi artisti emergenti assoldati dalla Pi sono stati tutti affiliati in qualche modo all’AACM: Vijay Iyer, pianista tra i più brillanti e originali del nuovo millennio, aveva suonato con Leo Smith; Rudresh Mahanthappa, particolarissimo sassofonista indo-americano che ha esplorato per tutta la sua carriera il rapporto tra la musica jazz e le sue radici indiane, suonava nei gruppi di Iyer; Steve Lehman era stato studente di Anthony Braxton. E così via.

Ora, dopo quasi vent’anni di lavoro, la Pi vanta contratti con molti dei personaggi dalle voci più innovative e uniche del panorama jazz e improvvisativo tout court attualmente in circolazione, che infatti riscuotono giustamente sempre più successo (almeno tra la critica specializzata). Certo, fin dalle prime registrazioni risalenti ai primi anni Duemila era evidente un certo pluralismo di generi, identità, culture, stili e attitudini: basti pensare a In What Language? di Vijay Iyer e Mike Ladd (PI09, 2003), un disco di nu jazz dalla forte impronta elettronica e hip hop centrato sul razzismo subìto da persone di colore negli aeroporti americani; oppure a Mother Tongue di Rudresh Mahanthappa (PI14, 2004), particolare risposta del sassofonista alla superficialità e ignoranza con cui la moltitudine di culture da cui provengono gli indo-americani viene percepita negli Stati Uniti; o ancora a Two Rivers di Amir ElSaffar (PI24, 2007), legato indissolubilmente alla tradizione araba e soprattutto a quella iraqena. Ma negli ultimi anni questo aspetto si è ulteriormente accentuato, e ora ogni artista della Pi sembra indagare percorsi musicali totalmente personali e inesplorati.
«Obviously, we want every jazz fan to buy all of our records. But really where we gauge our success is how we’re able to reach out beyond that. How we’re able to get not even a casual jazz fan, but a culture consumer who may just say: ‘You know what? I don’t own a single jazz record, other than some Miles Davis and some Duke Ellington. But this sounds interesting.’ That’s always what makes the difference for us.»
Yulun Wang
Forse il più importante artefice di questo ampliamento di prospettiva è stato Steve Coleman, già luminare della scena avant-garde di New York negli anni Ottanta. Mentre John Zorn e i suoi accoliti cominciavano a sperimentare con una ripresa post-moderna del bop e del free jazz che nel nome di un assurdo umorismo iconoclasta macinava musica aleatoria, colonne sonore, metal, no wave, elettronica, turntableism, world music e klezmer, Steve Coleman muoveva i suoi primi passi a partire dal free funk di Ornette Coleman e dei suoi Prime Time, oltre che dall’esperienza di musicisti jazz che si sono sempre mossi con elasticità ed eclettismo tra un contesto tradizionale e quello free jazz (Sam Rivers, David Murray, e Dave Holland in particolare). La musica di Steve Coleman respirava quindi l’aria urbana e metropolitana di New York, giocando moltissimo sui ritmi della cultura pan-africana in ogni sua manifestazione (dal funk e il jazz funk, all’hip hop, alla musica tradizionale cubana, latina e africana), ma era radicata negli idiomi di alcuni dei più unici improvvisatori del jazz americano: a una proposta tanto unica, Coleman attribuì il nome di M-base – in realtà, più una filosofia di vita e una forma mentis, piuttosto che un genere vero e proprio.
«I wanted to be able to look at a mountain and play the mountain. I used to tell my friends that, and […] they said, “What do you mean? You mean being inspired by the mountain?” I said, “No, not just inspired. Of course I’m inspired by it, but I want to play the mountain, literally, play the mountain.” They said, “Well, what do you mean by that?” I said, “I want to look at the mountain and see something like notation and be able to play it.” They thought I was crazy. They would just dismiss what I was saying. But I was serious. I wanted to be able to look at the flight pattern of a bee, the flight pattern of a bird, and play that. Or have that directly influence my music, so almost be able to look at nature as one big gesture. You can call it notation. I mean, what is notation? It’s a bunch of symbols that tell you, don’t do this, do this. But I wanted to be able to look at life with my eyes as well as with my ears and be able to translate that into sound. That was, and still is, one of my biggest things.»
Steve Coleman
Se i dettami dell’M-base hanno portato negli anni Ottanta a dischi che tradiscono ancora i legami con il funk più smooth del periodo (vedasi Motherland Pulse e World Expansion (By the M-Base Neophyte)), negli anni Novanta hanno invece partorito alcuni dei lavori più importanti del decennio, da Black Science e The Tao of Mad Phat (Fringe Zones) al capolavoro Genesis & The Opening of the Way passando per il grandissimo studio sulla musica afro-cubana di The Sign and the Seal.
Nel nuovo millennio, la maggior parte della produzione di Steve Coleman è stata registrata con il supporto dei Five Elements, un gruppo di (appunto) cinque elementi varato inizialmente negli anni Ottanta e che con formazioni sempre diverse ha accompagnato l’avventura di Coleman. Da allora moltissimi dei talenti del jazz degli ultimi trent’anni hanno militato più o meno stabilmente nei Five Elements, come la cantante Cassandra Wilson, l’eccezionale pianista Geri Allen, il trombonista Robin Eubanks, e il chitarrista David Gilmore, tra gli altri. Ed è proprio con i Five Elements che Steve Coleman ha inciso i suoi primi dischi Pi Recordings, vale a dire Harvesting Semblances and Affinities (PI33, 2010), The Mancy of Sound (PI38, 2011) e Functional Arrhythmias (PI47, 2013).
I primi due sono dischi pensati, almeno sulla carta, a partire da schemi e pattern ricorrenti osservati in natura, e influenzati dalla filosofia di Ramon Llull. All’ascolto, però, non traspare molto di più del “solito” suono tradizionalmente associato ai gruppi di Coleman: è musica fatta di fitti arrangiamenti e sovrapposizioni di ritmiche sud americane, africane, asiatiche, sempre dominata dall’esuberante voce di Jen Shyu (che ricopre il ruolo che negli anni Ottanta e Novanta era della Wilson). Dei due, il migliore è The Mancy of Sound, per via di un più riuscito lavoro sul ritmo e per un impiego più spregiudicato e creativo del contrappunto (in particolare tra le parti di tromba di Jonathan Finlayson e quelle del trombone di Tim Albright). Il vertice di questo approccio lo si trova nella Ifá Suite, una sorprendente composizione in quattro movimenti (ognuna intitolata a un elemento naturale differente) influenzata dalle credenze del popolo Yoruba, dove rivive l’eccitante esplorazione dei ritmi delle culture della diaspora africana già intrapresa in The Sign and the Seal. Functional Arrhythmias segna invece l’introduzione di due importanti novità nell’opera di Coleman. La prima è quella della composizione spontanea: Coleman, dopo aver raggiunto uno stato di semi-trance, raccoglie idee musicali da memorie, immagini e umori che vengono rese immediatamente in musica tramite improvvisazione estemporanee al sassofono, oppure tramite la voce, o ancora tramite il battito di mani e piedi. Il risultato di queste “sedute” viene quindi registrato, riarrangiato e riorchestrato grazie all’aggiunta di nuovi strati, anch’essi provenienti da sessioni di composizione spontanea. La seconda è invece data dalla ricerca della propria fonte di ispirazione nell’arrangiamento e nell’interazione delle varie parti (sia melodiche che ritmiche) dalla mimesi di un fenomeno fisico o biologico. In questo caso, come può apparire evidente dal titolo, l’ispirazione è data dal battito cardiaco e dal rapporto dei vari sistemi e apparati che permettono la vita all’essere umano: l’utilizzo di tempi ternari nelle linee di basso di Anthony Tidd, i poliritmi delle percussioni e l’approccio più subliminale e intimo, che esalta il delicato contrappunto tra le voci dei vari strumenti vanno quindi visti come i corrispettivi musicali della pulsazione del cuore e delle mansioni svolte in parallelo dalle diverse parti del corpo.

La produzione del nuovo millennio di Steve Coleman ha compiuto però un prodigioso salto di qualità con il bellissimo Synovial Joints (PI57, 2015), forse finora il lavoro Pi più celebrato di Coleman, suonato con i suoi Council of Balance. (Questi sono essenzialmente un ampliamento della formazione Five Elements con flauti, clarinetti, diversi ottoni, un trio d’archi, e un set di percussioni esotiche con conga, berimbau e bonghi, con cui Coleman ha indicato le sue formazioni più estese a partire da Genesis & The Opening of the Way nel 1998). Come il precedente Functional Arrhythmias, anche Synovial Joints si avvale della tecnica della composizione spontanea, mentre questa volta il modello di riferimento per l’interazione dei diversi strumenti va ricercato nelle articolazioni sinoviali che tengono insieme l’apparato muscolare e quello scheletrico, e soprattutto al modo in cui esse si piegano, si muovono e si torcono. (Il booklet fornisce delle indicazioni piuttosto precise su dove trovare tale ispirazione nella musica: per esempio l’interludio intorno a 2:51 della Part I rappresenta un’articolazione a sella, quello intorno a 8:06 della Part II rappresenta un’enartrosi, oppure ancora quello a 2:42 della Part III rappresenta un ginglimo laterale.) È invece del tutto inedito il principio della camouflage orchestration, cioè un tipo di orchestrazione ispirata dalle registrazioni sul campo fatte direttamente da Coleman stesso in Amazzonia e che si focalizza particolarmente sulla disposizione spaziale dei suoni, in modo da suggerire nell’ascoltatore la percezione di suoni in primo piano, in secondo piano, e sullo sfondo. (Un esempio particolare di questo approccio si trova nella sezione centrale di Tempest, dove il cambio di umore e di melodia delle linee del sassofono in primo piano, sempre sostenute e ribadite da archi e flauto, viene scandito dalle percussioni che sembrano provenire da una zona più lontana dalla luce dei riflettori.) La composizione spontanea e la camouflage orchestration insieme sembrerebbero condurre a un approccio quasi “esoterico” alla composizione e all’orchestrazione; i brani si realizzano però in uno stile peculiarissimo e frizzante, meno legato al classico jazz funk rispetto a Functional Arrhythmias e con contatti più decisi con i grandi capolavori M-base anni Novanta, oltre che con le musiche latine, africane, asiatiche, e finanche con la classica contemporanea. In virtù della disposizione spaziale dei suoni data dalla camouflage orchestration, la musica di Synovial Joints assume infatti una dimensione cameristica, quasi intimista, che permane anche quando la quantità di strumenti chiamati in causa non è assolutamente ridotta (cfr. Harmattan), mentre le percussioni accentuano il cerebralismo dell’impianto ritmico, sempre frammentato, complesso e sofisticatissimo – che, alla fine dei conti, è proprio il più grande contributo apportato da Steve Coleman allo sviluppo della musica jazz dagli anni Ottanta ad oggi. È forse proprio Synovial Joints l’album in cui, finalmente, Steve Coleman riesce a “suonare la montagna”.
Un approccio molto simile a quello di Synovial Joints lo si può ritrovare in Morphogenesis (PI69, 2017), questa volta attribuito all’inedita formazione Natal Eclipse, dove l’ispirazione non è più data dai legamenti e dalle giunture del corpo umano bensì dal movimento dei pugili durante gli incontri di boxe. Sotto molti punti di vista Morphogenesis prosegue nel solco di quanto sperimentato nel capolavoro precedente, anche se la strumentazione questa volta esalta la componente cameristica e il sapore contemporaneo introdotto su Synovial Joints. Alle percussioni viene concesso pochissimo spazio. Su quasi metà dei brani non sono pervenute (e tra questi figura Morphing, la traccia più lunga del disco per oltre quattordici minuti di durata), e quando sono presenti hanno un ruolo fortemente ridimensionato rispetto a ciò che ci si aspetta da un disco di Steve Coleman: su Roll Under and Angles si sente solo l’eco di alcuni gong in lontananza, qualche delicato tocco sui piatti di una batteria, e poco altro; in NOH (peraltro, insieme a Span, completamente improvvisata dal collettivo in studio in maniera più classicamente jazz) acquistano un ruolo più in primo piano solo per via di un ostinato schema sui tamburi; ancora, Shoulder Roll dapprima illude che la batteria debba acquisire una funzione più centrale nell’economia della musica, ma dopo pochi minuti questa si spegne lasciando spazio a un lungo assolo di contrabbasso senza mai più tornare in gioco. Ciò che viene tolto alle percussioni viene ridistribuito in favore delle parti di violino, clarinetto, pianoforte e voce. Jen Shyu torna al ruolo di assoluta protagonista come non accadeva da The Mancy of Sound, ma questa volta l’accompagnamento armonicamente più ardito di Rane Moore (clarinetto), Kristin Lee (violino), Greg Chudzik (contrabbasso) e Matt Mitchell (pianoforte) – i primi tre esecutori stabilmente legati al mondo accademico, mentre il quarto eccezionale pianista che si muove con disinvoltura tra jazz, musica contemporanea, e decine di altri generi – le permettono di mettere in mostra le sue eccezionali doti tecniche e interpretative in una maniera completamente inedita rispetto alle precedenti registrazioni con i Five Elements. La sua voce contrappunta e si confonde con il timbro del violino e del clarinetto, mentre il pianoforte e il contrabbasso accelerano e rallentano il tempo di esecuzione dettando il ritmo dei suoi vocalizzi: è una delle sue performance più brillanti da quando si esibisce con Steve Coleman. Per quanto non sia un lavoro egualmente innovativo, Morphogenesis mostra una inedita declinazione del suono introdotto su Synovial Joints e, per importanza, è secondo solo a questo lavoro tra tutti i dischi pubblicati finora da Coleman per la Pi Recordings.

L’AACM non ha smesso di essere un punto di riferimento chiave per l’estetica Pi dopo l’arrivo di Steve Coleman, ovviamente. Giusto quest’anno è uscito un doppio celebrativo dell’Art Ensemble of Chicago (We Are on the Edge: A 50th Anniversary Celebration, PI80), mentre Muhal Richard Abrams e soprattutto Henry Threadgill hanno continuato a pubblicare dischi per questa etichetta con una certa regolarità: il solo Threadgill è anzi responsabile di addirittura sei degli album pubblicati dalla Pi in questo decennio, di cui ben due l’anno scorso (Dirt… and More Dirt, PI73, e Double Up, Plays Double Up Plus, PI76), e visti i ritmi della Pi non è un risultato di poco conto. Proprio i lavori di Threadgill sono tra le uscite più apprezzate e accolte meglio da pubblico e critica in tutto il catalogo dell’etichetta, e tutto sommato a ragione: album come il doppio In for a Penny, In for a Pound (PI58, 2015), concepito come una collezione di pezzi per quintetto con uno o più solisti, e Old Locks and Irregular Verbs (PI64, 2016) sfoderano un felice aggiornamento del suo peculiare stile fatto di densi contrappunti strumentali, suggestive esplorazioni timbriche e una scrittura sofisticata a metà tra la composizione e l’improvvisazione che, come da tradizione AACM, riassumono quasi un secolo di musica jazz (dal blues e gli spiritual fino alle propaggini più avant-garde dei giorni nostri). E vista l’età avanzata di Threadgill e la quantità di grande musica già realizzata nel suo lungo passato come musicista, la qualità della musica offerta da questi due album è davvero ammirevole. Peraltro, In for a Penny, In for a Pound è stato insignito del premio Pulitzer nel 2016, mentre Old Locks and Irregular Verbs ha comunque ricevuto il titolo di “miglior disco del 2016” sia dalla NPR che dal Jazz Times Critics Poll, quindi se siete tra quelli che sentono il bisogno fisico di rimanere sempre sul pezzo un ascolto è quasi obbligatorio.
Anche diversi musicisti che già provenivano dalla sfera dell’influenza dell’AACM hanno continuato a lavorare con la Pi Recordings, come Steve Lehman (di cui parleremo meglio più avanti) o il chitarrista Liberty Ellman, già negli Zooid di Threadgill, che dopo nove anni dal suo secondo e ultimo lavoro Pi (Ophichus Butterfly, PI19, 2006) è tornato sulle scene con Radiate (PI60, 2015), un lavoro che offre un originale punto di vista sulla musica fusion del nuovo millennio grazie al suo stile eccentrico e angolare, figlio tanto dell’M-base quanto di Thelonious Monk. Altri, come Rudresh Mahanthappa e Vijay Iyer, sono invece passati in pianta stabile ad altre etichette come la ACT e l’ECM, nonostante abbiano comunque pubblicato con la Pi anche dopo l’entrata in scena di Coleman (rispettivamente Apex, PI35, 2010, e Holding It Down: The Veterans’ Dreams Project con Mike Ladd, PI49, 2013). Ma è comunque evidente che dopo l’arrivo del gigante new yorkese le sonorità tipicamente associate alle uscite Pi siano state trasfigurate, mentre diversi musicisti dei gruppi di Steve Coleman sono entrati a far parte stabilmente dell’etichetta cominciando a pubblicare dischi da leader.
Dei Five Elements, Jonathan Finlayson è il trombettista. Classe 1982, già a soli diciotto anni era riuscito nell’impresa di impressionare Steve Coleman durante un workshop alla Berkeley High School: da allora, fa parte stabilmente del suo gruppo, oltre che di una marea di altri complessi (come quelli di Mary Halvorson, di Steve Lehman, o di Henry Threadgill). Come ci si aspetta da un musicista cresciuto sotto l’influenza di Coleman, lo stile di Finlayson è ritmicamente intricato e armonicamente ardito, anche se più propenso all’elucubrazione logicamente coerente rispetto all’approccio più istintivo e “mistico” del proprio mentore. Non a caso, una dichiarata influenza di Finlayson è la sua passione per gli scacchi, a cui ha intitolato il moniker del proprio quintetto (i Sicilian Defense) e anche un brano del proprio debutto da leader, The Moment & the Message (PI48, 2013). La formazione piuttosto peculiare (la tromba è l’unico ottone del gruppo, mentre alla base ritmica classica pianoforte/basso/batteria si aggiunge la chitarra dell’eccellente Miles Okazaki) permette a Finlayson di concentrarsi con attenzione sugli arrangiamenti – ariosi e sfuggenti, eppure radicati nel linguaggio di derivazione post-bop –, che richiamano anche quelli di Henry Threadgill. La sua tromba ha uno stile swingante e tecnico, più vicino a Clifford Brown e Freddie Hubbard che non a trombettisti più avant-garde e post-moderni, con un tono cristallino e pulito che passa con naturalezza da fraseggi ritmicamente convoluti a linee più soffuse e distese. È lei la protagonista di The Moment & the Message: gli altri strumenti ne contrappuntano le linee con intelligenza, ora conferendo una base ritmica frammentata e sincopata ad esaltarne gli assoli più pirotecnici, ora pennellando soundscape astratti per fare da sfondo ai momenti più lirici del leader. Nonostante sia il primo album da leader, Finlayson appare già un compositore molto maturo e consapevole dei propri mezzi.
A quel promettente debutto ha fatto seguito Moving Still (PI67, 2016), ancora una volta ispirato agli scacchi (titoli come All of the Pieces, Flank and Center e Between Moves richiamano abbastanza evidentemente alcuni aspetti del gioco). Qui le composizioni di Finlayson si fanno ulteriormente astratte e cerebrali, anche per via del ricambio di musicisti nei Sicilian Defense (in particolare, il pianista David Virelles viene sostituito dal magnifico Matt Mitchell); ma nonostante le atmosfere così rarefatte e l’interazione così elastica tra tromba, chitarra e base ritmica, permane sempre quella componente swingante mutuata dal bop, anche quando i ritmi si fanno più intricati e i musicisti esplorano con più libertà le possibilità timbriche dei propri strumenti (cfr. Between Moves, in cui il bassista John Hébert sperimenta con l’archetto producendo dissonanze finora assenti nella musica di Finlayson).
E anche se non più chiamato Sicilan Defense, il gruppo allestito per 3 Times Round (PI77, 2018) è nient’altro che un’emanazione di quello che suonava su Moving Still due anni prima. Nello spirito, l’ultimo album di Jonathan Finlayson prosegue nel solco dei due lavori precedenti, ma vi sono ora due novità importanti che rendono 3 Times Round il lavoro più importante tra quelli a firma di Finlayson, perlomeno finora. Uno è, banalmente, il livello delle sue composizioni: Finlayson ha sempre avuto un certo gusto enigmatico ed elusivo, ma su brani come A Stone, a Pond, a Thought e The Moon Is New raggiunge nuovi vertici con una scrittura umbratile e fascinosa, in cui il contrabbasso di Hébert e il pianoforte di Mitchell fanno da padroni con intricate trame melodiche e armoniche dal sapore quasi impressionista. In secondo luogo, c’è l’estensione della front line a tre elementi: alla tromba di Finlayson si aggiungono ora il sax contralto di Steve Lehman e quello tenore di Brian Settles. La musica di Finlayson è sempre stata piuttosto sofisticata, ma la possibilità di duettare e intrecciare la voce del proprio strumento con altri due ottoni amplia notevolmente le possibilità timbriche e armoniche a sua disposizione. Il tono obliquo di Lehman e Settles fa da ottimo contraltare a quello più brillante e diretto della tromba di Finlayson; i loro assoli, fatti di frenetiche linee melodiche spezzate, giocano maggiormente con dissonanze e armonie angolari, trovando il proprio motore trainante nel contrappunto con le parti di Finlayson e di Mitchell piuttosto che in una sequenza di accordi prefissata. È un album che si colloca nella gloriosa tradizione in & out, continuamente a cavallo tra i groove del jazz mainstream contemporaneo e le armonie disorientanti dell’avant-jazz americano, e in questo genere uno dei migliori che il decennio abbia prodotto.
Jen Shyu è invece la vocalist che ha dominato la scena sui primi due lavori Pi di Steve Coleman. Americana, ma figlia di immigrati asiatici (di Taiwan e Timor più precisamente), la sua formazione è di matrice prettamente classica: ha studiato canto lirico alla Università di Stanford, ed è una notevole ballerina e soprattutto violinista – a soli tredici anni, suonava concerti per violino di Tchaikovsky con la Peoria Symphony Orchestra. Successivamente, una volta appassionatasi alla musica jazz, è venuta a contatto con le canzoni tradizionali taiwanesi che suo padre le proponeva come base per l’improvvisazione. È stata questa la scintilla che l’ha portata a interessarsi alle culture non occidentali, portandola a viaggiare verso Brasile, Vietnam e Taiwan per studiare sul campo la musica, le danze popolari, perfino la lingua di tradizioni popolari rimaste ai confini dell’impero. Se i dischi con Steve Coleman non mostrano pienamente i diversi riferimenti stilistici e geografici del suo canto, i lavori da leader che ha registrato con la Pi sono completamente votati alla creazione di un linguaggio panculturale (e nonostante l’influenza, tra le altre cose, del jazz, definirli album di “jazz vocale” è piuttosto fuorviante). Il primo album della Shyu edito dalla Pi, intitolato Synastry (PI39, 2011), è ancora piuttosto grezzo e soprattutto monocorde, nonostante la proposta comunque fortemente innovativa. Con l’accompagnamento dato dal solo contrabbasso di Mark Dresser (che comunque riesce ad estrarre dal suo strumento, suonato sia con l’archetto sia in pizzicato, una notevole varietà di timbri e ritmi, spaziando dal walking bass jazz a parti più vicine alla musica classica atonale), Synastry pone l’attenzione esclusivamente sul camaleontismo vocale della Shyu, che già qui palesa una quantità di influenze impressionante (da vocalist jazz sui generis come Patty Waters e Jeanne Lee, all’opera occidentale, al teatro cinese, alla musica popolare del sud-est asiatico e sud americano).
Il successivo Sounds and Cries of the World (PI61, 2015), concepito dopo quasi tre anni passati tra Java, Kalimantan, Bali e Sud Corea, riesce a trovare un compromesso tra la forma dei brani e l’esibizione vocale. Rispetto a Synastry, la strumentazione di cui si avvale la Shyu è molto più ampia: per quest’occasione istituisce un gruppo (chiamato Jade Tongue) con una tromba (Ambrose Akinmusire), una viola (Mat Maneri), un basso (Thomas Morgan) e una batteria (Dan Weiss), mentre lei stessa si destreggia tra pianoforte, yue qin cinese, gayageum coreano, gong e idiofoni vari. In questo modo la componente globalista della sua musica risulta più pronunciata ed efficace, soprattutto grazie alle esotiche frasi della viola di Maneri, dalle pronunciate suggestioni melodiche asiatiche, e al particolare gusto alla batteria di Weiss, i cui studi con maestri indiani della tabla gli permettono di conferire un adeguato supporto ritmico alla musica torrenziale e altamente non lineare di Sounds and Cries of the World. D’altro canto, la performance della Shyu si fa ulteriormente sorprendente. Come sottolinea lei stessa, il suo approccio alle altre culture non è quello di un etnomusicologo, bensì quello di un artista: nel suo canto, che si avvale di un’impressionante pluralità di linguaggi (su Sounds and Cries of the World si possono ascoltare almeno inglese, coreano, indonesiano e giavanese), non vi è mai un esplicito rimando a una precisa tradizione culturale. Piuttosto, la sua è una personale interpretazione dei canti femminili e rituali provenienti da diverse parti dell’Asia, in cui convivono simultaneamente elementi della musica folk dell’Hengchūn, del sindhenan giavanese, del shuochang cinese, e del pansori sud coreano. La mancanza di una precisa direzione dei brani è l’unico neo che ancora mina il successo dell’operazione della Shyu, che comunque con Sounds and Cries of the World ha già prodotto uno dei lavori più originali e particolari del jazz del nuovo millennio.

Song of Silver Geese (PI72, 2017) risolve anche queste ultime incertezze in fase di scrittura, ed è molto probabilmente il suo disco da leader migliore finora. Dedicato al poeta taiwanese Edward Cheng, morto di cancro nel 2015, e all’amico Sri Joko Raharjo “Cilik”, un giovane esponente del teatro d’ombre giavanese vittima di un incidente stradale insieme alla moglie e al figlio, questo lavoro è di fatto un dramma in nove movimenti (Doors) basato sulla morte di quest’ultimo. In Song of Silver Geese l’unica superstite della tragedia, la figlia Nala, viene visitata da tre spiriti che le portano messaggi di speranza nel momento del dolore. Con l’aggiunta di un quartetto d’archi (il Mivos Quartet), un flauto (Anna Webber), percussioni varie (Satoshi Takeishi), un vibrafono (Chris Dingman), e perfino di un ballerino per le esibizioni dal vivo (Satoshi Haga), il suono della Shyu si spinge con decisione verso la musica contemporanea asiatica, richiamando l’opera di Toshio Hosokawa e soprattutto di Toru Takemitsu. Le composizioni si dipanano tra momenti lirici che richiamano il Medio e l’Estremo Oriente (Door 4: Sinom Semarangan), sezioni più sfilacciate e astratte derivate dalla musica accademica, finanche momenti più ritmici con basso, batteria e vibrafono che tracciano sentieri di connessione con la tradizione post-bop (Door 6: World of Wehali e Door 8: World of Baridegi). Il flauto della Webber, in particolare, contribuisce molto alla varietà di umori di Song of Silver Geese, con il suo stile peculiare e tecnico che spazia tra la ricerca timbrica di Severino Gazzelloni allo swing obliquo di Eric Dolphy fino al misticismo contemplativo dei flautisti del teatro Noh (forse sporcato della lezione di Hozan Yamamoto). Come è facile immaginare, è però Jen Shyu la vera star di Song of the Silver Geese: sono la sua proteiforme prestazione vocale (che abbraccia canto jazz, opera lirica e teatro giapponese) e la sua performance strumentale (e in particolar modo al piano, dove il suo stile rivela più di un’influenza dei grandi pianisti jazz più vicini alla tradizione classica) a dettare la personalità e l’umore del lavoro,. L’immersione così profonda in canoni espressivi molto lontani da quelli occidentali rende enigmatica l’interpretazione della poetica di Song of the Silver Geese, che nonostante il tema di base tragico appare avvolto da un’emotività sui generis e fuori dal tempo: a conti fatti, si tratta di uno degli album più innovativi nell’ambito del jazz vocale degli ultimi anni.

Se si vuole cercare un’estetica unificante nella Pi Recordings di questo decennio non si deve guardare al genere di musica proposto, quanto all’approccio alla esecuzione e alla composizione. Seguendo i dettami dell’AACM, i musicisti della Pi sembrano infatti continuamente indagare, in maniera sempre nuova, una possibile via alternativa alla musica completamente scritta e a quella completamente improvvisata, risolvendo il dubbio adottando entrambe le strategie in totale libertà. Sull’importante ruolo giocato sulla progettazione e sulla riflessione intorno alla musica prima dell’atto performativo, Seth Rosner si è espresso piuttosto chiaramente (e forse con un filo di tono polemico) in una intervista su AllAboutJazz:
«Braxton has a term that the traditional jazz audience is looking for the “sweating brow,” the sweating musician, the person who’s up there, grinding it out, creating on the spot, and it’s incredible inspiration that’s coming to them, but that’s really not the case. There are people that we work with that spend a lot of time and put a lot of thought into creating something, and it’s not just this amazing feat that happens before your eyes. There’s really a lot of backstory and intellect, and work that goes into not just learning to play your instruments, but building these pieces and learning how to create music.»
Con una celebrazione così esplicita dell’elucubrazione intellettuale precedente all’esecuzione musicale in sé portata come manifesto dell’estetica della proposta della Pi, non sorprende quindi che una frequente critica alle uscite dell’etichetta sia quella di essere viziate da un gelido accademismo (a cui contribuisce anche il tipico suono dei dischi Pi – caratterizzati sempre da una produzione algida e impeccabile, spesso e volentieri più affine a quella che ci si aspetterebbe da registrazioni di musica classica contemporanea). Ciò non toglie che comunque nessuno degli artisti della Pi Recordings (nemmeno quelli che operano in un contesto solo lontanamente riconducibile alla musica jazz) rinneghi o guardi con sufficienza alla tradizione della musica jazz. Descrivendo la visione della Pi, Rudresh Mahanthappa ha anzi ricordato:
«I saw my work as being traditionally based while maintaining a progressive and modern vision. Pi thought so too. They see a clear line between the past and the potential future manifestations of jazz and improvised music as a global art form.»
L’estetica di confine della Pi si sublima proprio in questa prospettiva lungimirante per cui il futuro del jazz e della musica improvvisata passano anche dal recupero della tradizione – intesa in senso lato: non solo le radici della musica afro-americana che ha donato tantissima ispirazione agli sviluppi del jazz, ma anche alle tradizioni popolari e folkloristiche della cultura di provenienza dei vari musicisti. È forse proprio questo il più importante lascito all’estetica Pi dato da Steve Coleman – la stessa Jen Shyu di cui si parlava precedentemente rappresenta a pieno titolo un esempio paradigmatico di questo approccio alla creazione musicale. Tra i più importanti musicisti dell’etichetta che trovano linfa creativa immergendosi nel proprio retaggio culturale figurano il sassofonista iraniano-americano Hafez Modirzadeh e il trombettista iraqeno-americano Amir ElSaffar, interessati al recupero delle sonorità folkloristiche del Nord Africa e del Medio Oriente in un contesto jazz. (I due hanno anche collaborato su Radif Suite, PI32, 2010, un lavoro comprendente le due suite Radif-e Kayhan, a firma di Modirzadeh, e la Copper Suite, quest’ultima composta da ElSaffar; è un lavoro che riparte dai quartetti piano-less del free jazz e del post-bop anni Cinquanta e Sessanta, stile Ornette Coleman o il Sonny Rollins di East Broadway Run Down, ma con un più esplicito rimando alla armonia medio-orientale e alla microtonalità araba.)
Hafez Modirzadeh, dei due, è quello in attività da più tempo. Dopo aver conseguito un dottorato in etnomusicologia nel 1992, ha subito cominciato a esplorare come leader (il suo debutto, In Chromodal Discourse, risale al 1993) e come sideman (al fianco di musicisti come Charlie Persip e soprattutto Fred Ho, tra gli altri) l’idea di una musica che facesse convivere l’armonia persiana con il temperamento equabile, che lui stesso ha ribattezzato chromodality. Il progetto è assolutamente originale, tanto da risultare addirittura incompreso nella New York degli anni Novanta.
«I went to a popular jam session in lower Manhattan to try this concept in public. Before the end of my first chorus, the leader of the session pulled the horn out of my mouth and dragged me off the stage by my neck strap, yelling ‘You can’t just get up here and play like that!’.»
Hafez Modirzadeh
I suoi dischi da leader usciti per la Pi proseguono ed evolvono quell’idea primigenia. In passato Modirzadeh ha alterato il timbro del suo sassofono sperimentando con diteggiature e imboccature particolari, in modo da evadere dal sistema tonale occidentale; ma nonostante tutti gli sforzi, la frustrazione dovuta all’impressione di rimanere comunque legato al linguaggio tonale di Ornette Coleman l’aveva indotto quasi ad abbandonare la musica. Proprio un incontro con il leggendario sassofonista, e una collaborazione con lui nata nel 2007, ha rinforzato i suoi propositi di proseguire con i propri obiettivi artistici, e Post-Chromodal Out! (PI44, 2012), il suo debutto per Pi, si colloca così in continuità con quanto sperimentato in Radif Suite – tanto che anche questo non solo vede di nuovo la presenza di Amir ElSaffar, ma proprio come Radif Suite è suddiviso in due lunghe suite (Weft Facets, ad opera di Modizardeh, e Wolf and Warp, commissionata invece al collaboratore storico James Norton). Si tratta ancora una volta di un jazz altamente cerebrale che cerca di colmare la distanza tra il jazz astratto della scena underground di New York con la musica persiana: gli strumenti di cui si avvale il gruppo di Modirzadeh appartengono tutti alla tradizione jazz, ma l’uso di tecniche oblique di ogni tipo trasfigura sassofoni e trombe in flauti orientali, mentre il suono del contrabbasso suggerisce quello dell’oud. La novità principale risiede però nell’utilizzo di un pianoforte (suonato dal grandissimo Vijay Iyer) accordato in una maniera completamente innovativa secondo un sistema pensato dallo stesso Modirzadeh ottenuto utilizzando intervalli di tre quarti di tono (provenienti dalla musica persiana) alternati a intervalli classicamente associati al temperamento equabile occidentale. In Post-Chromodal Out!, quindi, non è tanto l’introduzione di strumenti locali in un contesto jazz a realizzare un ponte tra due culture diverse (anche se in qualche traccia si possono udire un kulintang e un santur suonati da alcuni ospiti), quanto piuttosto la sovrapposizione di due sistemi armonici differenti suonati durante la stessa improvvisazione. La dissonanza cognitiva che il pianoforte così accordato produce affiancato a strumenti tradizionali è tale da indurre l’orecchio a percepire una sfumatura aliena nella musica anche quando il sassofono di Modirzadeh e la tromba di ElSaffar descrivono assoli non troppo lontani da quelli della coppia Ornette Coleman/Don Cherry. Quella di Post-Chromodal Out! è una delle vie al jazz etnico più eccitanti e innovative che si siano potute ascoltare negli ultimi anni: è un’operazione che ha quasi più a che vedere con le lunghe composizioni per pianoforte microtonale influenzate dalla musica indiana di LaMonte Young e Terry Riley che non con altri esempi di jazz contaminato dalla cultura mediorientale e asiatica, e che finora non ha trovato nessun artista a raccoglierne la ricca eredità.
L’ultimo album di Hafez Modirzadeh, intitolato In Convergence Liberation (PI55, 2014), per quanto non egualmente riuscito prosegue però con pure maggiore caparbietà in questa immersione nella musica persiana. Messo da parte il pianoforte microtonale di Post-Chromodal Out!, Modirzadeh si avvale ora di un quartetto d’archi e di due strumentisti specializzati in musica classica persiana e iraniana (Faraz Minooei al santur e Amir Abbas Etemadzadeh al daff e al tombak), e con questa nuova formazione si pone l’ambizioso obiettivo di celebrare l’eredità culturale andalusa e persiana attraverso lunghi cicli di canzoni (le voci sono di Mili Bermejo, cantante di provenienza latina, e quella di Amir ElSaffar, che suona anche la tromba e un santur iraqeno) basati su poesie e testi persiani, messicani e spagnoli. (Il riferimento alla cultura andalusa, che a prima vista può apparire bizzarro nell’ottica dello studio della musica araba di Modirzadeh, è dovuto al dominio arabo imposto alla penisola iberica tra l’VIII e il XV secolo.) La musica di In Convergence Liberation è un esotico jazz da camera, che si avvale principalmente delle tecniche del maqam iraqeno e della musica classica araba, oltre che di scale e armonie della musica persiana e iberica; non mancano però i riferimenti post-moderni alla tradizione classica occidentale, con motivi e temi estrapolati dalle opere di Beethoven, Mozart o Bartók.

Amir ElSaffar è più giovane di Modirzadeh, ma dei due è lui quello che ha cominciato a pubblicare per primo sotto l’egida della Pi. Il suo percorso è simile a quello di altri musicisti dell’etichetta (formazione accademica con laurea in tromba classica presso la DePaul University, partecipazioni e collaborazioni con artisti affermati come Daniel Baremboim, Cecil Taylor, Fred Ho, Rudresh Mahanthappa, Vijay Iyer), se non fosse per lo studio del maqam intrapreso direttamente a Baghdad, dove ha anche imparato a suonare il santur. Nei suoi dischi per la Pi – con la quale ha pubblicato il suo primo lavoro da leader nel 2007, con l’acclamato Two Rivers – ElSaffar ha esplorato diverse tecniche oblique da applicare alla tromba in modo da produrre microtoni tipici della musica araba (diteggiature non convenzionali, glissandi, modulazioni particolari del timbro dello strumento), implementando così le armonie della tradizione iraqena nella musica jazz. (Two Rivers, che dà il nome anche al sestetto che si esibisce sull’album, è infatti un riferimento ai fiumi Tigri ed Eufrate che bagnano l’Iraq, e al contempo una metafora per intendere il sangue che scorre nelle vene di ElSaffar – iraqeno da parte di padre, e americano da parte di madre.)
Inana (PI41, 2011), registrato nuovamente con l’ensemble Two Rivers, lo ha confermato ancora una volta come una delle voci più innovative del jazz arabo dai tempi dei lavori di Rabih Abou-Khalil. Si tratta di una suite ispirata alla figura mitologica e alle vicende di Inanna, dea sumera dell’amore carnale e della guerra dal carattere capriccioso e volatile. La musica che ne descrive la gesta è, di conseguenza, mutevole e imprevedibile, con un’eccellente integrazione dell’improvvisazione modale mutuata dal maqam in eleganti strutture che provengono direttamente dal jazz d’avanguardia di New York, ma che non perdono il profondo feeling swingante della grande tradizione afro-americana. L’utilizzo di strumenti cordofoni della cultura araba come l’oud, il santur e il buzuq, le percussioni che affiancano la batteria, l’armonia modale basata su microtoni adoperata dal sassofonista Ole Mathisen (che sostituisce il dimissionario Rudresh Mahanthappa) e dallo stesso Amir ElSaffar, perfino il suo stile di canto (per esempio sulla bellissima Journey to the Underworld) conferiscono alla musica una dimensione molto più profonda rispetto al facile esotismo in cui è facile cadere in operazioni del genere: Inana suona misteriosa, affascinante e sinceramente multiculturale.

I successivi album per la Pi hanno continuato a esplorare le possibili connessioni tra il jazz e la musica iraqena e mediorientale, anche se ogni disco ha introdotto qualche piccola novità in una formula in continua evoluzione. Alchemy (PI51, 2013), composto dopo che ElSaffar ha vissuto per due anni in Medio Oriente, non è nemmeno un lavoro attribuito al Two Rivers Ensemble: è piuttosto uno studio su come adattare l’innovativo suono di ElSaffar in un contesto più classicamente jazz. La formazione che suona su Alchemy è in effetti quella di un quintetto neo-bop con musicisti di eccezione (il solito Ole Mathisen, François Moutin al contrabbasso, Dan Weiss alla batteria, John Escreet al pianoforte), con nessuna concessione a strumenti provenienti dalla tradizione araba e nessuna performance vocale del leader. Anche il pianoforte, al contrario di quanto accadeva in Post-Chromodal Out! di Modizardeh, è accordato secondo il temperamento equabile. Proprio per questo, la musica di Alchemy rimanda alle prime incursioni del jazz in Asia e nel mondo della microtonalità, ai primi esperimenti di Thelonious Monk che suggeriva i quarti di tono con le blue note, alle suite ambientate nel lontano Est di Duke Ellington, ai dischi di Yusef Lateef e a quelli di Ahmed Abdul-Malik. È musica che riparte dal bop dandogli però un taglio obliquo per via delle tecniche estese implementate dalla front line dei fiati e per via dell’importante utilizzo di antichi modi orientali (in questo disco, in particolare, quelli sumeri e babilonesi) come base dell’improvvisazione. E in una situazione tanto più tradizionale i toni di ElSaffar e Mathisen suonano particolarmente esotici, finendo per influenzare anche la percezione del timbro degli altri strumenti che pur rimangono stabilmente in un contesto armonico occidentale (cfr. Embubum / Ishtarum / Pitum e 12 Cycles).
Crisis (PI59, 2015) è per ora l’ultimo lavoro Pi di ElSaffar. (L’ultimo Not Two, disco per orchestra di diciassette elementi che prosegue sulla stessa scia concettuale degli album precedenti, è stato pubblicato dalla New Amsterdam nel 2017.) Suite concepita nel 2013 a cavallo tra Egitto e Libano, Crisis ritorna alla stesso sestetto che aveva suonato su Inana, e quindi alle forme meno classicamente americane e più contaminate dal maqam che avevano caratterizzato Two Rivers e lo stesso Inana, ma è un disco profondamente diverso da questi nello spirito. La sua stesura è avvenuta simultaneamente al precipitare della situazione nel Medio Oriente, dove i disordini, le ribellioni e le crisi scoppiate durante gli eventi dell’inverno arabo hanno minato profondamente la stabilità geopolitica dell’Egitto, dell’Iraq e dello Yemen, culminando nella sanguinosa guerra civile che ha devastato l’Iraq tra il 2014 e il 2017 e in quella più tristemente celebre che dal 2011 continua a mettere in ginocchio la Siria, influenzando profondamente di riflesso anche la vita e la politica dell’Occidente.
«Crisis was more about the contemporary situation of not only Iraq but the Middle East in general and even what we’re seeing happening in Europe, economically—I feel like we’re in uncharted territory and we’re facing the result of hundreds and hundreds of years of oppression, and colonialism, and imperialism, and slavery.»
Amir ElSaffar
Per questo, nella musica di Crisis decade quella componente più astratta che aveva segnato Inana e Alchemy in favore di un’urgenza espressiva più materialista, finora inedita nell’opera di ElSaffar. Brani come The Great Dictator, con il suo nervoso intrecciarsi delle linee della tromba e del sassofono e con l’incalzare della ritmica scandita anche da oud e buzuq, o El-Sha’ab (The People), con la sua lunga e meditabonda introduzione affidata al contrabbasso di Carlo DeRosa e agli strumenti tradizionali mediorientali, sfoggiano un’intensità che non si era mai sentita nei dischi precedenti, e suggeriscono un profondo turbamento: la rocciosità della base ritmica e l’instabilità melodica dei fraseggi della front line sono da imputare all’inquietudine di tempi turbolenti per la comunità araba nella sua interezza. La lunga (tredici minuti) Tipping Point è il momento più avant-garde ed esplosivo di tutta la suite, e con i suoi riferimenti melodici a The Great Dictator e un titolo sinistramente eloquente sembra riferirsi apertamente alle rivolte che hanno segnato la primavera araba, nel contempo annunciando nuove insurrezioni per rovesciare i nuovi equilibri autoritari affermatisi nel Vicino Oriente. Senza dubbio, Crisis non è l’album più innovativo di Amir ElSaffar. Ma, altrettanto certamente, è quello dalla poetica più singolare e dalla forza più sconvolgente; una cupa testimonianza in prima persona di una tragedia che ancora non accenna a esaurirsi, e pertanto uno dei lavori più attuali e imprescindibili dell’intero catalogo Pi Recordings.

Seppur da una prospettiva sensibilmente meno drammatica, il pianista cubano David Virelles con il suo ultimo album in studio Igbó Alákọrin (The Singer’s Grove) Vol. I and II (Pi78, 2018) ha comunque registrato uno dei capitoli più emblematici e riusciti di questo processo di recupero delle proprie radici culturali e musicali attuato da diversi musicisti Pi.
Pianista di formazione accademica, negli anni scorsi ha riscosso un discreto successo critico con i suoi lavori Continuum (PI46, 2012) e soprattutto Mboko (ECM, 2014), grazie a uno stile che recuperava le proprie radici cubane in un contesto jazz ma astraendole e sfilacciandole in un suono privo di riferimenti spazio-temporali ben precisi, producendo così una sorta di algido jazz latino da camera eccessivamente occidentalizzato (soprattutto per quanto concerne Mboko, che come è sempre più comune in casa ECM soffre dell’estetica narcotizzante imposta da Manfred Eicher).
L’operazione compiuta in Igbó Alákọrin, invece, è molto più coraggiosa: forse influenzato anche dai riconoscimenti tributati a giganti del nuovo jazz latino come Arturo O’Farrill in America, Virelles ha deciso di non celare il suo retaggio culturale cubano, e anzi di approfondire il legame tra il suo linguaggio musicale e quello della tradizione cubana (in particolare quello delle grandi orchestre anni Trenta di Chepin e di Mariano Mercerón, nel primo volume, e delle danzones di Antonio María Romeu risalenti all’inizio del Novecento, nel secondo). Lo stesso titolo Igbó Alákọrin (che tradotto in inglese vuol dire proprio Singer’s Grove) è mutuato dalla lingua degli Yoruba, la civiltà africana che ricopre un ruolo piuttosto importante nella storia culturale di Cuba e dell’America latina: è dalla loro religione animista, trasfigurata dal contatto con il culto cristiano dei santi e portata nelle Americhe con la tratta degli schiavi, che discende l’attuale santería praticata a Cuba e dintorni.
Quella di Igbó Alákọrin è musica vitale e creativa che con il suo profondo impianto ritmico percussivo, la strumentazione tradizionale cubana, e un’esecuzione filologicamente accurata di generi come bolero e trova, suona come un sincero omaggio alle radici della musica cubana del Novecento. D’altra parte lo stile di Virelles al pianoforte è moderno e armonicamente ardito, consapevole degli sviluppi del pianoforte jazz degli ultimi decenni: da questo scontro tra tradizione e sguardo al futuro emerge uno dei lavori di jazz latino più affascinanti degli ultimi anni.
Anche il batterista Dan Weiss, adottando un punto di vista ancora differente da quelli di Jen Shyu, Hafez Modizardeh, Amir ElSaffar e David Virelles, si muove nel solco del poliglottismo e dell’incontro di culture lontane (sia geograficamente che stilisticamente). Nonostante ora si sia fatto un nome suonando la batteria in contesti jazz più o meno tradizionali, Dan Weiss ha studiato per vent’anni le tabla con Pandit Samir Chatterjee, registrando anche alcuni dischi in cui riadattava repertorio originale indiano per tabla alla batteria occidentale: non a caso, le sue prime registrazioni Pi (che risalgono al 2006) lo vedono suonare con ben due musicisti di origine indiana, ovvero Rudresh Mahanthappa e Vijay Iyer (Codebook, PI21, 2006). Nei suoi dischi da leader editi dalla Pi, però, Weiss riversa molto altro oltre alla musica jazz e alla musica hindustani. Weiss è infatti un musicista dai gusti eterogenei, appassionato non solo di John Coltrane e di Nikhil Banerjee, ma anche di progressive rock (Rush, Yes, King Crimson), musica classica (da Bach a Morton Feldman passando per Beethoven, Mahler e Stravinskij) e musica metal (Meshuggah, Metallica).
Il suo debutto da leader per la Pi Fourteen (PI52, 2014), concepito per un ensemble di quattordici elementi (da cui il titolo) comprendente, oltre a diversi ottoni e alla classica base ritmica jazz, anche una chitarra elettrica, un’arpa, un glockenspiel, un organo (secondo il press kit della Pi, lo stesso su cui gli Iron Butterfly registrarono In-a-Gadda-da-Vida) e tre voci femminili, è il primo di una serie di lavori che rivela questo stuolo variegato di influenze. Dipanandosi in sette movimenti di durata variabile, Fourteen si gioca perlopiù sulla progressiva sovrapposizione di tracce musicali e sul contrappunto tra le diverse parti strumentali. Il paradigma è dato dall’eccellente traccia d’apertura, in cui il tema di poche battute del pianoforte viene progressivamente ribadito e arricchito dall’intervento degli altri strumenti (prima basso e batteria, poi chitarra acustica, poi le voci, infine i fiati). È musica corale, dove è data la precedenza all’impatto totale dell’ensemble piuttosto che all’improvvisazione e agli assoli dei singoli – che pure sono presenti, a partire dall’assolo di chitarra elettrica di Miles Okazaki sul finale del primo movimento, fino all’estrosa dimostrazione della tecnica del konnakol di Weiss stesso nella terza sezione, mutuandola dalla musica carnatica. Attraverso tutta Fourteen, se si esclude lo spettro della eclettica musica per big band di Carla Bley che pervade tutta la composizione, si percepiscono riferimenti più prossimi alla tradizione progressive rock che a quella jazz, come i King Crimson più duri di metà anni Settanta (quarto movimento), le atmosfere della scena di Canterbury più bucolica (secondo e quinto movimento), il Rock in Opposition (più o meno tutto l’album). Ma a un ascolto più attento si riescono a udire anche riferimenti più sottili, come gli ostinati percussivi del minimalismo di Steve Reich, il misticismo estatico della musica hindustani, i poliritmi dei Meshuggah: è davvero una musica totale e senza barriere. Il successivo Sixteen: Drummers Suite (PI63, 2016), pur partendo dall’interessante premessa di ricamare una composizione attorno alle parti di batteria di alcuni dei batteristi jazz più apprezzati da Weiss (Ed Blackwell, Elvin Jones, Tony Williams, Kenny Clarke, Max Roach, Philly Joe Jones) sembra segnare un passo indietro rispetto a Fourteen. L’organico è più ampio e lo stile è di base simile, ma rispetto all’eccellente predecessore Sixteen: Drummers Suite opta per un impianto meno corale, soffermando l’occhio di bue invece sulla batteria (ovviamente) e soprattutto sulle voci, il cui utilizzo eccessivo rappresenta il punto debole sostanziale del lavoro.

È piuttosto molto più interessante il recente Starebaby (PI74, 2018) che svela apertamente un lato dell’estetica di Weiss rimasto fino a quel momento in secondo piano: Starebaby è infatti una dichiarazione d’amore per la musica metal e per Twin Peaks. Non che questo aspetto fosse davvero inedito – già in Fourteen (e nei vari dischi su cui aveva suonato prima di Starebaby) risaltava il peculiare stile alla batteria di Weiss, in cui coesistevano non solo le influenze più prevedibili per un batterista jazz dai gusti verso il prog (e quindi Max Roach, Tony Williams, Neil Peart, Bill Bruford) e la sempre pervasiva presenza dei grandi suonatori di tabla indiani, ma anche una certa irruenza mutuata dai batteristi di metal estremo dal groove più accentuato – Tomas Haake dei Meshuggah su tutti, ma anche Steve MacDonald dei Gorguts e Gene Hoglan –. (Non a caso, Dan Weiss ha anche suonato per anni con i Bloody Panda, band doom metal che ha registrato per la Profound Lore e che ha inciso anche uno split con i Kayo Dot di Toby Driver.) Composto per quintetto con doppia tastiera, chitarra, basso e batteria, Starebaby è un album oscuro e surreale, dominato dalle atmosfere astratte ricamate dalle tastiere e dall’elettronica di Craig Taborn e Matt Mitchell e dalla chitarra di Ben Monder (noto per il suo recente lavoro su Blackstar di David Bowie, ma che qui indulge liberamente in uno stile dissonante e distorto che richiama alternativamente Robert Fripp, Piggy e Fredrik Thordendal). I tempi adottati sono perlopiù lenti, scanditi dal basso di Trevor Dunn (che in passato ha prestato servizio non solo per John Zorn, ma anche per i Mr. Bungle e i Fantômas di Mike Patton) e dalla poderosa batteria di Dan Weiss, che passa liberamente da parti più dinamiche e jazzy a mid-tempo più cadenzati che sottolineano il legame con la musica di Confessor e Burning Witch. La produzione non sempre si mostra all’altezza del suono della band, soprattutto quando i volumi si alzano e la performance si fa più pesante (forse anche per inesperienza da parte della Pi nel gestire certe sonorità), ma Starebaby offre comunque un campionario di soluzioni davvero suggestivo. Si passa dal metal di Depredation, alle atmosfere da incubo di Annica, alla personale reinterpretazione della musica per guitar hero su Cry Box, fino al più esplicito tributo alla colonna sonora di Twin Peaks su Badalamenti. Il meglio va cercato però nei due brani più lunghi, cioè The Memory of My Memory ed Episode 8, che riassumono tutte le anime del progetto Starebaby tra desolate distese elettroacustiche rubate a Bernard Parmegiani, dark jazz notturni venati della poetica di Angelo Badalamenti, fragorose parentesi sludge deturpate da folate elettroniche, sfuriate di math metal angolare degne, alternativamente, degli Shining norvegesi o degli Human Remains. È, senza dubbio, uno dei dischi più particolari e unici dell’intero catalogo Pi; ma è anche interessante perché dimostra un apprezzamento di musiche estreme come death metal e doom metal che in certi ambienti della scena jazz americana sta prendendo sempre più piede, influenzandone notevolmente la ricerca timbrica e l’estetica (peraltro, smentendo un luogo comune ancora ben radicato in certa critica nostrana e non che vuole il metal come musica puramente adolescenziale ascoltata solo da gente completamente inconsapevole di altri generi oltre a questo).
L’analisi dell’opera di Dan Weiss conduce quindi all’altra tendenza maggioritaria nella produzione Pi degli anni Dieci: all’incontro tra jazz e culture popolari non occidentali messo a punto da molti artisti dell’etichetta, si affianca un processo di contaminazione del jazz con virtualmente qualsiasi altro genere musicale partorito in Occidente nel secolo scorso (classica contemporanea, rock, metal, hip hop, elettronica). Anche in questo caso, non si tratta di un trend lanciato dall’ingresso di Steve Coleman (si pensi anche solo al già citato In What Language?), ma è innegabile che il suo arrivo abbia dato una spinta propulsiva notevole a questi esperimenti di crossover, e il volume di registrazioni votate al melting pot selvaggio di stili in questo decennio è aumentato sensibilmente, sia per la temerarietà della fusione di generi, sia per il mero numero di album prodotti.
Steve Lehman è forse uno dei casi più emblematici di questo melting pot stilistico. I suoi primi dischi da leader risalgono ai primi anni 2000 (di questi, si ricorda almeno Structural Fire, uscito per la CIMP) e solo nel 2005 è approdato alla Pi Recordings, di cui è stato uno dei primi giovani talenti, debuttando con Demian as Posthuman (PI17, 2005). Ai tempi aveva appena conseguito il Master in composizione presso la Wesleyan University, dove aveva avuto modo di studiare con alcuni dei pesi massimi AACM (Anthony Braxton, ma anche Jay Hoggard) e pure con Alvin Lucier, nel frattempo lavorando anche con Jackie McLean. I primi lavori di Lehman sono quindi esattamente in linea con quanto ci si aspetterebbe da insegnanti di questo calibro: il suo è un jazz altamente strutturato e ritmicamente convoluto, fatto di fraseggi nervosi e frammentati, supportato da una buona dose di musica elettroacustica e venato del respiro metropolitano dell’M-base di Steve Coleman. A partire dal suo primo lavoro per ottetto, Travail, Transformation and Flow (PI30, 2009), il suo stile di scrittura ha cominciato a evolversi in una direzione (ulteriormente) astratta e sperimentale. Non solo per i più espliciti richiami all’hip hop (su questo disco c’è pure una cover di Living in the World Today di GZA), ma anche per un approccio “spettralista” alla composizione: Steve Lehman aveva infatti conosciuto all’università Gérard Grisey e Tristan Murail, e con quest’ultimo ha studiato presso la Columbia University a partire dal 2006 (dove, nel 2012, ha pure conseguito il dottorato in composizione). Dopo la fugace digressione di matrice più ovviamente post-bop data dal suo lavoro per trio Dialect Fluorescent (PI42, 2012), il successivo Mise en Abîme (PI54, 2014), registrato con lo stesso ottetto che aveva inciso Travail, Transformation and Flow, ha amplificato l’influenza spettralista. A differenza di altri lavori improvvisativi basati su tecniche microtonali o spettrali, le improvvisazioni del gruppo di Steve Lehman non utilizzano una scala fissata, impiegando invece gli spettri armonici come base per la costruzione delle successioni di accordi – che in tal modo possono modulare con facilità verso un centro tonale sempre nuovo durante la performance. Il dinamismo armonico che viene raggiunto in questo modo suona straniante, perché l’equilibrio sonoro dell’ottetto appare instabile e sempre sull’orlo di disgregarsi (il finale di 13 Colors ne è un esempio paradigmatico).
Per espandere ulteriormente le possibilità armoniche della sua musica, Steve Lehman si è anche fatto costruire ad hoc un vibrafono con accordatura microtonale presso il centro di ricerca parigino dell’IRCAM, dove ha studiato elettronica interattiva a partire dal 2014. È proprio questo lo strumento impiegato su Mise en Abîme: l’accordatura personalizzata del vibrafono (suonato, sul disco, da Chris Dingman) ne compromette il timbro rendendolo alieno e surreale, quasi come se fosse continuamente manipolato dall’elettronica (cfr. Segregated and Sequential oppure Chimera / Luchini, dove duettando con elettronica e drum machine si confonde nel tessuto elettroacustico). La musica dell’ottetto, di base, trarrebbe ispirazione da quella di Jackie McLean, da quella anni Novanta/Duemila di Anthony Braxton e da quella di Steve Coleman (quest’ultima, però, privata del sapore etnico e “world”); ma le trame esotiche del vibrafono, insieme alla live electronics di Steve Lehman che ora distorce il tono degli strumenti, ora produce sibili elettroacustici che si trasformano nevroticamente per adattarsi agli sviluppi armonici e ritmici dei brani (vedasi Beyond All Limits), le conferisce un carattere astratto e futuristico. E oltre che un esercizio intellettuale nell’implementazione dello spettralismo in un contesto avant-jazz, Mise en Abîme è anche l’accorata celebrazione di un mentore di Jackie McLean, vale a dire il leggendario pianista Bud Powell, con cui Lehman sente di avere diverse caratteristiche concettuali in comune.
«Jackie McLean was one of my most significant mentors, and Bud was one of Jackie’s mentors. And like me, Bud was someone who grew up in New York, spent a lot of time in France, and felt a connection to the French classical tradition. For him it was Frederic Chopin. For me it’s Tristan Murail and Gerard Grisey. It’s a thread of continuity that I felt was important to explore.»
Steve Lehman
Per tributare tale omaggio in maniera più esplicita, Lehman sceglie tre brani di Powell come framework di partenza per altrettante composizioni di Mise en Abîme. Glass Enclosure, qui rinominata Glass Enclosure Transcription, diventa un quasi irriconoscibile brano di post-bop spettralista, dominato dalle armonie microtonali del vibrafono e dagli assoli dei fiati e scandito dal bofonchiare della tuba in sottofondo; l’apertura di Autumn Interlude sembra provenire direttamente dall’avanguardia francese, ma ad ascoltare con maggiore attenzione le parti del vibrafono si sentirà la citazione esplicita al tema del pianoforte di Autumn in New York. Infine, su Parisian Thoroughfare Transcription, il pianoforte di Bud Powell viene direttamente campionato, mentre sopra di esso il sassofono di Lehman elucubra in solitaria.

Finora, però, è probabilmente Sélébéyone (PI66, 2016) l’album in cui Steve Lehman ha portato a termine l’operazione più coraggiosa e visionaria. Su questo disco, Lehman ha colto l’occasione per manifestare la sua passione per l’hip hop e l’influenza di questo sulla sua musica, aggiungendo al suo quintetto (un’estensione del trio di Dialect Fluorescent con un pianista e un altro sassofonista, il suo studente Maciek Lasserre) i rapper High Priest, nume tutelare dell’hip hop sperimentale degli anni Duemila con gli Antipop Consortium (che già nel 2003 avevano flirtato con il jazz nell’album Antipop vs. Matthew Shipp) e Gaston Bandimic, rapper emergente della scena senegalese (che qui infatti canta nella sua lingua natìa, il wolof), presentatogli direttamente da Lasserre. Il compito di missare l’album è quindi affidato ad Andrew Wright, che aveva lavorato anche su good kid, m.a.a.d. city di Kendrick Lamar. La musica registrata per Sélébéyone è a tutti gli effetti avant-jazz della stessa matrice di Mise en Abîme, vale a dire con importanti ingerenze elettroacustiche, un uso visionario dell’armonia microtonale e spettralista nell’improvvisazione, e intrecci poliritmici complessi mutuati dall’M-base. Le prestazioni tecniche individuali sono, ovviamente, eccellenti, e in linea con quanto mostrato dai gruppi di Lehman nei suoi dischi strumentali. Questa volta si distingue in particolar modo il batterista Damion Reid che, destreggiandosi tra batteria elettronica e acustica, porta a pieno compimento le sue innovative idee sullo strumento introdotte a partire già dal 2007, quando aveva partecipato alla registrazione di In My Element di Robert Glasper. Dotato di un’impressionante tecnica a mani aperte, che indulge in fitte reti di passaggi velocissimi e intricati poliritmi, è spesso lui a guidare l’andamento ritmico dei brani, sia dettando il tempo delle improvvisazioni di Lehman, sia scandendo la metrica dei versi dei due rapper: il suo ruolo nell’economia dell’album è davvero al crocevia tra classico batterista jazz e beat-maker hip hop, sotto l’influenza simultanea di Billy Higgins e J Dilla. Sélébéyone, però, non è solo un disco di jazz rap particolarmente brillante: è un disco senza mezzi termini straordinario, e tra i più innovativi nella storia del genere. Certo non è la prima volta che un disco hip hop si avvale di un gruppo acustico per la realizzazione delle basi, ma la vera novità di Sélébéyone va ricercata nella sinergia tra la componente verbale e quella strumentale della musica. Durante l’improvvisazione, il quintetto non è ignaro delle parole di High Priest e Bandimic, di cui comunque evidenzia i versi cardine rispondendo intelligentemente con opportuni cambi di tonalità, accordi e ritmo; ciononostante, il rapporto tra mc e beat viene completamente stravolto, perché non sono più le basi che vengono manipolate e riadattate in modo da incastrarsi nel classico 4/4 su cui rappare, bensì sono i rapper che ora devono seguire una musica tanto spigolosa e astratta, adeguando opportunamente il proprio flow. In più, quella di Sélébéyone è davvero musica globalista e inclusiva, dove gli interpreti di provenienze disparate si incontrano e costruiscono insieme la loro opera lavorando a partire dai punti in comune gli uni con gli altri (come la fede sufista, o la conoscenza della lingua francese). Il prodotto finale è un disco multietnico conteso tra il Senegal della lingua wolof, la New York del jazz M-base, la Francia della musica spettralista, tra musica bianca e musica nera: esattamente l’album che ci si aspetterebbe da uno studente di Anthony Braxton e Tristan Murail appassionato però anche di A Tribe Called Quest e Harry Partch. Lo stesso titolo Sélébéyone altro non è che la traduzione diretta in wolof della parola “intersezione”: in un mondo come quello attuale, in cui l’inclusione di altre culture e l’accettazione del diverso sono problematiche ancora aperte per una fetta troppo vasta della popolazione, quello di Sélébéyone è un atto radicale non solo dal punto di vista musicale ma anche da quello politico. E, pertanto, va annoverato a pieno titolo tra i lavori fondamentali di questo decennio.

Un’altra delle voci più innovative provenienti dal vivaio della Pi Recordings appartiene di nuovo a un batterista, seppure quest’ultimo si muova in un contesto radicalmente differente da quello di Dan Weiss – e, se per questo, da quello di qualsiasi altro musicista attualmente in attività. Tyshawn Sorey, come specifica esplicitamente il sito della Pi stessa, è il batterista che ha inciso più album per l’etichetta (ha suonato su dischi di Vijay Iyer, Steve Lehman, e Steve Coleman) ed è per questo il primo batterista cui è stato offerto di pubblicare un proprio lavoro da leader sotto di questa – anche se, prima di approdare alla Pi, aveva già registrato due album per Firehouse 12 (That / Not, 2007) e per 482 Music (Koan, 2009). Anche Sorey vanta un curriculum squisitamente accademico, con un bachelor in studi e performance jazz conseguito nel 2004, e un master in composizione presso la Wesleyan University conseguito nel 2011, sotto la supervisione di (tra gli altri) Anthony Braxton, Jay Hoggard e Alvin Lucier. Oggi Sorey insegna alla Wesleyan University, dopo aver terminato il suo dottorato in composizione alla Columbia University nel 2017, ed è un session man ricercatissimo, richiesto tanto da leggende istituzionalizzate dell’avant-jazz (tra i musicisti che si sono avvalsi del suo talento si ricordano almeno Roscoe Mitchell, Anthony Braxton, John Zorn, soprattutto Butch Morris – forse la personalità musicale più affine alla sua) quanto da importanti musicisti del nuovo millennio (David Binney, Ingrid Laubrock, Matt Mitchell, John Escreet). Il suo debutto per la Pi è avvenuto con Oblique – I (PI40, 2011), realizzato per un più o meno tradizionale quintetto composto di sax contralto, chitarra, pianoforte, basso e batteria. La musica di quest’album, per quanto ottima, è ancora radicata in un jazz di derivazione post-free, con l’evidente influenza degli artisti AACM; si percepisce in particolare l’influsso del quartetto anni Novanta di Anthony Braxton, e infatti le composizioni in questo disco sono intitolate, secondo la più classica tradizione braxtoniana, semplicemente con il loro numero di serie. (Secondo il press-kit dell’album, è stata proprio una conversazione con Braxton a portare Sorey a comporre, tra il 2002 e il 2006, le quarantuno composizioni da cui sono state estrapolate le dieci che costituiscono Oblique – I.) Qua e là affiora però un gusto particolare per una musica più meditativa e assorta, come testimoniano alcuni momenti di (per esempio) Thirty-Five, Eighteen, e Thirty-Six, ed è proprio questo il sentiero percorso con decisione da Sorey nei suoi lavori successivi, in una sintesi tra musica nera e musica classica occidentale, tra improvvisazione e composizione.
Il primo album a rivelare questa nuova direzione è Alloy (PI56, 2014), concepito come una bizzarra mutazione del formato piano trio. Lo swing di un Bill Evans o un Paul Bley viene però rimpiazzato da un accademismo austero, che parte dalla musica per pianoforte di Chopin e Debussy fino ad arrivare gli sviluppi post-cageiani di Morton Feldman. La musica si fa sfilacciata e rarefatta, il silenzio per Sorey diventa un nuovo, vitale strumento con cui giocare – e inevitabilmente lo porta a prediligere sonorità sparse e dinamiche pianissime, venendo meno al suo caratteristico sostegno ritmico e utilizzando con parsimonia le bacchette. A dominare è invece il tono umbratile del pianoforte di Cory Smythe (già membro stabile dell’International Contemporary Ensemble). E anche se quella esibita su Alloy non è una prospettiva completamente inedita nell’opera di Sorey (Template, per esempio, proviene dalle sessioni di That / Not e qua viene anzi accelerata rispetto all’originale) l’assenza di fiati conferisce alla musica una dimensione onirica e astratta che non viene meno neanche in una composizione a programma come A Love Song, che nei suoi oltre trenta minuti di durata appare sfuggente e aliena a qualsiasi vicenda umana, nonostante il tema si basi sulle ben terrene peripezie sentimentali di un uomo e diverse donne. L’unica cosa che limita la portata di Alloy (che comunque già permette a Sorey di vincere il titolo di Number one rising star drummer nel sondaggio dei critici di Downbeat) è la pervasiva sensazione che la nuova poetica del batterista sia qui solo abbozzata, e la direzione da perseguire non sia ancora ben delineata nel groviglio di possibili sentieri da percorrere.

Questa sensazione viene spazzata via già con il successivo The Inner Spectrum of Variables (PI65, 2016), grandiosa composizione di quasi due ore di durata, suddivisa in sei movimenti più una spettrale reverie di quindici minuti, orchestrata per doppio trio. (Al piano trio di Alloy si aggiunge un trio d’archi composto di violino, viola e violoncello, suonati da un gruppo di musicisti con esperienza in complessi di musica contemporanea come il Sirius String Quartet e l’International Contemporary Ensemble.) In questo lavoro lo studio delle possibilità di interazione tra composizione e improvvisazione si fa molto più profondo (non a caso, Sorey cita apertamente le conduction di Butch Morris come una grande influenza su questa opera), anche se a livello musicale The Inner Spectrum of Variables si spinge con decisione verso la musica classica. Pure nei momenti più apertamente jazzati, non è la tradizione più swingante del genere a rappresentare il parente più prossimo della musica di Sorey (seppur egli dichiari, a sorpresa, che tra le varie influenze sulla sua arte vi sia anche il leggendario Louis Armstrong) bensì dalle sue propaggini più arcigne, AACM in primis. Ovviamente, la presenza degli archi a sostituire la più tradizionale front line di ottoni gioca un ruolo fondamentale in questo senso, ma non va sottovalutato nemmeno il contributo del solito Cory Smythe, il cui pianismo assorbe suggestioni da Chopin, Scriabin e Messiaen oltre che da Lennie Tristano e Paul Bley. La musica è solo vagamente meno diradata di quella di Alloy: la sezione ritmica gioca ancora una volta un ruolo fortemente secondario, e Sorey per la gran parte del disco non tocca nemmeno lo strumento. Il suo ruolo principale è quello di direttore dell’ensemble, dando direttive esplicite su come leggere ed eseguire il materiale scritto nella partitura; solo occasionalmente si esibisce dietro la batteria, alternando bacchette e spazzole, e non sorprendentemente questi momenti coincidono con quelli in cui The Inner Spectrum of Variables si avvicina di più alla musica afro-americana. Certo, il disco paga qualche lungaggine di troppo (la The Inner Spectrum of Variables che possiamo ascoltare su disco dura circa il doppio rispetto alla versione che aveva debuttato in un’esibizione a Brooklyn nel maggio 2015), ma con il suo innovativo connubio di musica classica e jazz, tra Brahms, Schoenberg, Walter Zimmermann e Anthony Davis rappresenta comunque una delle più innovative registrazioni contemporanee di questo decennio. Forse, l’unico precedente che si può trovare a un album del genere è probabilmente il monolitico capolavoro Ten Freedom Summers di Wadada Leo Smith, pubblicato nel 2012 dalla Cuneiform. The Inner Spectrum of Variables è un lavoro tanto riuscito da permettere a Tyshawn Sorey di valicare gli steccati del pubblico jazz. La sua fama raggiunge anche la stampa e il pubblico interessato alla musica contemporanea, che lo elegge come uno dei massimi talenti emergenti: il prestigiosissimo Alex Ross ha dedicato al The Inner Spectrum of Variables un’entusiasta recensione sul New Yorker, mentre Zachary Woolfe del New York Times ha accolto calorosamente la prima mondiale della sua composizione Josephine Baker: A Personal Portrait, che ha debuttato all’Ojai Music Festival nel 2016, definendola “uno dei lavori più importanti emersi dal movimento Black Lives Matter”.
Recuperato il formato piano trio di Alloy, Verisimilitude (PI70, 2017) è stato, fino a poche settimane fa, l’ultimo album per la Pi di Tyshawn Sorey (l’anno scorso aveva comunque pubblicato il monumentale Pillars per la Firehouse 12, cui abbiamo dedicato un’attenta recensione proprio su queste pagine), ed è uno dei lavori più profondi e intensi della sua eccellente opera. Le cinque composizioni che formano il disco risalgono direttamente ad alcune esibizioni al Newport Jazz Festival e al Village Vanguard del 2016 e 2017 rispettivamente, e sembrano recuperare la poetica dei brani di Alloy aggiornandole però con la nuova consapevolezza e la maturità di scrittura acquisite con The Inner Spectrum of Variables e Josephine Baker: A Personal Portrait. Il minutaggio rispetto all’album precedente si è molto ridotto – passando da quasi due ore ai settantanove minuti di un singolo cd – e la scelta si rivela vincente, visto che Verisimilitude si ritrova levigato dei momenti più prolissi di The Inner Spectrum of Variables. Eppure, le composizioni di Sorey si schiudono ancora attraverso un processo estremamente lento e graduale: sembrano svolgersi al rallentatore, quasi come se si trattasse di una normale performance in piano trio che viene però dilatata all’inverosimile, producendo in questo modo impressioni di paesaggi misteriosi dai contorni indefiniti. Come nei lavori precedenti, è sempre il doppio mentorato spirituale di Butch Morris e Morton Feldman a guidare lo sviluppo dei brani, anche se i riferimenti musicali chiamati in causa in Verisimilitude sono i più disparati: Debussy, Webern, Stockhausen, Messiaen, Bill Dixon, Anthony Davis, Anthony Braxton sono tutti nomi che possono essere chiamati in causa per descrivere qualche aspetto o qualche frammento di Verisimilitude – e pertanto, dimostrano come un arido elenco di nomi ingombranti non sia più atto a cogliere appieno la personale proposta di Tyshawn Sorey. Il silenzio gioca ancora un ruolo fondamentale nell’estetica di Sorey, avvolgendo e inghiottendo il suono degli strumenti, mentre la linea temporale seguita dai musicisti è sfilacciata e offuscata, secondo la lezione del Philip Guston di Feldman. Infine, l’uso di live electronics (che esaltano il riverbero degli strumenti nel vuoto siderale del silenzio e ne distorcono il suono), percussioni assortite (tra cui gong, timpani, campanelle, oltre alla classica batteria) e perfino un piano giocattolo arricchiscono quindi la palette timbrica da cui Sorey può attingere. La musica è completamente scritta, ma tramite segnali testuali o verbali predeterminati Sorey può suggerire, nel mezzo dell’esecuzione, un cambio di tonalità, o un cambio di dinamica; può richiedere un fortissimo unisono o un assolo, o ancora può dirigere l’esecuzione retrogradando la partitura. Verisimilitude suona quindi disorientante – probabilmente perché gli stessi musicisti non sanno in che direzione si muoveranno sotto le direttive del leader – e per questo è un lavoro completamente unico, caratterizzato da una poetica e una sensibilità propria solo di Sorey. Soprattutto in Obsidian e Algid November (che insieme occupano oltre cinquanta dei settantanove minuti del disco), il gruppo interpreta in maniera fortemente innovativa la dimensione del piano trio, alternando tenui acquerelli impressionisti a folate elettroacustiche, spingendosi verso lidi dissonanti per poi fare marcia indietro e cimentarsi in sezioni più jazzate in linea con il post-bop più armonicamente avanzato. Sfuggente ed enigmatico, Verisimilitude è certamente uno degli esperimenti a metà tra composizione e improvvisazione più innovativi tra quelli tentati dai musicisti del catalogo Pi, e probabilmente tra i più importanti nell’intero panorama avant-garde di questi anni.

Forse l’artista più prodigioso che abbia mai lavorato con la Pi Recordings è però il pianista Matt Mitchell, che negli ultimi dieci anni è stato non solo uno dei musicisti che ha registrato più lavori in assoluto con l’etichetta (tra album da leader e come sideman per artisti del calibro di Steve Coleman, Jonathan Finlayson e Dan Weiss, tra gli altri, ha registrato undici dischi), ma in generale uno dei musicisti più richiesti nell’intera scena post-bop e avant-garde americana (Snake Oil di Tim Berne, Bird Calls di Rudresh Mahanthappa, Simple di Anna Webber e il recentissimo eccezionale Path of Totality di Quinsin Nachoff, di cui abbiamo parlato proprio negli ultimi mesi, sono solo alcuni dei lavori che recentemente si sono avvalsi della sua presenza). Classe 1975, Mitchell si è avvicinato a soli sei anni al pianoforte, cominciando a comporre dopo averne compiuti dieci, influenzato dall’opera di Keith Jarrett e di Herbie Hancock. Laureato presso la Indiana University e con un Master’s Degree conseguito presso la Eastman School of Music, Mitchell vanta una carriera ragguardevole sia come strumentista che come accademico, avendo insegnato alla School for Improvisational Music di Brooklyn e alla New School di New York, e avendo suonato insieme a musicisti del calibro di Tyshawn Sorey, Lee Konitz, Dave Douglas, Kenny Wheeler, e David Torn. Addirittura, una delle sue prime performance incise su disco lo vede alle prese con la musica dei Thinking Plague, storica istituzione dell’avant-prog di derivazione RIO statunitense, nei panni di tastierista; indubbiamente, però, è l’esperienza maturata con i gruppi di Tim Berne quella che ha permesso a Matt Mitchell di diventare uno dei più importanti (se non il più importante) pianista jazz attualmente attivo negli Stati Uniti. Secondo lo stesso Berne:
«Since we began working together the last four years I’ve seen him blossom into one of the most important pianists in music. His ability to navigate complex composed and improvised structures with incredible ease and maturity is revelatory.»
Con un curriculum tanto ingombrante, il nome di Matt Mitchell era inevitabilmente piuttosto chiacchierato già da prima che desse alle stampe il suo esordio da leader con Fiction (PI50, 2013). Registrato in duo con il batterista e percussionista Ches Smith, per quanto rappresenti un buon lavoro è però poco indicativo dell’estetica sviluppata da Mitchell negli anni successivi: si tratta infatti di una collezione di brani sgorgati a partire da studi individuali che Mitchell aveva cominciato a partorire a partire dal 2010, per testare la propria abilità tecnica e per lavorare sull’integrazione di forme improvvisate in musica già scritta. Ogni pezzo propone una sfida per l’esecutore, che possa essere suonare seguendo due tempi diversi tra mano sinistra e mano destra, oppure gestire ritmi continuamente mutevoli, oppure ancora cimentarsi in proibitivi salti di intervallo tra suoni consecutivi. Questi studi sono diventati quindi esercizi di riscaldamento prima dei concerti con Tim Berne, e dunque veri e propri brani in duo quando Ches Smith ha cominciato (dapprima per gioco, e poi più seriamente) a improvvisare e lavorare su di essi insieme a Mitchell. Per gli amanti delle possibilità più estreme del pianoforte jazz, tra poliritmi cerebrali che richiamano il pianismo percussivo di Cecil Taylor (anche se con l’esplicito intento di emulare le ritmiche degli Autechre), aperture più melodiche riprese dal romanticismo di Chopin, e una personalissima manipolazione dell’armonia come da lezione Andrew Hill, Fiction è assolutamente da recuperare.
Se in Fiction il caratterere bozzettistico dei brani appariva comunque chiaramente, soprattutto nei numeri più brevi, il successivo doppio Vista Accumulation (PI62, 2015), registrato per quartetto (oltre a Mitchell, vi sono Chris Speed al sassofono tenore e al clarinetto, Christopher Tordini al contrabbasso, Dan Weiss alla batteria), compie un prodigioso salto di qualità per quanto riguarda la scrittura. Le composizioni si fanno ora molto più lunghe ed elaborate (delle otto comprese in Vista Accumulation, solo tre durano meno di dieci minuti, e di queste nessuna scende sotto i sette), dipanandosi lungo uno sviluppo completamente libero e lineare tra improvvisazioni collettive, assoli individuali e conversazioni tra i vari strumenti. I brani si collocano in una dimensione austera, complice anche la scintillante produzione dei suoni, più affine a certa musica contemporanea che a un disco di jazz, e che avvicina Vista Accumulation a grandi opere di jazzisti che hanno subìto il fascino della musica colta; in particolare, vengono in mente i lavori per HatHut di Franz Koglmann e Guillermo Gregorio, anche se si possono rintracciare influenze risalenti fino al leggendario trio di Jimmy Giuffre dei primi anni Sessanta (soprattutto quando interviene il clarinetto di Chris Speed, il cui tono caldo, le linee sinuose vicine alla ruralità europea e l’utilizzo prevalente del registro più grave dello strumento rimandano molto al maestro texano). Inoltre, il vasto vocabolario stilistico cui i musicisti possono attingere rende il lavoro ulteriormente inclassificabile: nell’insieme, il quartetto vanta esperienza nel metal, nel progressive rock, nella musica indiana e in quella classica contemporanea – oltre ovviamente al jazz in ogni sua sfumatura –, e questa varietà di linguaggi permea ogni brano di Vista Accumulation, per quanto subliminalmente. Lo stesso Mitchell qui sfodera uno stile pianistico molto più evoluto di quello (già ben lontano dall’essere semplice o derivativo) esibito su Fiction, dimostrando di aver assimilato tanto la pronuncia afro-americana di Andrew Hill e Horace Tapscott, quanto l’ardito gusto armonico e melodico di Paul Bley e Lennie Tristano, quanto l’opera dei compositori per pianoforte appartenenti alla storia della musica classica europea, da Charles-Valentin Alkan fino a Iannis Xenakis, sporcato in continuazione da un gusto personale che non disdegna il death metal, l’elettronica più astratta e il noise. Tanto che la musica prodotta, tra partiture densissime ispirate alla New Complexity anglosassone, ritmiche intricate provenienti dall’M-base e aperture più rade figlie della poetica di Morton Feldman che esplodono quindi in improvvisazioni più esplicitamente jazzistiche, diventa infine molto vicina in spirito a quella di grandi innovatori dell’avant-prog come Henry Cow e News from Babel. Per questo, Vista Accumulation risulta essere sì un disco difficile e non esattamente accessibile, ma anche particolarmente indicato come introduzione alla musica di Mitchell per gli ascoltatori dal gusto per il jazz meno ortodosso e più vicino, per sensibilità e mezzi impiegati, alla musica europea o al rock più avant-garde.

Rivoluzionando nuovamente organico e stile, A Pouting Grimace (PI71, 2017) aggiunge a quanto già proposto nei due album precedenti un eclettismo sonoro ancora più stupefacente, nonché un’esplorazione timbrica senza precedenti e con pochi eguali in tutto il panorama jazz contemporaneo. Al contrario di Fiction e Vista Accumulation, suonati da una line-up stabile per tutta la durata del disco, A Pouting Grimace è una raccolta di sei composizioni pensate ed eseguite da diverse formazioni di volume variabile (la più contenuta consta cinque elementi, quella più allargata vanta ben dodici musicisti, senza contare Tyshawn Sorey nei panni del conduttore dell’ensemble), che raccolgono la crema della scena avant-jazz new yorkese e americana in generale – da Anna Webber a Ches Smith passando per Jon Irabagon e Dan Weiss, oltre al già citato Sorey –. A corollario di queste, quattro parentesi elettroniche (che ricoprono il ruolo di overture, interludio e conclusione del lavoro) vedono il solo Matt Mitchell gigioneggiare con il Prophet 6, dipingendo gelidi acquerelli cosmici basati solo sull’effettistica del sintetizzatore e su turbinii e loop di elettronica. Di queste, solo la conclusiva ooze interim supera i due minuti di durata. Le sei composizioni principali vedono invece avvicendarsi strumenti classici della tradizione jazzistica (sassofoni, clarinetti, corni, pianoforte, contrabbasso, vibrafono e batteria) e alcuni più inusuali (flauti, fagotti, oboe, arpa e glockenspiel), oltre a una pletora di percussioni provenienti dalla cultura latina (tanbou, marimba e conga), africana (bongo), indiana (tabla) e cinese (gong). Ognuna di queste indaga le possibili interazioni tra strumenti a fiato (e in particolar modo i legni) con quelli a percussione, prendendo piede da un nucleo primitivo (un concetto, un tema o un’idea per la performance) e sviluppandosi, a partire da questo, in maniera più o meno deterministica – agli esecutori è comunque concesso improvvisare, pur seguendo un preciso set di regole, rendendo i brani sempre dinamici ed esotici nonostante la natura fissa della scrittura. In plate shapes, per esempio, il settetto viene limitato da una griglia prefissata di possibili manovre improvvisative, e così, mentre il sassofono e il pianoforte sono costretti a sfruttare la ripetizione dello stesso tema per prendere dimestichezza con la performance, il vibrafono, la marimba e il fagotto decorano il pezzo sviluppandone gli arrangiamenti; in mini alternate, invece, gli strumenti ricamano diverse frasi melodiche e assoli basandosi sempre sullo stesso schema di contrabbasso, ribadito per tutta la durata del brano, in tal modo celando uno sviluppo circolare con l’illusione di un’evoluzione lineare. I pezzi migliori sono in ogni caso i due che vedono la formazione di tredici musicisti al completo. Il primo di questi, brim, è un caleidoscopio torrenziale e amorfo di dinamiche sempre cangianti, in cui le linee di flauto, oboe e fagotto si contrappuntano leggiadre mentre i poliritmi intessuti dal pianoforte e dalle percussioni sabotano i misteriosi assoli dei fiati: è quasi impossibile riuscire a seguire perfettamente la direzione delle singole parti strumentali, eppure il risultato finale suggerisce una struttura ben ordinata soggiacente alla performance corale. (brim è anche il brano da cui scaturiscono le altre composizioni di A Pouting Grimace: mini alternate per esempio nasce da un frammento retrogradato di brim, mentre l’interludio elettronico deal sweeteners ne è di fatto un riepilogo elettroacustico.) sick fields, che sfiora i dieci minuti di durata, è invece la composizione più lunga del disco e nella sua natura spoglia, fatta di allucinazioni e visioni scollegate dove i diversi musicisti intervengono ordinatamente in piccoli gruppi, ergendosi timidamente nel silenzio, si rivela figlia tanto di Morton Feldman quanto dei recenti sviluppi dell’arte di Tyshawn Sorey. Vista anche la varietà di formazioni chiamate all’azione lungo l’album, A Pouting Grimace suona inevitabilmente come un disco densissimo di invenzioni melodiche, armoniche e ritmiche, con un gusto dell’orchestrazione che rimanda ora ai gruppi di Henry Threadgill, ora alla musica di Anthony Braxton, ora perfino all’avant-prog. E a indagare con attenzione fino ai più reconditi dettagli del disco, si possono scorgere anche scorie e suggestioni di metal estremo (la cadenza apocalittica che apre heft), della musica modale orientale, di Harrison Birtwistle, di Iannis Xenakis. La ricchezza di idee in questo lavoro rende A Pouting Grimace da un lato immediatamente avvincente e sorprendente; dall’altro lo rende misterioso e sfuggente, poiché la varietà di riferimenti e di soluzioni adottate si svela lentamente con il progredire degli ascolti. È uno degli album più originali e unici di tutto il panorama jazz del nuovo millennio, e insieme a lavori come Sélébéyone o Verisimilitude può ambire alla palma di miglior disco Pi di questi anni Dieci.

Abbiamo discusso ampiamente di ciò che la Pi Recordings ha prodotto fino al 2018, ma non abbiamo detto nulla riguardo a cosa l’etichetta abbia rilasciato nel 2019. Proseguendo coerentemente con il proprio programma di pubblicare pochi dischi ogni anno, la Pi ha finora inciso solo cinque album, di cui uno è il lavoro dell’Art Ensemble of Chicago menzionato fugacemente nella prima parte di questo articolo. In ogni caso, le uscite di questo 2019 si pongono sui sempre ottimi (e talvolta pure più alti) standard qualitativi a cui la Pi ci ha abituato in questi quasi vent’anni di attività.
La prima di queste, in ordine cronologico, è Clockwise (PI79) registrato dalla flautista e sassofonista Anna Webber, già su Sixteen: Drummers Suite (Dan Weiss), A Pouting Grimace (Matt Mitchell) e Song of Silver Geese (Jen Shyu) e qui al suo debutto da leader per la Pi. In questi anni, la Webber si è fatta notare grazie a un paio di buone uscite per la Skirl Records con il suo trio Simple (comprendente anche Matt Mitchell), dove metteva in luce il suo background accademico. Nonostante si esprima principalmente nel formato della musica improvvisata, il suo linguaggio è infatti fortemente legato al mondo della musica classica occidentale contemporanea, da Karlheinz Stockhausen e Iannis Xenakis a Morton Feldman e John Cage. (Ha anche suonato alla prima mondiale di Sila: The Breath of the World del compositore John Luther Adams, premio Pulitzer nel 2013).

Clockwise, per settetto comprendente due fiati, un pianoforte, un violoncello, un trombone, un contrabbasso e una batteria, trova la sua ispirazione principale proprio nella musica contemporanea, e in particolare nelle composizioni per percussioni. Il nucleo primigenio della quasi totalità dei brani viene estratto da una figura ritmica di qualche opera percussiva del Novecento, che viene quindi decontestualizzata e utilizzata come fonte creativa da cui far scaturire una composizione completamente nuova – come ci tiene a specificare la stessa Webber, è un’operazione più radicale della semplice ricontestualizzazione della cellula musicale originaria. In Kore II e Kore I, posti rispettivamente in apertura e in chiusura di Clockwise, i ritmi scanditi dai sei percussionisti su Persephassa vengono usati per dirigere i contrappunti dei vari strumenti, che intervengono seguendo i tempi dettati nell’opera originale di Iannis Xenakis; in Array, le parti strumentali individuali si limitano ad abbozzare le linee melodiche che emergono invece dalla performance corale dei musicisti, che rubandosi le note a vicenda e calpestandosi i piedi imbastiscono insieme un’improvvisazione liberamente tratta dal pattern di rullante di Homily di Milton Babbitt. O ancora, sulle tre parti di King of Denmark (ispirata alla composizione omonima di Morton Feldman) da schizofreniche cellule ritmiche emergono alcune delle improvvisazioni più logicamente coerenti del gruppo – sovvertendo completamente la sparsità del brano originale, che paradossalmente si avverte invece nella title track ispirata a Zyklus di Karlheinz Stockhausen. L’unica eccezione a questo modus operandi è rappresentata da Idiom II, brano completamente originale che, nonostante si muova su binari totalmente ascrivibili all’avant-jazz, nelle parti per violoncello di Christopher Hoffman (che richiamano quelle di Abdul Wadud) e nei dissonanti intrecci dei sassofoni della Webber e di Jeremy Viner (che riportano alla mente la Inner Time II di Horațiu Rădulescu) manifesta ancora una evidente continuità con la produzione classica contemporanea. Album come Simple (2016) mostravano già un’estrema bontà del linguaggio coniato da Anna Webber, eppure era assolutamente impossibile immaginare che ella avrebbe raggiunto così presto vertici creativi tanto elevati. Clockwise è un profondo studio sul ritmo, sul timbro e sulle dinamiche, che diventano il fulcro della musica riducendo all’osso la componente armonica e melodica – e, di conseguenza, l’album diviene anche una sfida per gli esecutori che devono realizzare brani coerenti senza avvalersi di tali elementi. A suo modo, Clockwise è anche una riflessione sull’eredità della classica contemporanea e sul possibile rapporto fruttifero tra questa e il jazz – una delle riflessioni più acute che si potessero fare a riguardo, perdipiù.
Il 31 maggio è stata quindi la volta di di Phalanx Ambassadors (PI81) del solito Matt Mitchell – probabilmente, una delle uscite più belle dell’intero catalogo fin dalla fondazione dell’etichetta. Per la sua quarta uscita da leader per la Pi, Mitchell ha introdotto l’ennesima nuova formazione (i Phalanx Ambassadors, appunto), un quintetto comprendente tastiere, chitarra (Miles Okazaki), vibrafono (Patricia Brennan), contrabbasso (Kim Cass) e batteria (Kate Gentile) con cui Mitchell si cimenta in alcune composizioni tra le più cerebrali della sua intera carriera. La nascita del progetto risale a diversi anni fa, ma la prima del gruppo è arrivata solo nel 2016, e la registrazione del disco è avvenuta solo nel dicembre 2018 – successivamente sia alla composizione che alla registrazione di A Pouting Grimace, proprio a causa della complessità della musica dei Phalanx Ambassadors. Phalanx Ambassadors nasce infatti dal concetto di stretch goal, che Mitchell eradica dal contesto del mondo del business dalla quale proviene per adattarla alla sua musica, allo scopo di definire un obiettivo musicale collettivo che richiede agli esecutori di lavorare ed estendere i propri limiti (tecnici e compositivi) per poter essere portato a termine. Il brano che apre l’album si chiama appunto stretch goal ed è una dichiarazione di intenti in questo senso, tra intricate interazioni ritmiche tra vibrafono e contrabbasso, dissonanti assoli di chitarra che più di una volta richiamano anche la musica rock, e l’esplosivo sostegno ritmico della batteria di Kate Gentile che sembra provenire direttamente da un disco metal: gli strumentisti sono solo cinque, ma la densità degli arrangiamenti e delle parti strumentali fanno pensare a un numero di elementi di molto superiore. stretch goal è stato il primo brano composto per i Phalanx Ambassadors, e da esso è scaturita la scintilla creativa che ha portato alla realizzazione dell’intero album – in cui si addensano contrappunti cervellotici, fitte orchestrazioni, incastri ritmici sofisticati, ardite esplorazioni timbriche e armoniche. Quella contenuta in Phalanx Ambassadors è una musica difficilissima tanto per i musicisti (per la precisione loro richiesta per eseguirla perfettamente) quanto per gli ascoltatori (che si trovano a processare una quantità di informazione impressionante trasmessa anche in soli pochi secondi), che richiama, più che la scrittura poliritmica di Steve Coleman, addirittura le astruse partiture di Brian Ferneyhough. Anche brani dal minutaggio estremamente contenuto come taut pry o zoom romp, con la loro impenetrabile rete di incastri musicali dove chitarra elettrica, vibrafono e una miriade di effetti del Prophet 6 si sovrastano a vicenda, sfoderano una quantità di idee che sembra stare molto stretta nei loro duecento secondi di durata complessiva. È quindi una fortuna che Phalanx Ambassadors riveli la creatività di Mitchell alle prese anche con composizioni dal minutaggio ben più dilatato: nei sedici minuti della bellissima phasic haze ramps, sorta di rivisitazione contemporanea di Moonchild dei King Crimson alla luce dell’M-base e della New Complexity, le oniriche interazioni tra il pianoforte e il vibrafono e i liquidi assoli di chitarra frippiani di Okazaki tratteggiano scenari allucinati che si trasfigurano lentamente, rivelandosi con il passare del tempo attraverso misteriose improvvisazioni collettive; mind aortal cicatrix, posta in chiusura del disco, sfiora i nove minuti e mezzo di durata e viaggia con naturalezza da jam corali dominate dagli arrangiamenti policromatici del vibrafono della Brennan (che qui richiama il lavoro di Bobby Hutcherson nelle composizioni più astratte di Andrew Hill e Joe Chambers per i suoi dischi Blue Note anni Sessanta), a momenti di lustro individuale dove il fuzz, il Mellotron e le marimba ribadiscono subliminalmente gli assoli di chitarra, pianoforte e vibrafono rispettivamente. Nella sua indecifrabile complessità, Phalanx Ambassadors appare come un album assolutamente senza precedenti nell’opera di Matt Mitchell, e simultaneamente come una delle manifestazioni più pregnanti della sua personalissima poetica musicale: la particolare attenzione ai timbri (cfr. la nube di effetti di Prophet 6 che si addensa e ingloba l’improvvisazione del quintetto su be irreparable), l’eccezionale lavoro sul ritmo, i continui giochi con le dinamiche, i riferimenti schizofrenici che spaziano dal jazz, al rock, alla musica classica contemporanea senza alludere esplicitamente mai a nessuno di questi generi, sono tutte caratteristiche che hanno accompagnato l’opera di Mitchell fin dai tempi di Fiction. In perfetto equilibrio tra l’essere la testimonianza di una maturità stilistica ormai da tempo acquisita, e una visionaria collezione di musica nuovamente proiettata all’ignoto, Phalanx Ambassadors è un nuovo capolavoro di un artista che parla ormai solo la sua lingua e che, se c’è giustizia, sarà ricordato come uno dei più grandi di questo primo scorcio di secolo.

A Phalanx Ambassadors ha fatto seguito The People I Love (PI82) di Steve Lehman, pubblicato il 30 agosto. Questa volta Lehman è tornato a esibirsi con il suo trio (Matt Brewer al contrabbasso e Damion Reid alla batteria), ma aggiungendovi la partecipazione esclusiva di Craig Taborn, prestigioso pianista che, nonostante relativamente poche apparizioni su registrazioni Pi (negli anni Dieci ha suonato solo su Starebaby di Dan Weiss e su Trickster, PI68, 2017, di Miles Okazaki), condivide con molti suoi artisti una visione avant-garde alla materia jazzistica e dei gusti eterogenei che vanno da (ovviamente) il jazz, alla classica contemporanea, all’elettronica, fino al death metal.
«Craig is one of the most brilliant musicians of his generation. We’ve been friends for a long time; played duo in acoustic and electronic settings, and talked for hours about everything under the sun. I don’t think there’s anyone out there more in sync with my overall musical aesthetic.»
Steve Lehman
The People I Love, nei propositi di Lehman, vuole essere una ricapitolazione dello stato dell’arte del jazz nel 2019 e al contempo una dichiarazione di ammirazione per, appunto, le persone che Lehman ama – vale a dire le sue influenze, i suoi riferimenti musicali, e gli artisti che più in generale hanno inciso alcuni di quelli che considera moderni standard del genere. A suo modo, The People I Love è un disco intimo, tanto da comprendere senza problemi anche una registrazione in presa diretta e priva di qualsiasi edit in post-produzione come A Shifting Design (originariamente di Kurt Rosenwinkel, dove Steve Lehman mostra l’influenza esercitata sul suo stile da Evan Parker e Anthony Braxton) e reinterpretazioni aggiornate di brani del vecchio repertorio dello stesso Lehman. Beyond All Limits, qua allungata di oltre tre minuti rispetto alla versione di Mise en Abîme, vede per esempio Taborn ingegnarsi per suggerire l’armonia spettralista che nell’incisione originale era esplicita grazie all’accordatura microtonale del vibrafono di Chris Dingman e all’intervento dell’elettronica; Curse Fraction, senza più la partecipazione del solito Dingman e della tromba di Jonathan Finlayson, si trova eccessivamente spogliata della ricchezza timbrica che invece vantava la registrazione su On Meaning (PI25, 2007). Sono molto più interessanti la rivisitazione di qplay degli Autechre (da Oversteps del 2010), nuova occasione per Damion Reid di sfoggiare la sua tecnica eccezionale come batterista e per Craig Taborn di mettersi ancora una volta alla prova in un contesto a metà tra il jazz e l’elettronica, e quelle di Echoes (da Travail, Transformation & Flow) e di The Impaler di Jeff “Tain” Watts (da Citizen Tain del 1999), compattate nei cinque minuti di frenetico post-bop modernista di Echoes / The Impaler.
Primo disco intitolato al suo trio dopo Dialect Fluorescent del 2012, The People I Love non prosegue nel solco di quanto sperimentato negli ultimi capolavori per ottetto o con il gruppo Sélébéyone. Ciononostante, non va visto come un passo indietro rispetto a quei lavori, quanto una digressione nella sua recente discografia: The People I Love è un album che, nonostante la complessità melodica e ritmica degli assoli di Lehman e Taborn, ricerca innanzitutto di comunicare la sensibilità e l’emotività del leader tramite una narrazione personale dei suoi ascolti e delle sue influenze. Non il suo lavoro più rivoluzionario o imperdibile, ma una gustosa aggiunta alla carriera di uno dei giganti dell’avant-jazz contemporaneo.

Infine, dopo nemmeno un mese dall’uscita di The People I Love, la Pi Recordings ha pubblicato The Adornment of Time (PI83), prima incisione in assoluto del duo composto da Tyshawn Sorey e Marilyn Crispell – storica veterana del pianoforte jazz affermatasi negli anni Ottanta negli ambienti dell’AACM e che oltre a una vastità di album a suo nome vanta anche prestigiose collaborazioni con i giganti dell’organizzazione (la più rilevante è probabilmente quella nel quartetto di Anthony Braxton degli anni Novanta).
L’idea di una collaborazione con la Crispell ha aleggiato nella mente di Sorey fin dal 2005, quando la conobbe a un festival in Austria, ed è potuta finalmente concretizzarsi in occasione di un concerto al Kitchen di New York, tenutosi il 21 ottobre 2018. In contrasto con quanto registrato precedentemente da Sorey, The Adornment of Time è un brano completamente improvvisato, senza nessun dettaglio stabilito a priori della performance. Di conseguenza, The Adornment of Time vede Sorey abbandonare il ruolo di direttore e band leader che ha ricoperto con tanta intelligenza in questi anni: l’esibizione registrata al Kitchen non prevede gerarchie di nessun tipo, e in questo senso ha molto più a che vedere con le classiche improvvisazioni del free jazz che non con l’opera precedente di Tyshawn Sorey. Se a questo si aggiunge anche la riconoscibile pronuncia ritmica della Crispell, che rispetto al solito Cory Smythe ha un’impronta più marcatamente afro-americana e percussiva, non sorprende quindi che The Adornment of Time appaia come il disco più jazz tra tutti quelli registrati da Sorey per la Pi fin dai tempi di Oblique – I.
Non che il duo rifiuti digressioni più meditative e aperture più sfocate, con le percussioni che prendono il sopravvento mentre il pianoforte tace o lesina note che si perdono nell’aria – e anzi, nella seconda metà del brano il duo esplora con maggiore curiosità proprio questo sentiero più sparso, muovendosi in punta di piedi tra oscuri assoli in solitaria di Sorey e obliqui temi di pianoforte preparato i cui contorni si definiscono con chiarezza solo con il passare dei minuti. Ma i radi colpi delle percussioni e le note di piano centellinate con parsimonia di queste sezioni più feldmaniane si rivelano, a posteriori, i tasselli fondamentali di un’improvvisazione che diviene progressivamente più esplosiva e turbolenta, trovando infine una climax negli assoli torrenziali della Crispell. Il suo stile richiama con decisione la tradizione pianistica free jazz di giganti come Anthony Davis e soprattutto Cecil Taylor – i cui concerti in duo al festival di Berlino del 1988 sono, anche per questioni di formazione, uno dei più fulgidi punti di riferimento di The Adornment of Time. Proprio come Taylor, Marilyn Crispell è capace di alternare elucubrazioni liriche ad arcigni cluster dissonanti in fortissimo (come quelli che sovrastano gli ultimissimi minuti del brano), dando varietà emotiva, oltre che musicale, all’improvvisazione. Questi momenti più vicini al free jazz classicamente inteso di The Adornment of Time offrono un’occasione per apprezzare al meglio anche lo stile alla batteria di Tyshawn Sorey, che nei dischi precedenti veniva parzialmente offuscato dal carattere esoterico delle sue composizioni: il suo gusto come strumentista è completamente unico, anche per via di uno stuolo di influenze che passa, oltre che per i grandi dello strumento come Jack DeJohnette, Elvin Jones e Art Blakey, anche per outsider di spessore come Jaki Liebezeit dei Can, Weasel Walter dei Flying Luttenbachers e Flo Mounier dei Cryptopsy, e per nuovi interpreti della batteria jazz come Dan Weiss, Kate Gentile e Makaya McCraven. Un musicista ed esecutore, oltre che un compositore e un intellettuale, di primissimo ordine, e tra i più importanti del nuovo millennio.
The Adornment of Time segna così l’ultimo capitolo della saga della Pi Recordings, che comunque non si appresta a interrompersi nel breve termine. Un sesto album da pubblicare in questo 2019 è già stato annunciato: si tratta di The Sea Below di Miles Okazaki, grandissimo chitarrista attivo da moltissimi anni nella scena newyorkese sia come side man che come band leader, che farebbe seguito al suo primo album Pi Trickster. [Edit: il disco è stato pubblicato il 25 ottobre, quando le prime due parti di questo articolo erano già state messe online.] A prescindere da cosa ci riserverà nel futuro questa etichetta, in ogni caso, la Pi Recordings ha già marchiato a fuoco il panorama musicale di questi anni Dieci. La sua proposta innovativa e la sua estetica unica, riconoscibile nonostante la pluralità di voci e sensibilità raccolte sotto la propria egida, l’hanno resa già un instant classic del nuovo millennio: il ruolo di punta che la Pi ricopre nel panorama avant-garde di questo periodo è paragonabile a quello che la Black Saint o addirittura l’ECM giocavano tra anni Settanta e Ottanta. Mentre attendiamo con trepidazione le prossime mosse di Rosner e Wang, il nostro consiglio spassionato è soltanto uno: ascoltate i loro dischi, recuperate i lavori che hanno già pubblicato, rimanete aggiornati sulle nuove uscite del loro catalogo, se volete supportatela comprando direttamente dal loro negozio online. E se non avete idea da dove partire, abbiamo preparato anche una possibile discografia introduttiva per conoscere alcuni dei lavori più profondi e di impatto pubblicati dalla Pi Recordings in questo decennio. Non avete più nessuna scusa.

Discografia consigliata (2010-2019):
☆☆☆
Steve Coleman – Synovial Joints
Amir ElSaffar – Crisis
Steve Lehman – Mise en Abîme
Steve Lehman – Sélébéyone
Matt Mitchell – A Pouting Grimace
Matt Mitchell – Phalanx Ambassadors
Tyshawn Sorey – Verisimilitude
☆☆
Steve Coleman – Morphogenesis
Jonathan Finlayson – 3 Times Round
Hafez Modizardeh – In Post-Chromodal Out!
Matt Mitchell – Vista Accumulation
Tyshawn Sorey – The Inner Spectrum of Variables
Anna Webber – Clockwise
Dan Weiss – Fourteen
☆
Steve Coleman – Functional Arrhythmias
Amir ElSaffar – Inana
Amir ElSaffar – Alchemy
Jonathan Finlayson – The Moment & the Message
Jonathan Finlayson – Moving Still
Matt Mitchell – Fiction
Jen Shyu – Song of Silver Geese
Tyshawn Sorey – Oblique – I
Tyshawn Sorey & Marilyn Crispell – The Adornment of Time
Henry Threadgill – In for a Penny, In for a Pound
David Virelles – Igbó Alákọrin (The Singer’s Grove) Vol I and II
Dan Weiss – Starebaby