È facile pensare all’anno appena passato come un periodo in cui si sono sovrapposti tra di loro eventi che, per un motivo o per l’altro, meriterebbero di essere qualcosa di più di una nota a margine di un articolo che vuole discutere di qualcosa di pressoché irrilevante come “lo stato dell’arte” all’interno di una frazionatissima comunità di artisti. Frazionatissima perché, nonostante la nostra classifica editoriale dimostri comunque una preziosa apertura dello sguardo su scenari al di là di quel pugno di musicisti intriganti che si muovono all’interno del panorama europeo e nordamericano, deve necessariamente fare i conti con la sempre più inevitabile atomizzazione del panorama, un orizzonte degli eventi in continua espansione e che rende impossibile la catalogazione sistematica e rigorosa di “tutto quello che è uscito”. Per dire, sono sicuro di non aver toccato gran parte dei dischi più chiacchierati di quest’anno, salvo qualche estemporanea eccezione come Motomami di Rosalía, proprio perché i dischi in questione erano troppo chiacchierati. Non si veda il rifiuto come una sorta di hipsterismo malcelato: nel momento in cui si fa parte di una webzine che tenta in ogni modo di scavare e affondare le proprie stilettate in territori vergini e floridi, ritrovarsi di fronte a un’enorme quantità di scritto riguardo all’ennesimo, irrilevante dischetto hyperpop mette in soggezione, soprattutto quando l’esperienza personale di ascolto del disco non fornisce nessun appiglio a cui invece lo scribacchino di Pitchfork di turno può aggrapparsi per raccontare appassionatamente in qualche migliaio di caratteri questo trauma intergenerazionale o quella ri-contestualizzazione post-coloniale poptimista di sta ceppa di cazzo. Quindi, in primo luogo il rifiuto di adeguarsi allo standard ha fatto sì che gli ascolti divenissero molto più accuratamente mirati verso band e artisti di cui non avevo mai sentito qualcosa prima d’ora o che, agli antipodi, fossero oramai in un modo o nell’altro nelle mie rotazioni di ascolti da anni con altri dischi. In secondo luogo, autoanalizzandomi, ho potuto notare un serio cambiamento nelle modalità in cui ho voluto scoprire i dischi più “in” del 2022, meno dipendente dalle comunità di infognati sfigati e rivolto perlopiù verso fonti come podcast (utilissimi per cassare un disco fin dall’estratto tirato fuori per qualche decina di secondi) o le newsletter (altrettanto utili per sussurrare tra sé e sé “ma te guarda che minchiata ha scritto Ansaldo su Internazionale anche sta settimana”), che hanno anche il privilegio di poter insegnare come NON si dovrebbe scrivere di musica la maggior parte del tempo. Allo stesso modo, ammetto candidamente di essermi infine arreso, verso la fine dell’anno, all’uso di Spotify per l’ascolto al posto di stare a solcare ogni volta i mari pirateschi di amati servizi p2p che meno se ne parla e meglio si sta. Devo dire che se da una parte la comodità della reperibilità è impareggiabile, mi sento ancora un po’ sporco a digitare nella barra di ricerca artisti che so che si meriterebbero molto più rispetto di quello che Spotify dà loro; per non parlare del fatto che un servizio del genere mi dà la sensazione di svilire il ruolo di ascoltatore per la maggior parte del tempo… Sono impressioni che devo ancora mettere a fuoco, e spero di riuscire a esplicitarle più avanti.

Quindi, tornando a noi: cosa rimane di questi 365 giorni passati con miriadi di note in cuffia? Sicuramente diversi dischi brutti, alcuni davvero bruttissimi: e se per alcuni – Michael Gira che strimpella per un’ora le sue demo e le vende a prezzo d’album, Jack White che decide di frullare qualsiasi riferimento musicale gli passi per la testa in maniera totalmente scoordinata e demente – posso dire di aver orgogliosamente adempiuto al mio dovere di recensore stroncando con rabbia delle perdite di tempo immani, per altri l’abbacinante e sconfortante silenzio della penna è stato una damnatio memoriae che adesso sono costretto a revocare per poche sferzate. Così, una processione di terribili spettri dai contorni indefiniti adesso assume, mentre le parole si incolonnano una dietro l’altra sullo schermo, dimensioni e nomi ben precisi: Eternal Stalker di Merzbow e Lawrence English (chissà perché ho voluto dedicare ancora il mio tempo a un qualsiasi progetto di Merzbow?); MLDE della Marxist Love Disco Ensemble (di gran lunga il più brutto disco italiano che abbia ascoltato quest’anno); Cool It Down degli spompatissimi Yeah Yeah Yeahs; PAINLESS di Nilüfer Yanya, che finendo nella top 10 dell’anno del sopracitato Ansaldo mi conferma che le mie prime impressioni sono molto spesso corrette; l’insulso Gemini Rights di Steve Lacy, che se è questo il futuro del bedroom pop ridatemi il cadavere dei Beat Happening; Bar Mediterraneo dei Nu Genea, che riesce a disperdere quel poco di buono che il gruppo aveva stabilito nel primo disco nel nulla cosmico con un irritante e pervasivo senso del kitsch; Hyper-Dimensional Expansion Beam dei The Comet Is Coming, che mi fa quasi gioire del fatto che Shakaba Hutchings abbia deciso di non suonare il sax almeno per tutto l’anno prossimo; ¡Ay! di Lucrecia Dalt, che la gente esaltava come la seconda venuta di Badalamenti e che invece è evidentemente stato l’ultimo chiodo da martellare sulla sua bara; LABYRINTHITIS di Destroyer, che per favore smettete di fargli fare i dischi; Cheat Codes di Danger Mouse & Black Thought, una delle uscite meno ispirate che abbia avuto modo di mettere in ascolto per cinquanta minuti quest’anno.
Mi sembra però altrettanto ingiusto a voler ridurre gli ultimi 12 mesi a uscite mediocri e senza direzione: il 2022 è stato anche e soprattutto un momento in cui è stato possibile trovare musica sinceramente bella in barba anche al fatto che la nicchia dove la si andava a cercare sembrava polverosa e piena di muffa. Così, oltre ai venti dischi che ho deciso di eleggere personalmente a capisaldi della mia classifica e che trovate in fondo a questi articoli, sono orgoglioso di poter affiancare allo stesso modo tanti piccoli, preziosi album: confortanti isolette di pace in un oceano sconfinato che hanno rappresentato l’unico modo in cui mi è stato possibile tenermi a galla, rifornire le scorte, e poi tirare avanti. Il loro quid, quello delle menzioni onorevoli, li piazza appena immediatamente al di sotto di quei dischi che sono finiti poi nella top 20; ma il loro ruolo è stato altrettanto fondamentale per farmi ben sperare in un altrettanto avventuroso 2023.

Così, se come me siete quel tipo di ganzi che sentono una chitarrina placida e si mettono a frignare e mi avete seguito nel riconoscere Eric Chenaux e Kevin Morby come due splendidi lavori di folk più o meno intimista, non posso fare a meno di consigliarvi delle adeguate controparti femminili che si sono cimentate nell’impresa di portarmi al lacrimone facile nell’appena terminato 2022. Tra queste spicca sicuramente lo splendido Se ve desde aquí di Mabe Fratti, che ha l’unico difetto di essere forse un po’ troppo simile al precedente Será que ahora podremos entendernos per essere altrettanto incisivo; allo stesso modo sarebbe da segnalare Warm Chris di Aldous Harding, che confeziona una decina di piccole ma strepitose ballate per pianoforte, chitarra e archi vari, forse un po’ troppo monocordi tutte in una volta ma gustosissime spizzicate di tanto in tanto. Sul versante maschile invece si può passare dall’abbraccio caldo di Sessa e del suo Estrela acesa, che col suo delicato tepore è quanto più di simile all’ “álbum branco” di João Gilberto si possa pensare, alle ipnotiche bordate di violoncello effettato di Oliver Coates in The Pale Faced Family on the Hill (e a conferma del mio buon intuito, Coates ha anche firmato la colonna sonora di uno dei film più toccanti dell’anno scorso, Aftersun).
Per quanto riguarda i versanti più sperimentali, due dischi che mi hanno sorpreso (in positivo) sono stati il colossale e cervellotico sforzo dei Matmos, che con il loro Regards / Ukłony dla Bogusław Schaeffer si sono confermati per l’ennesima volta come uno dei progetti più ambiziosi dell’elettronica hi-tech, sebbene il confine con lo sbrodolamento autocelebrativo sia molto labile su questa uscita; al polo opposto, il progetto Whatever the Weather di Loraine James (che lo scorso anno ha fatto uscire anche il meno riuscito Building Something Beautiful for Me) è riuscita a legare a un concept deboluccio (la variazione climatica degli ambienti di montagna: mah!) una bella e curata esplorazione dei tanti approcci alla techno più sfilacciata e chill-out, condendola a volte con clangori industriali, a volte con echi vagamente acid.
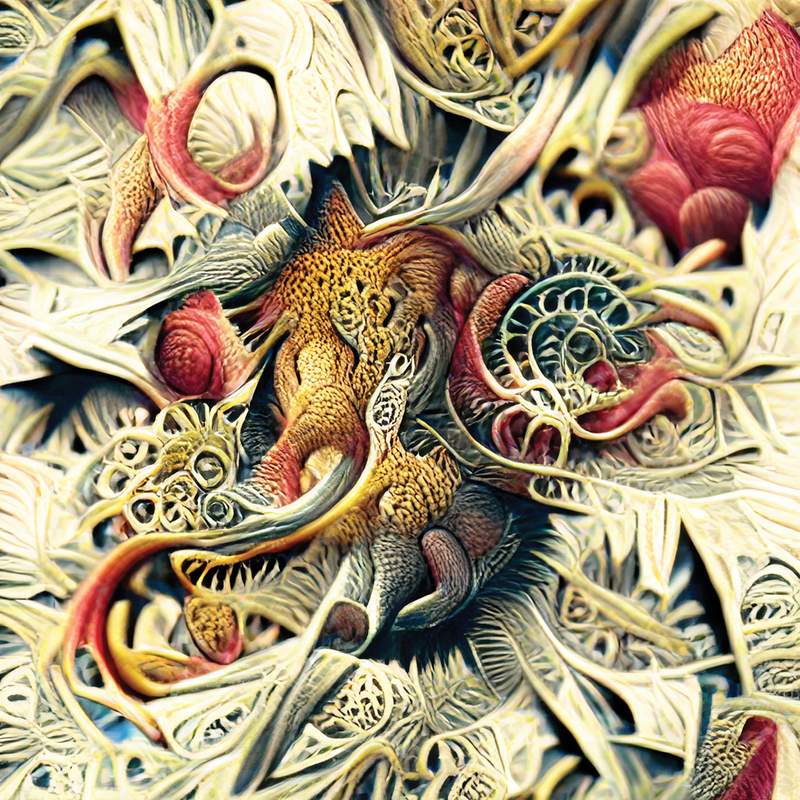
Altrettanto stupefacenti sono stati Bestiaries di Bekah Simms, testimonianza riuscita solo parzialmente di come il metal abbia oramai definitivamente eroso la barriera dell’impenetrabilità e si sia insidiato dappertutto nel mondo della musica, finanche alle composizioni orchestrali; Classic Objects di Jenny Hval, che oramai sta giocando a fare la Robert Ashley dei nostri tempi e devo dire che le riesce benissimo; Chance dei Société étrange, una rivitalizzazione della lezione dei This Heat che ha il grosso problema di suonare comunque più indietro nel tempo dei This Heat – ma d’altronde è difficile competere sul tempo con dei crononauti; 19 Masters di Saya Gray, che spero vivamente abbia nelle sue corde qualcosa di più succinto di questa intrigante manciata di acquerelli impressionisti a metà tra ambient e sussurri boschivi perché rischia di creare qualcosa di davvero bello. Se dovessi invece indicare due dei dischi più gustosi che abbia ascoltato negli ultimi dodici mesi, non avrei alcun dubbio nel puntare il dito verso Comradely Objects degli Horse Lords, che continuano nella loro esplorazione di geometrie impossibili aggiungendo pochi elementi, forse troppo pochi, a quel mammuth che era The Common Task, e Honk If You’re Sad degli Ebi Soda, fusion suonata in maniera competente, smargiassa e cazzona e che inizia a lasciare un retrogusto leggermente muffoso soltanto sulle battute finali. E poi il titolo mi fa davvero molto ridere.
Bon, quello che avevo da dire l’ho detto e mi sono tolto qualche sassolino dalle scarpe. Più sotto trovate la mia classifica, le menzioni d’onore e la playlist: ci vediamo nel 2023, che mentre scrivo sto già iniziando a trovare nuovi dischi pallosissimi. Certe cose non cambiano mai.
Classifica
- Richard Dawson – The Ruby Cord
- Congotronics International – Where’s the One?
- Eric Chenaux – Say Laura
- Soul Glo – Diaspora Problems
- Editrix – Editrix II: Editrix Goes to Hell
- Big Thief – Dragon New Warm Mountain I Believe in You
- Florent Ghys – Mosaïques / Ritournelles
- Imperial Triumphant – Spirit of Ecstasy
- Yonatan Gat – American Quartet
- Sélébéyone – Xaybu: The Unseen
- Extra Life – Secular Works, Vol. 2
- Denzel Curry – Melt My Eyez See Your Future
- Cécile McLorin Salvant – Ghost Song
- Nwando Ebizie – The Swan
- Kirk Knuffke Trio – Gravity Without Airs
- Show Me the Body – Trouble the Water
- Rhabdomantic Orchestra – Almagre
- Afrorack – The Afrorack
- Balungan – Kudu Bisa Kudu
- Kevin Morby – This Is a Photograph
Menzioni d’onore
- Black Flower – Magma
- Jean-Michel Blais – aubades
- Ebi Soda – Honk If You’re Sad
- Mabe Fratti – Se ve desde aquí
- Saya Gray – 19 Masters
- Marina Herlop – Pripyat
- Horsegirls – Visions of Modern Performance
- Horse Lords – Comradely Objects
- Jenny Hval – Classic Objects
- Keith Jarrett – Bordeaux Concert
- Jóhann Jóhannsson – Drone Mass
- Matmos – Regards / Ukłony dla Bogusław Schaeffer
- Makaya McCraven – In These Times
- Nancy Mounir – Nozhet el nofous
- The Pale Faced Family on the Hill & Oliver Coates – The Pale Faced Family on the Hill
- Sessa – Estrela acesa
- Bekah Simms – Bestiaries
- Société étrange – Chance
- Spiritualized – Everything Was Beautiful
- Whatever the Weather – Whatever the Weather





